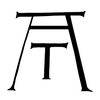Se il teatro fu dono di Brahmā, l’arte della danza fu regalata agli uomini da Śiva, che insegnò al suo devoto Tandu la possente danza di manifestazione e dissoluzione dell’universo che Egli ciclicamente eseguiva e che da quel momento fu nota come tāṇḍava. Tāṇḍu, a sua volta, la trasmise a Bharata e questi la diffuse fra gli uomini mentre Pārvatī, consorte di Śiva, aveva addestrato la principessa Uṣā ad eseguire l’aggraziata e sensuale lāsya. Tali eventi meritarono a Śiva il titolo di Naṭarāja, “Re della danza”.
La danza, nata in ambito rituale e originariamente eseguita all’interno dell’area sacrificale, trovò in seguito collocazione in appositi padiglioni del tempio, interpretata da una precisa categoria di esecutori ed esecutrici investiti di funzioni sacerdotali. La dura preparazione, la lunga esperienza e la particolare sensibilità permettevano all’artista di immedesimarsi con il personaggio interpretato, liberandosi dalla propria identità personale per acquisirne una universale. Di conseguenza ad essere espresse non erano le emozione individuali del singolo, ma quelle corali dell’umanità, trasposte nella dimensione mitica, al di là di ogni contingenza spazio-temporale. Lo spettacolo diventava così un evento cosmico, una sacra rappresentazione nella quale lo spettatore partecipava, entrando in sintonia con l’artista e provando sentimenti epurati da ogni soggettività. L’ego veniva in tal modo trasceso ed era con un livello di coscienza superiore che si fruiva il rasa: l’esperienza che ne scaturiva non era estetica, bensì spirituale e simile all’estasi mistica.
A eseguire le sacre coreografie furono centinaia e centinaia di fanciulle d’alto lignaggio, dedicate in tenera età dalle loro famiglie al servizio rituale nei templi. Non solo apprendevano la danza, ma ricevevano un’ottima educazione in discipline artistiche e altri campi del sapere che le rendeva di alta considerazione sociale. Ritenute spose del dio a cui erano dedicate e dunque depositarie del suo potere e della sua grazia, furono in alcuni casi protagoniste di riti erotici finalizzati a garantire la prosperità del regno. I grandi complessi templari dell’odierno stato del Tamilnadu ospitarono, a partire dal X sec. d.C., centinaia di queste fanciulle, chiamate devadāsī, “ancelle degli dei”.

Le vicende storiche che videro, prima ad opera dei musulmani e poi degli inglesi, la scomparsa delle grandi dinastie hindu che patrocinavano i templi, costrinsero le devadāsī ad esibirsi fuori dal complesso sacro e ad interpretare brani sempre più profani e lascivi. In molti casi si giunse addirittura alla prostituzione. Dell’antica e nobile tradizione non rimase che la forma esteriore, svuotata e snaturata della sua essenza. Le devadāsī, non più provenienti come all’origine da famiglie d’alto rango, ma ridotte a ballerine prezzolate, furono coperte di discredito e gli stessi indiani, imbevuti di cultura vittoriana, intrapresero alla fine dell’Ottocento una campagna per la soppressione delle danze nei templi. Fortunatamente un gruppo di personalità illuminate [1] decise a non permettere che una tradizione tanto gloriosa finisse nell’oblio, si batterono per restituirle la sua dignità.
Il recupero della danza tradizionale e la sua rivisitazione si devono in modo particolare a Rukmini Devi, appartenente ad una famiglia d’alto lignaggio brahmanico [2]. Attratta dalla danza, su suggerimento della famosa danzatrice russa Anna Pavlova, Rukmini si diede ad un’approfondita ricerca della tradizione indiana. Le fonti le vennero offerte dai testi e, soprattutto, dalle raffigurazioni sui templi, in modo particolare i bassorilievi sui portali di Chidambaram, che riproducono le 108 principali posizioni della danza, in modo tanto preciso da costituire un punto di riferimento fondamentale [3]. Nei bassorilievi, inoltre, le evoluzioni delle danzatrici sono frequentemente accompagnate da musicisti, i cui strumenti forniscono un interessante campionario per la storia della musica.
Studiando presso i maestri custodi delle antiche modalità coreutiche e osservando le varie devadāsī ancora operanti, Rukmini elaborò una forma di danza epurata dall’eccesso di sensualità e restituita al suo carattere sacro. La chiamò “bharata nāṭya”, ove nāṭya sta per “danza” e bharata è l’acronimo delle sillabe iniziali di bhava, “emozione”, rāga, “melodia”, tāla, “ritmo”, gli elementi portanti dell’evento scenico.

Per diffondere il bharata nāṭya Rukmini fondò alle porte di Madras il Kalakshetra, il “Campo dell’arte”, ove il contesto naturale, le strutture, lo stretto rapporto fra allievi e insegnanti rimandano all’antica tradizione educativa dell’āśrama [4]. Oggi a Kalakshetra, come in una serra, si coltivano piante speciali da trapiantare nella società per rinverdirla. L’arte non viene appresa come forma estetizzante fine a se stessa o come realizzazione narcisistica, bensì come strumento di esplorazione e conoscenza di sé e come ricerca del significato ulteriore della vita.
Benché attualmente le devadāsī siano scomparse e i templi non costituiscano più il palcoscenico delle loro rappresentazioni, artiste d’altissimo livello ne continuano la tradizione esibendosi nei teatri e in altri luoghi di cultura.
Articolata in danza espressiva e in danza pura – abhinaya, che “racconta” utilizzando un rigoroso vocabolario codificato di gesti, e nṛtta, nella quale l’esecutore estrinseca le proprie emozioni attraverso movimenti e coreografie più libere – bharata nāṭya rappresenta le vicende eroiche ed erotiche degli dei ed è una vera e propria preghiera in movimento. L’insegnamento è impartito sia da maestre che maestri, ma l’esecuzione é per lo più affidata a danzatrici che generalmente si esibiscono in “a solo”, drappeggiate in serici sāṛī, cinque metri di stoffa avvolta attorno alla vita e passata sopra la spalla, oggi spesso sostituiti da attillati pantaloni su cui si apre un ventaglio di pieghe. Il corpetto, la stola, numerosi gioielli, le cavigliere tintinnanti e un’acconciatura di fiori completano l’abbigliamento della danzatrice, il cui trucco elaborato serve a evidenziare l’espressione del viso e il mobile gioco degli occhi.
Ogni spettacolo inizia con l’invocazione a Shiva Naṭarāja, il “Signore della Danza”. Una voce maschile o femminile narra cantando l’evento mitico che viene mimato nei brani di danza espressiva mentre la scansione vocale di particolari sillabe ritma gli inserti di danza pura. Nelle tessiture musicali i danzatori inscrivono le gesta degli dei con le posizioni del corpo, la gestualità delle mani, il movimento degli occhi e del capo, sulle tracce del ritmo scandito dai piedi.
Anche nella danza per interpretare un personaggio bisogna svestirsi di sé, smettere gli “abiti” del quotidiano (il genere, i ruoli, le convinzioni ecc.) per lasciare emergere ciò che nel profondo c’è già: la dimensione variegata dell’essere umano, il macrocosmo nel microcosmo [5]. La tecnica libera l’artista dai movimenti convenzionali facendo piazza pulita di abitudini e schemi e mettendo a silenzio il modo “normale” di essere, per un altro esprimersi che non è alieno, ma extraordinario.

L’accompagnamento musicale è affidato al sitār – che ha sostituito un precedente strumento a corde, la vīṇā -, al flauto, al tamburo, ai cembali e all’armonio. L’ausilio della musica è fondamentale.
La musica indiana nasce come supporto alla recitazione degli inni agli dei, che andavano modulati secondo precise regole contenute nel “Sāmaveda”, il “Veda dei canti sacri”. Anche la musica aveva un’origine soprannaturale: era connessa al nāda, primordiale fremito proiettivo che aveva dato origine all’universo, secondo una delle tante teorie della genesi. Il nāda si era diversificato in ulteriori risonanze, le cui vibrazioni avevano “condensato” i vari stati della materia.
Eseguita in seguito anche fuori dall’ambito rituale, la musica era ed è costituita da tre elementi fondamentali: il tāla, “battito, scansione”, da intendersi soprattutto come “struttura”, ovvero spazio nel quale nascono e si sviluppano il ritmo e la melodia; il rāga, denominato dalla radice verbale rañj, “tingere”, e quindi da intendersi come coloritura emotiva ed effusione melodica; il rasa, “essenza” che scaturisce dal processo musicale e costituisce il godimento estetico [6]. I rāga, maschili, e le rāgiṇī, loro consorti femminili, sono raggruppati in famiglie, nonché associati alle stagioni, alle varie parti del giorno e della notte e agli stati d’animo. Anche l’improvvisazione, aspetto importantissimo della musica indiana, è regolata da norme precise, perché soltanto la disciplina aiuta a contenere e a intensificare la creatività che altrimenti rischia di disperdersi in un linguaggio astruso o, peggio, in arbitrio egocentrico.
M.A.
NOTE
[1] Tra cui il grande poeta Tagore.
[2] Era sposata a un occidentale e questo le rese più facile il compito. Dagli ambiti più conservatori fu comunque considerata in maniera negativa.
[3] Per le 108 posizioni descritte a Chidambaram vedi Carolina Guzman, “Sculture che danzano”, ed. Il Principe Costante.
[4] Negli āśrama, antichi eremi luoghi di istruzione, maestro e discepoli vivevano insieme e la trasmissione culturale avveniva per via diretta ed esperienziale.
[5] E’ lo stesso procedimento della scultura, che rimuove l’eccesso di materia per lasciare che la forma emerga.
[6] Vedi Paolo Pacciolla e Luisa Spagna: “La gioia e il potere. Musica e danza in India”, ed. Besa 2008
Pagine correlate
[menu_in_post_menu menu=58 style=”list”]