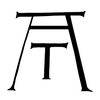I racconti più antichi vedono gli dei come protagonisti e la scena è per lo più il cielo, ma mano a mano che gli uomini prendono maggiore consapevolezza, entrano in scena a loro volta e nasce così l’epopea, che fa scendere gli dei sulla terra e salire gli uomini al cielo. Attingendo a un antichissimo patrimonio mitico che propone l’eterno conflitto fra le forze del bene e quelle del male, l’epica indiana mette in scena dei e demoni, ora incarnatisi sotto spoglie umane, ora procreatori di eroi. Ma gli eroi dell’epopea indiana spesso si dimenticano di essere figli di dei, ovvero rappresentanti di una volontà superiore [1]: la dimenticanza diviene metafora dell’ignoranza e l’intreccio degli eventi serve come strumento per recuperare la memoria di sé.
Il “Mahābhārata”, frutto di stratificazioni successive e composto in un lungo arco di tempo fra il IV sec. a.C. e il IV sec. d.C. – con un nucleo, sembra, ascrivibile addirittura al IX/VIII a.C. -, è costituito da 110.000 strofe divise in 18 libri, più un’appendice, l’Harivaṃśa. Benché frutto di diversi interventi, è tradizionalmente ascritto a Vyāsa, antenato comune delle due famiglie guerriere che si fronteggiano nel poema. Lungi dall’essere opera morta, è tutt’ora noto alla popolazione e continuamente riproposto [2].

Benché vi siano alcuni probabili echi storici – scontri fra Arii e popolazioni autoctone, conflitti fra tribù rivali, tensioni fra brāhmaṇa e kṣatriya, ovvero fra le due prime caste, quella sacerdotale e quella guerriera, – l’intento del poema è altro. Si tratta infatti di un itihāsa[3], una narrazione di eventi del passato che contengono insegnamenti sui quattro scopi della vita umana: il dharma, ovvero l’osservanza delle norme etiche e sociali; l’artha, cioè il conseguimento dei beni materiali; il kāma, il soddisfacimento dei piaceri; il mokṣa, la liberazione dall’esistenza condizionata e dolorosa.
Tuttavia, collocandosi gli accadimenti nella dimensione mitica, cioè fuori dal tempo, non sono “storia”, ma racconti paradigmatici che costituiscono un complesso d’istruzioni collettive, illuminate dai valori fondamentali della cultura che le ha prodotte. Ogni aspetto dell’esistenza viene esplorato e se ne espongono le modalità di reazione e di comportamento. I rapporti che intercorrono fra i vari strati della società – sovrano/cappellano, brāhmaṇa/kṣatriya, genitori/figli, uomo/donna – sono regolati minuziosamente. Quasi la metà del “Mahābhārata” è infatti didattica, per cui l’opera rappresenta il compendio per eccellenza dell’essere hindu.
Attraverso lo svolgimento dell’azione mitica viene spiegato all’uomo come deve comportarsi, poiché nulla è casuale sulla terra, ma sempre rientra in un ordine divino. Il racconto è un potente strumento didattico, capace di raccordare fra loro piani diversi attraverso quadri narrativi che si aprono gli uni dentro gli altri, secondo quell’espediente letterario del racconto cornice di cui l’India è stata la più antica maestra. Ogni evento s’inscrive dentro uno più ampio e il ripetersi delle situazioni piega il flusso lineare del tempo nel movimento circolare dell’eterno ritorno. Tutto si ripete nella concezione ciclica indiana che vede il mondo apparire, permanere, scomparire per poi di nuovo apparire, così come gli esseri nascono, crescono, muoiono e di nuovo rinascono. Eppure nulla è esattamente identico a ciò che è stato. Più ancora che il cerchio, è la spirale il simbolo dell’esistenza: quando il giro sta per chiudersi, si apre su un diverso livello. E il racconto stesso, che pur fedelmente trasmette senza azzardare giudizi o interpretazioni personali, per il fatto di essere recitato – e non letto – si rinnova e rigenera nelle intonazioni del narratore. Il narratore, che è un brāhmaṇa e quindi capace di leggere tra le maglie del profano il disegno del sacro, è il custode della memoria del popolo.

Le vicende del “Mahābhārata” si situano nel passaggio dallo Dvāparayuga al Kaliyuga [4], con la conseguente crisi che chiude un’era e ne apre un’altra. La Dea terra, oppressa da troppe presenze umane, molte delle quali demoniache, chiede agli dei di essere alleviata. E l’unico modo è la guerra. L’ultima terribile battaglia del poema è in effetti la grandiosa opera di un disegno provvidenziale, che insegna attraverso la sofferenza la liberazione spirituale e sublima l’eccidio in olocausto.
Dei e demoni si agitano non solo sul campo di battaglia, ma anche nel cuore dei protagonisti, dando vita a personaggi di grande spessore umano che soffrono nel dovere sottostare a un dharma che spesso appare ingiusto e che invano tentano di ribellarsi ad esso. Continui passaggi dal piano personale a quello trans-personale sottolineano la ricerca sofferta del senso della vita, che è nella vita stessa e al contempo al di là di essa, e che si coglie quando si scorge oltre il divenire la trama dell’Essere.
La storia
Tutto inizia nella selva Naimiṣa, un luogo mitico che simboleggia la memoria di un popolo, custodita e alimentata dallo straordinario mezzo del racconto. Un inclito consesso di brāhmaṇa si era raccolto nel folto della foresta per celebrare un rito che sarebbe durato dodici giorni divini, ovvero dodici anni umani. A sera giunge un ospite, un altro brāhmaṇa, Sauti Ugraśravas che, dopo essere stato accolto con i dovuti onori, inizia a raccontare quanto udito ad un altro grande sacrificio, condotto dal re Janamejaya figlio di Parikṣit, erede dei Pāṇḍava, eroi del “Mahābhārata”. Proprio durante questa celebrazione era stato recitato il “Mahābhārata” da Vaiśampāyana. Questi non ne era l’autore, ma a sua volta ne aveva appreso la storia dal suo maestro, Kṛṣṇa Dvaipāyana Vyāsa, che del “Mahābhārata” non era solo il compositore, ma anche uno dei principali protagonisti.
A generare Vyāsa era stata Satyavatī, splendida fanciulla scaturita da un pesce, unitasi ad un asceta. In seguito Satyavatī era andata sposa al re Śāntanu, dandogli due maschi, Vicitravīrya e Citrāṅgada, e per permettere che questi ereditassero il regno, Devavrata, precedente figlio di Śāntanu e della dea Gaṅgā, aveva fatto voto di celibato ed era stato denominato Bhīṣma, poiché aveva fatto un voto “terribile”. Citrāṅgada muore in combattimento senza avere avuto eredi. Bhīṣma ottiene come mogli per Vicitravīrya le tre principesse di Kāśī, Ambā, Ambikā e Ambālikā, ma Ambā – già promessasi al re Śālva – rifiuta il matrimonio. Tuttavia, respinta prima da Śālva e poi anche da Bhīṣma, giura di vendicarsi di quest’ultimo e si reincarna come Śikhaṇḍinī, figlia del re Drupada dei Pāñcāla, cambiando poi sesso per potere combattere.
Anche Vicitravīrya muore senza eredi e allora Satyavatī impone a Vyāsa di sposare le due cognate vedove per assicurare la continuità della stirpe regale, garantita non tanto dal sangue paterno, quanto da quello materno.
Nascono così da Ambikā il cieco Dhṛtarāṣṭra e da Ambālikā il “pallido” Pāṇḍu mentre da un’ancella Vyāsa ha Vidura. A Pāṇḍu, colpito da una maledizione, viene preclusa l’unione con le proprie mogli, pena la morte. Grazie comunque alla formula magica conosciuta da una delle sue due spose, Kuntī [5], vengono chiamati cinque dei che generano con le regine altrettanti figli, i Pāṇḍava. Da Kuntī unitasi con il dio Dharma, Signore della Giustizia, con Vāyu, divinità del vento e con Indra, re degli dei, nascono Yudhiṣṭhira, Bhīma e Arjuna mentre Mādrī, unitasi agli dei gemelli Aśvin, partorisce i gemelli Nakula e Sahadeva.
Ciò che Kuntī ha tenuto nascosto al marito è il fatto di avere provato già la formula e di avere avuto da Sūrya, il dio Sole, un figlio. Abbandonato alle acque e raccolto da un cocchiere, il bambino era stato chiamato Karṇa ed era cresciuto alla corte dei Kaurava, diventando il migliore amico del principe Duryodhana [6].
Pāṇḍu, non resistendo alla passione per la moglie più giovane, si unisce a lei, morendo subito dopo. La regina, involontaria responsabile della morte del consorte, s’immola sul rogo funebre di Pāṇḍu, affidando a Kuntī i propri due figli. Kuntī si rifugia con i cinque ragazzi alla corte dello zio di questi, Dhṛtarāṣṭra, che nel frattempo ha avuto dalla moglie Gāndhārī cento figli: i Kaurava. Fin da fanciulli fra i Pāṇḍava e i cugini Kaurava nasce una violenta inimicizia che né l’antenato comune Bhīṣma, né il valoroso precettore Droṇa riescono a sanare. I Kaurava tentano di bruciare i Pāṇḍava in una casa appositamente costruita e i cinque eroi e la madre, sfuggiti segretamente all’attentato, vengono ritenuti morti.
Rifugiatisi nelle selve, i Pāṇḍava vivono molteplici avventure: Bhīma s’innamora di una demonessa e ne ha un figlio, Ghaṭotkaca. Arjuna, incitato dallo stesso Vyāsa, partecipa allo svayavara, il torneo cavalleresco indetto dal re Drupada per maritare la figlia Draupadī. Qui Arjuna incontra Kṛṣṇa, cugino per parte di madre, e subito fra i due s’instaura un rapporto di profonda amicizia. Conquista la principessa vincendo la gara con l’arco, Arjuna conduce Draupadī a casa e Kuntī – prima ancora di avere visto di cosa si trattasse – impone di dividere quanto acquisito dal figlio con i fratelli. Così Draupadī diviene la moglie comune dei cinque Pāṇḍava, mentre Vyāsa, sopraggiunto, spiega la ragione di un matrimonio tanto insolito: i Pāṇḍava sono i “cinque Indra”, ovvero aspetti di un’unica divinità [7]. Il fratello di Draupadī, Dhṛṣṭadyumna, riconosce i Pāṇḍava, che vengono poi accolti con tutti gli onori alla reggia di Drupada.
Il matrimonio rivela al mondo che i Pāṇḍava sono vivi e i Kaurava meditano come distruggerli. Il loro padre, però, il re Dhṛtarāṣṭra, concede ai Pāṇḍava un’ampia porzione di regno ed essi vi fondano la splendida Indraprastha.
Arjuna, in volontario esilio per avere colto Yudhiṣṭhira in intimità con Draupadī, s’innamora di Subhadrā, sorella di Kṛṣṇa, e la sposa avendone il figlio Abhimanyu. Intanto Draupadī, a un anno di distanza ciascuno, ha dato alla luce cinque figli. I Pāṇḍava ingaggiano battaglie con demoni e sovrani ostili, acquisiscono armi divine e fanno edificare un palazzo splendido dall’architetto degli dei. L’odio dei Kaurava si intensifica e sfocia in una fraudolenta partita a dadi, ove i Pāṇḍava perdono ogni ricchezza, se stessi e perfino Draupadī, salvata dal disonore di essere pubblicamente spogliata da un intervento miracoloso di Kṛṣṇa. La partita viene annullata, ma poi ripetuta e i Pāṇḍava, di nuovo perdenti, sono costretti ad andare in esilio nella foresta per dodici anni e a restare in incognito per il tredicesimo.
In esilio vivono molteplici avventure. Kṛṣṇa rivela ad Arjuna che loro sono Nara e Nārāyaṇa, aspetti del dio Viṣṇu indissolubilmente uniti, mentre promette vendetta a Draupadī per l’insulto subito. Arjuna, ingaggiato combattimento con Śiva, ottiene dal dio altre armi divine e poi visita il padre Indra nei cieli, ove è maledetto dalla ninfa Urvaśī, respinta, ad essere eunuco per un anno. Nella selva molti visitano i Pāṇḍava e raccontano aneddoti edificanti e storie di grandi personaggi. I Pāṇḍava decidono quindi di intraprendere un pellegrinaggio che li porterà a visitare i giardini celesti e Bhīma incontra Hanuman, figlio anch’egli del dio Vāyu. Scongiurato un ratto di Draupadī, i Pāṇḍava trascorrono il tredicesimo anno sotto mentite spoglie alla corte del re dei Matsya, Virāṭa, che offre la propria figlia Uttarā ad Abhimanyu, figlio di Arjuna.
Finalmente giunge per i Pāṇḍava il momento di rivendicare la loro parte di regno: avendogliela i Kaurava negata, scoppia una guerra terribile e cruenta, che si dipana per diciotto giorni con enorme strage di eroi da ambo le parti. Kṛṣṇa, richiesto d’aiuto da Kaurava e Pāṇḍava, lascia loro la scelta fra se stesso e il suo esercito: i Kaurava optano per i soldati mentre i Pāṇḍava si garantiscono l’aiuto di Kṛṣṇa, che sceglie di fare da auriga al carro di Arjuna.
Alla vigilia della battaglia ha luogo fra i due il famoso dialogo che costituisce la “Bhagavadgītā”, la più importante opera spirituale hindu: in essa Kṛṣṇa dichiara che anche l’uomo d’azione può salvarsi, compiendo ciò che deve senza attaccamento [8].
La battaglia viene narrata al re cieco Dhṛtarāṣṭra dall’auriga Saṃjaya, che ha acquisito una vista divina. Nelle varie giornate si alternano eroismo e vigliaccheria, in una sanguinosa falcidia di eroi: l’ottavo giorno muore Irāvat, figlio di Arjuna e della nāgī [9] Ūlūpī. Nel decimo giorno Arjuna, nel tentativo di fermare la furia di Bhīṣma – che milita nel campo dei Kaurava, non per convinzione, ma per dovere – si fa scudo di Śikhaṇḍin per colpire il congiunto. Bhīṣma, infatti, ha dichiarato all’inizio della guerra che non combatterà contro Śikhaṇḍin, poiché sa che questi in effetti è Śikhaṇḍinī, la reincarnazione di Ambā, e dunque una donna. Nel tredicesimo giorno Abhimanyu, figlio di Arjuna, è ucciso a causa di Jayadratha, e questi, l’indomani, è a sua volta eliminato da Arjuna, grazie ad un inganno di Kṛṣṇa [10]. Ghaṭotkaca, figlio di Bhīma, è ucciso da Karṇa e Droṇa – l’invincibile maestro d’armi dei Kaurava – mena strage nelle file dei Pāṇḍava. Kṛṣṇa allora suggerisce un trucco: fa uccidere un elefante chiamato Aśvatthāman e ne proclama a gran voce la morte. Droṇa, indotto a credere da Yudhiṣṭhira che a essere ucciso sia stato proprio suo figlio, si lascia uccidere sua volta.
Nel diciassettesimo giorno ha luogo il duello fra Arjuna e Karṇa. Il guerriero aveva appreso da Kuntī di essere suo figlio e quindi fratello dei Pāṇḍava, ma non aveva voluto tradire Duryodhana che l’aveva accolto come un amico. Aveva comunque promesso alla madre che non avrebbe combattuto contro nessuno dei fratelli ad eccezione di Arjuna, in modo che Kuntī potesse comunque avere sempre cinque figli vivi. Spogliato con un trucco delle protezioni garantitegli dal padre, il dio Sole, Karṇa è ucciso in maniera sleale da Arjuna istigato da Kṛṣṇa. Nel diciottesimo e ultimo giorno di battaglia i Kaurava vengono sconfitti e Duryodhana, rifugiatosi in un lago, viene massacrato da Bhīma con un colpo di clava non ammesso dal codice cavalleresco. Duryodhana muore rimproverando a Kṛṣṇa le scorrettezze e gli inganni compiuti.
Durante la notte, mentre nel campo avverso i nemici sono immersi in un sonno profondo, Aśvatthāman invasato da Śiva, uccide tutti, anche i figli dei Pāṇḍava e il nascituro nel grembo di Uttarā, moglie di Abhimanyu. Si salvano solo i cinque fratelli e Kṛṣṇa, che non erano al campo. Durante tutto questo periodo Bhīṣma rimane in vita su un giaciglio di frecce, dettando i precetti del buon governo e del vivere etico. Avendo ritenuto compiuto il suo tempo, decide di morire, riaccolto dalla madre Gaṅgā.
Kṛṣṇa resuscita il bimbo dato alla luce morto da Uttarā e il piccolo erede dei Pāṇḍava viene chiamato Parikṣit. Ma Kṛṣṇa stesso, a causa di una maledizione di Gāndhārī, la madre dei Kaurava, viene ucciso durante una rivolta nella sua città di Dvārakā da una freccia che lo colpisce nell’unico punto vulnerabile, il tallone.
Dopo un lungo regno giusto e pacifico, Dhṛtarāṣṭra, Gāndhārī, Kuntī, Saṃjaya e Vidura si ritirano e muoiono nelle selve, mentre i cinque fratelli lasciano il trono a Parikṣit e con la sposa comune Draupadī intraprendono un pellegrinaggio sull’Himalaya. Caduti a uno a uno sull’ardua via, rimangono Yudhiṣṭhira e il suo cane – che altri non è che il suo stesso padre, il dio Dharma. Entrato in cielo, Yudhiṣṭhira non vi trova i fratelli e la moglie, ma i Kaurava. Sconvolto, chiede di raggiungere i congiunti e si ritrova all’inferno. E’ questa l’ultima prova, imposta a Yudhiṣṭhira in espiazione della menzogna detta a Droṇa, e finalmente i Pāṇḍava raggiungono il cielo e vi godono la gloria eterna.
M.A.

NOTE
[1] Perfino gli dei dimenticano chi essi siano, come accade – vedremo – nel “Rāmāyaṇa”.
[2] Una delle rappresentazioni più famose è stata la serie televisiva di 93 episodi, che dall’ottobre 1988 al luglio 1990 è stata vista da centinaia di milioni di persone.
[3] Il termine sanscrito, che significa letteralmente: “Così fu davvero”, viene tradotto come “Storia”, con un’accezione del vocabolo diversa da quella occidentale.
[4] Secondo la concezione hindu, il mondo attraversa quattro yuga, epoche cosmiche, che vanno sempre più corrompendosi. La prima, il Satyayuga, è perfetta; la seconda, Tretāyuga, mostra già l’inizio della corruzione che si fa più evidente nello Dvāparayuga per degenerare completamente nell’ultima era, il Kaliyuga, iniziato nel 3102 a.C. con la morte di Kṛṣṇa, che si concluderà con la fine del mondo.
[5] Chiamata anche Pṛthā.
[6] Vedi oltre.
[7] Secondo una versione più popolare, in una vita precedente Draupadī aveva chiesto agli dei per ben cinque volte un marito e questi l’avevano accontentata…
[8] Sulla “Bhagavadgītā” vedi oltre la scheda di riferimento.
[9] ] I nāga e le nāgī sono semidivinità maschili e femminili in parte serpentiformi.
[10] I comportamenti poco cavallereschi e gli stratagemmi truffaldini messi in atto da Kṛṣṇa, che è avatāra, ovvero discesa sulla terra del dio Viṣṇu, vengono spiegati con l’essere ormai nel Kaliyuga, l’era degenerata, e con l’adeguarsi del dio alle dure necessità della guerra, che comunque deve essere vinta dai Pāṇḍava.
Pagine correlate
[menu_in_post_menu menu=58 style=”list”]