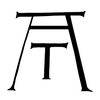Somiglianze fra il Kojiki e il panorama cosmogonico classico
di Federico Filippo Fagotto
In un recente studio sulla cultura giapponese, il prof. Hisayasu Nakagawa ha tentato di dare vita ad un’«antropologia reciproca» [1] fra il suo mondo e alcuni dei costumi occidentali. Ha dovuto perciò indovinare, in poco più di un centinaio di pagine, i paragoni più acconci affinché alle peculiarità della sua tradizione riuscisse di catturare l’attenzione dell’occhio sul chiaroscuro del confronto. Ha particolare successo l’idea secondo cui la società nipponica tende spesso a fornire una «verità senza soggetto», non soltanto nel groviglio della sua impalcatura linguistica, ma anche al momento di rendere conto della consistenza di alcuni dei fatti che hanno avuto luogo. Nei confronti di essi, per l’appunto, il pubblico occidentale tradirebbe una maggiore ansia e brama di ricondurre il dato evento ad un determinato autore.
Senza cincischiare con esempi di contorno, l’emerito docente dell’Università di Kyōto fa subito riferimento al nostro modello di soggetto agente. Il «Sia la luce!» delle Sacre Scritture non può che ricordarsi come «il risultato di un atto di volontà» [2] compiuto da Elohim. Al contrario, egli cita un articolo di Masao Maruyama secondo cui in Giappone «nessun evento storico viene spiegato come prodotto di volontà particolari» [3], perché si preferisce pensare ad una successione di forze che vengono in essere per se stesse. L’esempio che Nakagawa decide di addurre è troppo grande per lo spazio che può dargli, come avviene per alcune fiere in cattività. Egli infatti chiama in causa il Kojiki, le antiche cronache giapponesi, il cui abbrivio – capace di descrivere la creazione senza ricorrere al divino fautore – tanto si distanzia da ciò che contiene invece il libro della Genesi. Qui egli ravvisa la «proposizione europea in cui un soggetto afferma una verità», mentre nella prima opera quella proposizione «in cui la verità appare in maniera spontanea e naturale» [4].

Il confronto, tuttavia, è un ospite cui sarebbe sgarbato offrire solo la prima portata. Una volta scomodato, va trattato con i dovuti riguardi sino in fondo. Per conoscere meglio il Kojiki, va quindi ricordato ch’esso venne compilato sul finire del periodo Hakuhō (673-686 d.C.) ed ultimato nel 712 d.C. per volere dell’imperatrice Genmei, che ordinò al nobile Yasumaro di mettere ordine negli annali di corte. Questi, sfruttando le ricerche compiute pochi anni prima da Are – cortigiano che ricevette dal precedente sovrano, Tenmu, il medesimo compito – creò un’opera che avvicina la storia e il mito per tracciare una linea di sangue fra le antiche divinità e l’attuale stirpe imperiale, in un frangente in cui, con lo spostamento della capitale a Heijō e l’inizio dell’epoca Nara, era necessario rispolverare il valore dell’autorità. Prima di soffermarsi sulla sacra discendenza, tuttavia, il Kojiki indugia nel primo capitolo sulla nascita dell’universo e la comparsa dei primi esseri divini. Già ad una prima lettura, il fascino delle somiglianze che si risveglia fa capire che non ci si trova certo ai margini del panorama cosmogonico classico, come si era invece detto pocanzi. L’inizio infatti recita:
Ci fu un tempo confuso in cui qualcosa iniziò a prendere una consistenza, ma ancora così indistinta, anonima, e inerte, che nessuno potrebbe descriverla [5].
L’assenza dell’artefice ha di sicuro il suo peso, ma l’enfasi che il racconto sceglie per il suo abbrivio insiste piuttosto sulla caoticità ai primordi del divenire. Allo stesso modo, anche il Genesi ha l’immediata urgenza, già nel secondo versetto, di descrivere il creato come «una massa senza forma e vuota» [6], usando all’incirca gli stessi aggettivi di cui si serve il Kojiki, cui si aggiunge logicamente anche l’inerzia prima dell’intervento divino sull’atto iniziale. Gli stessi tre connotati vengono eletti anche dai Ṛg Veda, ai fini della poetica descrizione degli albori dell’essere. L’universo è qui visto come un’«acqua indistinta», in cui il «germe dell’esistenza» è «avvolto dal nulla». Anche l’immobilità è sottintesa fintanto che non sarà il «desiderio» a fecondare la mente, principiando i fenomeni [7].L’intera scena è poi resa sintetica da Esiodo nella Teogonia dove, dopo l’invocazione alle Muse e un «dunque» che suona come un colpo di tosse che apre la vera prolusione, si limita a dire: «per primo fu il Caos» [8].
Poi il cielo e la terra si cominciarono a separare [9].
Questa è la seconda informazione che ci regala il Kojiki. È curioso che anche il primo versetto di tutta la Bibbia, per descrivere il Creato, si serve non di un termine unico ma proprio della distinzione tra «il cielo e la terra» [10]. Il Dio là descritto, infatti, sembra avere a cuore che «vi sia fra le acque un firmamento, il quale separi le acque superiori da quelle inferiori» [11], perché la somiglianza anche soltanto cromatica fra cielo e mare – di cui la terra è per lo più composta – rischia di regredire nell’indistinto iniziale da cui si è invece preso le mosse. La stessa premura appartiene al Kojiki e ad altri grandi racconti cosmogonici. Quando nell’Edda – il principale riferimento della mitologia norrena – ci si chiede ad esempio cosa abbia compiuto di grande il sommo dio Allfödhr, la prima risposta è: «Egli forgiò cielo e terra» [12]. Che al di là del miracolo creativo, la gloria di tal gesto consista proprio nell’importanza della separazione, viene riconfermato dal ruolo che Allfödhr spesso riveste di guardiano della distinzione fra gli enti. Sarà lui a mettere ordine fra i pericolosi figli di Loki, incatenando il lupo Fenrir, scagliando il serpente Midhgardhr nel mare profondo e spedendo Hel, la dea degli inferi, nel Niflheimr, il regno dei ghiacci, lasciandole in più il compito di dividere le varie dimore dei nove mondi. Anche nei Ṛg Veda la nascita dei due elementi è frutto di una separazione, nella fattispecie delle membra del Puruṣa, poiché «dalla testa si produsse il cielo, dai piedi la terra» [13]. Questi diventano a loro volta delle divinità coi nomi di Dyaus e Pṛthivī e vengono immaginati come due enormi coppe rovesciate l’una sull’altra. Sceverare fra gli enti significa quindi creare nuovi poteri divini e ruoli cosmologici. Questo fu allora anche uno dei principali obiettivi dell’opera di Esiodo, il cui merito, agli occhi di Erodoto, fu descrivere le divinità «distinguendo le loro prerogative e le competenze» [14]. Di qui lo stesso valore storiografico cui punta il Kojiki e che, ai nostri occhi, somiglia ad alcune opere ibride come l’Ad urbe condita, dove il passaggio fra storia e mito – in particolare alla morte di Romolo – coincide con il momento in cui i senatori e le decurie «si dividono il potere» [15] iniziando a conferire allo Stato romano la sua forma politica peculiare.
Seguendo l’incipit del Kojiki, vediamo che dopo terra e cielo anche «il sole e la luna spuntarono» [16], con chiaro riferimento all’avvento della luce che rischiara il buio primordiale. «Le primissime origini – ammette Yasumaro – rimangono dunque oscure» [17]. La stessa dinamica, arcinota, si legge nel testo giudaico-cristiano. Prima del fiat lux, infatti, è detto chiaramente che «le tenebre ricoprivano l’abisso» [18], e poco più in là ecco sorgere gli stessi astri, il «luminare maggiore» e quello «minore» [19], che svolgono in più l’incombenza di «distinguere le stagioni, i giorni e gli anni» [20], regolando il tempo con l’ennesima scansione. Grazie a ciò, anche l’elemento umbratile viene trasformato ed accettato nel cosmo come trapasso meridiano. Quando infatti Dio «separò la luce dalle tenebre» [21], chiamò la prima «giorno» e la seconda «notte» [22], distinguendola dalle tenebre stesse. Analogamente, anche nel Kojiki il sole e la luna, e con essi giorno e notte, scoprono i loro ruoli solo abbandonando entrambi il «regno invisibile» [23], ossia l’oscurità del regno dei morti. Esiodo addirittura decide di incarnare i due principi umbratili in diverse divinità, Έρεβός e Νύξ, i quali unendosi danno vita ad Ήμέρη, il Giorno. La dinamica ritorna poi nei Ṛg Veda, in cui si dice che «in principio vi era solo tenebra nascosta dalla tenebra» [24], poi una di queste cominciò ad acquisire identità trasformandosi nella Notte, sino a meritarsi un inno a lei dedicato (x, 127) perché «con i suoi numerosi occhi», cioè le stelle, fu capace addirittura di cacciare lei stessa le tenebre portando le luci, lì descritte come delle «bellezze» [25]. Il fascino estetico è infine dichiarato anche nell’Edda, dove la scura Nótt, figlia di Nörfi, va in sposa a Dellingr, della stirpe degli Asi, generando Dagr, il Giorno, presentato come «luminoso e bello» [26].
A questo punto, l’autore delle cronache giapponesi fa una serie di digressioni spiegando i motivi della compilazione dell’opera, lodando il suo signore ed accennando anche agli interessanti problemi di natura linguistica da lui affrontati. Quando riprende con la narrazione, parla dei primi esseri che vennero al mondo. Come fossero frutto dello stesso parto, i «tre esseri misteriosi» [27] sembrano emergere all’unisono. Takamimushi, Kamumushi e Amenominakanushi non possono che far pensare al tema della Trinità, di cui ci sono tracce veterotestamentarie già nel Genesi, in particolare quando ad Abramo compare Dio sottoforma di «tre uomini» [28], di cui però è uno soltanto a parlare. Similmente, i primi esseri divini del Kojiki vengono descritti come «solitari, invisibili» [29], anche se l’interpretazione del passo è ardua. Un’altra versione opta per una resa più prosaica: «ebbero origine come dei unici, e nascosero il loro corpo» [30], vale a dire che ognuno di loro contava come un dio onnipotente. Ciò avvicina tale panorama mitico al concetto di «catenoteismo» di Max Müller, secondo cui l’esistenza di una divinità che comanda a turno permette anche al politeismo di assumere, in alcuni contesti, le funzioni di un monismo. Secondo il filosofo orientalista tedesco, proprio le saghe nordiche e quelle vediche ne sono esempi fecondi. Nella prima, la figura di Ódhinn assume varie forme ed epiteti, di cui tre sono appunto i principali: Hár, che siede sul seggio più basso, Iafnhár e Thridhi, che invece è assiso su quello superiore. Il suo corrispettivo indiano è di certo Viṣṇu che, nonostante i numerosi Avatāra, è così descritto nell’inno a lui dedicato (I, 154): «essendo uno, sostiene in maniera triplice cielo e terra e tutte le creature» [31]. Il «catenoteismo» greco si sviluppa invece su base cronologica, nel corso della dinastia che da Urano, passando per Crono, elegge Zeus padrone dell’Olimpo. In senso analogo, anche la posizione predominante dei tre numi giapponesi trova nell’inizio della discendenza divina la propria funzione. La dinamica, però, con cui essa prende piede è particolarmente interessante.
Da creature simili a germi di giunco gemmarono gli esseri misteriosi [32].
Si immaginano qui i primi esseri come dei semi da cui l’inizio delle generazioni divine, e poi umane, si sviluppano come per gemmazione. Sembrerebbe prerogativa di una religione che non può richiamarsi ad una causa esterna per spiegare la fonte dei fenomeni, così come vorrebbe Nakagawa. Eppure, anche nel Pentateuco scorgiamo un Dio che si preoccupa di fornire alla sua creazione un’autonomia dinamica – donde le speculazioni successive sulla metafora dell’orologiaio – e che agisce su piante e frutti affinché «abbiano in sé la propria semenza» [33] e a loro volta servano a sostentare la razza umana. In entrambe le prospettive, nonostante il differente retroterra teologico, si gioca allora un sottile scambio fra il potere esterno e l’energia interna. È curioso notare che è proprio da un altro dubbio di questo tipo che si giustifica l’intera narrazione dell’Edda. Il re Gylfi, infatti, sovrano di Svezia, pensando alla sapienza e nobiltà del popolo degli Asi, «meditò se questo potesse derivare dalla loro propria natura oppure dalla potenza degli dèi cui essi sacrificavano» [34]. Per soddisfare il cruccio si mette allora in cammino verso Ásgardhr. Tra i vari quesiti che verranno posti, anche qui il passaggio dal mondo naturale all’essere umano sarà chiarificatore sul rapporto fra la matrice interiore e l’apporto divino. Si dice infatti che quando i figli di Borr trovarono due alberi il primo conferì loro «anima e vita», il secondo «intelletto e movimento», l’ultimo «parola e udito e vista» [35], creando l’uomo. Con un tocco finale, attribuirono loro anche dei nomi e, con essi, un sesso: lui diventa Askr e lei Embla.

Anche nel Kojiki la catena comincia con le prime germinazioni di cui detto e, trascorse le prime successioni divine, arriva infine a nominare due grandi divinità: Izanaki (o Izanagi) e Izanami. Con loro appare ciò che si era profetizzato all’inizio: «la distinzione fra femmina e maschio» [36]. I due principi si sono esternati e presto cominceranno il rapporto di posizioni che anche i Ṛg Veda previdero all’origine di tutto sottoforma di simbolo sessuale: «sotto vi fu l’energia, sopra vi fu l’impulso» [37]. Che il ruolo di Izanaki e Izanami costringa quindi a condursi sulle tracce di un paragone con Adamo ed Eva lo si deve ad alcune curiose analogie. Anzitutto il fatto che l’avvento dei due kami, gli dèi shintoisti, cade esattamente sette generazioni dopo la comparsa dei primi tre esseri misteriosi. Dopo lo stesso numero di giorni, come si sa, anche il Dio del Genesi decise che con la creazione dei primi uomini la sua opera poteva considerarsi finita. Quello che sarà il valore sacrale di tale numerologia tradisce subito i suoi futuri intenti, ripetendosi più volte già nei primi capitoli. Sette saranno le volte in cui, nelle parole di Lamec, verrà vendicato Caino. Lui invece, suo discendente e figlio di Matusael, si riserva di essere vendicato «settanta volte sette» [38], frase che poi ripeterà il Cristo a S. Pietro. Il sette è poi l’asse del rapporto fra Dio e il figlio di Lamec: Noè. Sette sono le paia di ogni specie pura di animale che gli ordina di salvare dopo che, di lì a sette giorni, si verificherà il Diluvio, finito il quale il patriarca ne aspetterà altrettanti prima di uscire dall’Arca. Nei Ṛg Veda la dinamica segue le medesime tappe. Indra, nume supremo, decide di concludere il travaglio di emersione dal Caos chiamando a sé Agni, dio del fuoco, per istituire il sacrificio rituale che passa traverso «sette esecuzioni» [39]. Nei panni di Bṛhaspati, divinità cui è spesso associato, contribuisce poi al volere cosmetico con gli stessi atti del Dio cristiano: si serve della luce, con cui disperde le tenebre grazie a sette raggi – lo stesso carro del sole verrà poi scortato da «sette cavalle baie» [40] – e dello pneuma, grazie alle sette bocche con cui intona i canti. Anche l’elemento acquatico del Diluvio torna qui in compagnia del simbolo numerico, sottoforma dei sette fiumi che davano addirittura il nome alla regione indiana, il Sapta Sindhu, un tempo abitata dagli Arii. Sarà ancora Indra a liberarli uccidendo il serpente Vṛtra. Infine, anche nell’Edda all’inizio della vicenda si incontra Gangleri che, davanti alle porte del Valhöll, fa roteare dei pugnali «in modo tale che ve n’erano sempre sette contemporaneamente in aria» [41]. Appare qui l’immagine stessa del numero come simbolo della chiusura del cerchio e conclusione del ciclo, sia che esso consista nelle prime generazioni divine, come nel Kojiki, nel tempo impiegato per dar vita al creato o anche solo per fondare le basi di un grande impero, come quello romano, nell’arco di sette monarchi e nel luogo di altrettanti colli.
La seconda analogia riguarda il patto che i primi esseri stringono con Izanaki e Izanami, ordinando loro di «consolidare le terre alla deriva» [42] e seguendoli nel rituale di accoppiamento con cui daranno vita alle future generazioni, da cui discende quella imperiale. Anche il patto stretto con Noè, dopo la sua opera di salvaguardia degli esseri viventi, è volto a garantire la sopravvivenza della specie umana. Protraendosi poi nel patto concesso ad Abramo, finisce con il rivolgersi in particolare al popolo eletto. A Izanaki e Izanami spetta adesso un vero e proprio atto creativo. La lancia donata loro dagli dèi viene fatta roteare, la punta caglia una «salsedine gorgogliante» da cui colano dei «grumi di sale» [43] che, gocciolando sui mari, danno vita alle sacre isole dell’arcipelago nipponico. In questa magica descrizione si annida uno stupefacente archetipo se si pensa all’isolazionismo culturale in cui il Giappone ha vissuto per buona parte della sua storia. Si prendano i Ṛg Veda, dove la nascita degli esseri viventi si deve al «burro coagulato» [44] che sgorga dal sacrificio del Puruṣa supremo alle origini del Cosmo. Andando più distanti, la somiglianza aumenta poi paradossalmente. Nell’Edda, per spiegare l’esistenza della schiatta umana si parla delle acque di Élivágar da cui monta una schiuma che indurendosi diviene ghiaccio il quale, espandendosi, entra in contatto con l’aria calda sciogliendosi e gocciolando. «In quelle gocce sorse la vita» si dice «e si formò una figura d’uomo» [45]. L’anima di cui verrà dotato «vivrà e mai perirà», mentre il corpo di dissolverà in «polvere» [46]. Si torna così al Genesi in cui, come si sa, «il Signore Iddio formò l’uomo dalla polvere della terra» [47], dandogli nome Adamo da ‘Ādam’ (ebr. אָדָם) = «uomo terroso». Come sarà per lui l’Eden, anche i due kami scelgono una bella dimora ove risiedere, piantandovi una «magnifica colonna» [48] che ricorda sia l’Albero della Vita che il frassino di Yggdrasill che, nell’Edda,viene visto come «l’albero del mondo e della vita» [49], e che in tempi recenti Schröder, ispirandosi ai simboli della Scienza sacra di René Guénon, ha identificato proprio in una colonna [50].
A questo punto avviene l’unione profonda fra Izanaki ed Izanami nel segno della carne. Essa è un incontro. Izanaki chiede con curiosità: «come è il tuo corpo?» [51] e lei risponde che sarebbe perfetto se non avesse una parte incompiuta poiché non chiusa. Egli realizza allora che ciò di cui lui è invece in esubero potrebbe colmare questa imperfezione. Al contrario, Eva è frutto di un’emersione carnale dalla costola di Adamo, quindi a latere, per sottolineare che non gli è né subordinata né preferita, bensì scelta come compagna ideale per ricreare «una sola carne» [52]. La nascita per endogenesi dal fianco ricorda il mito della nascita del Buddha, fuoriuscito dal fianco della madre Maya senza arrecarle dolore. Tra i due esempi c’è però un’inversione delle parti fra maschio e femmina. Con essa sembrano divertirsi anche i Ṛg Veda nel parlare di Virāj, il principio femminile, che si origina dal maschio Puruṣa, generandolo però a sua volta: «da lui nacque Virāj, da Virāj Puruṣa» [53]. Che la colonna eretta dai numi giapponesi sia implicata nella celebrazione della vita lo si deve all’uso che ne fanno nel rito di accoppiamento. Si pongono a contatto con la colonna ruotando in due sensi opposti finché, raggiungendosi, lui esclama «che bella ragazza!» e viceversa deve fare Izanami. Ella però commette l’errore di parlare per prima e, a causa di ciò, il loro primo figlio nascerà deforme. Emerge così, come nelle Sacre Scritture, il fatto che alla donna si imputano gli errori. Adamo, per scusarsi del proprio peccato agli occhi di Dio, incolperà la donna di averlo tentato. Un simile trasferimento di colpe lo delinea Tito Livio parlando della malvagità di Tullia, che spingerà Tarquinio ad uccidere Servio Tullio, padre di lei, e ad usurparne il trono. Anche in quel caso «l’inizio di tutto lo sconvolgimento venne dalla donna» [54]. Altrettanto lapidari sono, in merito, i Ṛg Veda, nel dire: «non esistono amicizie con le donne: di iena sono i loro cuori!» [55]. Il fatto che da Izanami nasca il primo essere imperfetto dopo generazioni di grandi divinità, significa che con la donna avviene la fine dell’età dell’oro. Infatti, solo a partire da adesso cominceranno a comparire accadimenti negativi. «La cosiddetta età dell’oro – si legge anche nell’Edda – venne poi rovinata dall’arrivo delle donne» [56]. Lo stesso destino lo incontrano i popoli greci descritti nella Teogonia, stavolta per volere di Zeus che, per vendicarsi delle furberie di Prometeo, fa forgiare dalla terra una «vergine vereconda», ornata di veli e gioielli. Da lei proviene «la stirpe nefasta e la razza delle donne, che, sciagura grande per i mortali, fra gli uomini hanno dimora» [57].
Nell’ultimo verso dell’opera si accenna però ad una rivalutazione, poiché il poeta invoca di nuovo le Muse e chiede: «ora cantate la stirpe delle donne» [58]. Sarà nel finale, infatti, a venir presentato Tifeo, l’ultimo dei figli di Gaia unitasi a Tartaro, descritto come un essere deforme e terribile, come il figlio di Izanami, che sembra destinato a rovesciare il trono di Zeus. Questi riesce però a sconfiggerlo. In seguito, quando dovrà venire alla luce qualcun altro eletto a subentrare al Cronide, cioè Atena, Zeus si premonirà in maniera diversa dai predecessori: la incuberà lui stesso. La donna viene così “maschilizzata” e svezzata in modo simile ad Eva, per garantire la discendenza. Sempre nel Genesi troviamo un’altra eco della dinamica scorta nel Kojiki. Prima che l’unione fra David e Betsabea – che significa «settima figlia» – generi Salomone, il prosecutore del regno d’Israele, Dio decide di punire la loro relazione illecita facendo nascere loro un figlio che morrà sette giorni dopo il parto. Allo stesso modo, Izanaki e Izanami, dopo aver abbandonato la sfortunata creatura nella corrente, svolgono nuovamente il rito, stavolta senza errori, procreando le altre isole del Giappone e una ricca serie di esseri sacri che costituiranno il “Pantheon” dello Shintoismo, incarnando gli elementi naturali. Tra questi, particolarmente importanti saranno i signori delle porte d’acqua, i principi Hayākitsu, per il loro ruolo di «tenere separati fiumi e mari», simile a quello di Kukonochi, signore dei monti, e Ohyomatsumi, signora dei campi, di «tenere separati monti e campi» [59]. La necessità di distinzione ontologica viene così ultimata con un atto identico a quello svolto da Indra, che arresta le montagne e puntella il cielo, e Bṛhaspati che fece lo stesso con le estremità della terra «perché rimanessero separate» [60].
Infine, Izanami sgrava Yagihayako, kami del fuoco che, nascendo, brucerà la vulva della madre causandone la triste morte. La disperazione di Izanaki non avrà requie, tanto che risolve di seguire i passi dell’amata «nella terra delle acque ocra» [61], ossia negli inferi. Siamo ormai certi dell’appartenenza di questo testo al panorama cosmogonico classico. La catabasi, la discesa nell’al di là, è infatti il grande topos che accomuna il patrimonio mitologico. Dagli esempi preclari di Odissea ed Eneide, la ritroviamo anche nell’Edda, laddove Hermódhr decide di andare nel regno di Hel per riprendere Baldr, il più bello degli dèi, morto per un inganno di Loki. Come se non bastasse, anche nel Kojiki compare il tropo del divieto, quello imposto ad Izanaki di non guardare la sua consorte finché il signore dell’oltretomba non si sia deciso a restituirgliela, cosa che ovviamente non farà. La somiglianza col mito di Orfeo ed Euridice è certo marcata e in generale colpisce l’attribuzione del tabù all’organo della vista, come nel veto imposto a Psiche di non guardare Amore durante i loro incontri, come l’obbligo ingiunto a Skadhi nell’Edda di scegliere un marito fra gli Asi senza guardarlo in volto, o come l’ammonizione di Dio a Lot di non voltarsi indietro durante la fuga da Sodoma e Gomorra in procinto di essere distrutte, cosa cui sua moglie disubbidirà, venendo tosto tramutata in una colonna di sale. Nel racconto dell’interdizione ad Izanaki c’è poi un elemento che lo fa essere molto simile all’inno vedico che parla di Urvaśī e Purūravas. Questi doveva giacere con la ninfa tre volte al giorno, senza però farsi vedere nudo da lei, cosa che un giorno purtroppo succede a causa di un inganno perpetrato dai Gandharva. Anche nell’infrazione di Izanaki il malus è che scorge la dèa sotto le sue vere spoglie. È quindi singolare che non sarà il sovrano degli inferi ad adirarsi, ma la stessa Izanami, che griderà: «umiliata, mi hai umiliata!» [62], portando così acqua al mulino di Ruth Benedict e alla sua teoria secondo cui i popoli orientali sono tuttora dei promotori dell’antica «società della vergogna» [63]. Non si può tuttavia fare a meno di notare cosa accade nel Genesi non appena si contravviene alla proibizione divina. Nell’istante in cui i due peccatori assaggiarono il frutto:
Si aprirono allora gli occhi di tutt’e due e s’avvidero che erano nudi [64].
Dacché «erano tutt’e due ignudi, ma non ne avevano vergogna» [65], si instilla in loro il senso della pudicizia e solo allora decidono di coprirsi con le foglie di fico. Solo da questo momento, infatti, la sozzura del loro animo è in contraddizione con il candore del loro aspetto. Anche nella saga nordica Loki viene descritto come «bello e gradevole nella figura, malvagio nell’animo», e infatti di lui si dice che è «la vergogna degli dei» [66]. Lo stesso avviene durante la descrizione della nascita di Indra, tanto che «la madre lo nascose, come se lo ritenesse una vergogna». Ma lui seppe levarsi in alto «indossando la veste sua propria» [67], cioè quella dell’eroe, che di molto si differenzia dal costume assunto da Adamo. L’apice di quest’indipendenza invereconda si avrà allora con Uṣas, la dèa dell’Aurora, che compare da Oriente al mattino mostrando il seno e scoprendo «le sue parti più amabili» [68].

Una volta che Izanaki riesce a sfuggire alla furia della defunta compagna si arriva all’epilogo non solo della vicenda, ma dell’intera parabola cominciata all’inizio del racconto e che conclude la prima era mitica del mondo. Izanami, fuori di sé, giura di soffocare ogni giorno a morte «mille della folta siepe di uomini», ma sarà vano poiché il dio promette che ogni giorno, per suo volere, sorgeranno «millecinquecento capanne per il parto» [69]. In realtà la compensazione ha come effetto un rinnovamento della razza umana, similmente a come avviene per il diluvio universale. È ricorrente infatti nel racconto cosmogonico l’incrocio di un momento di profonda rinnovazione che passa attraverso uno sterminio emendatore. Quello che fece il Dio biblico allorché vide «che la malvagità degli uomini era grande» [70] attraverso un «diluvio di acque su la terra» [71], si ripete nel famoso mito greco di Deucalione e Pirra, che sfuggono sempre grazie ad un’Arca al diluvio imposto da Zeus per purificare l’immoralità umana. Anche loro, salvatisi sulla cima del Parnaso, ripopoleranno il mondo lanciando delle pietre da cui risorgeranno gli esseri umani. Anche nell’Edda ritorna la dinamica nel segno dell’elemento liquido. Quando i figli di Borr uccidono il gigante Ymir, sgorga tanto sangue da annegare l’intera stirpe dei thursi della brina. Ne uscirà salvo uno soltanto, Bergelmir, nascostosi con la moglie dentro un tronco cavo. Da loro si ricreerà la razza dei giganti della brina. Anche nella contesa fra Izanaki ed Izanami lo strumento esecutore è la sostanza acquea. Si intuisce che Izanami, ormai definita «signora delle acque ocra», soffocherà la stirpe umana mediante annegamento, ma sarà Izanaki ad officiare la purificazione di «un mondo tanto sporco» [72] decidendo di compiere delle abluzioni rituali.
Ed ecco l’atto generativo, o meglio plasmatore. Nella calma delle sacre aspersioni, Izanaki deterge il proprio occhio sinistro e da una lacrima ne nasce Amaterasu, la grande dèa del sole, somma divinità dello Shintoismo, cui l’imperatore in persona reca omaggio al santuario di Ise, il più importante di tutto il Giappone. Poi si lustra l’occhio destro e ne sorge il dio Tsukiyomi, infine si lava il naso generando Susanowo, il dio malvagio e rude di cui si racconteranno svariate gesta. Ai tre kami Izanaki spartisce il compito di governare rispettivamente sui cieli, sulla notte e sui mari, seguendo quindi la classica divisione di poteri che si trova non solo sull’Olimpo fra Zeus, Ade e Poseidon, ma anche nel Valhöll fra Ódhinn, Víli e Vé. La fecondazione dei tre numi propiziata dalle parti corporee di Izanaki ritrova poi il tema ancestrale del sacrificio battesimale. L’esempio più incisivo è quello del Puruṣa nel Vedismo, il gigante primordiale dal cui sacrificio ha origine sia l’universo fisico – dal suo respiro venne il vento, dall’ombelico l’atmosfera, e via dicendo – che sociale: da bocca, braccia, cosce e piedi le quattro varna, ossia le caste. Anche ad un’altra divinità creatrice, Viśvakarman, viene chiesto: «offri in sacrificio la tua stessa persona» [73], permettendoci di ricordare la reinterpretazione del sacrificio che avviene nel passaggio fra i due Testamenti della nostra tradizione. A tal proposito, anche nell’Edda il sacrificio di Ymir, altro gigante, ha il sapore della Transustanziazione: «dal suo sangue il mare e le acque; la terra fu tratta dalla sua carne»[74]. Infine, anche la cultura dell’antica Cina, per cui è rischioso parlare di un’autentica mitologia, tramanda la vicenda di Ban-gu, stavolta un nano, che per trarre il mondo fuori dal Caos si immola. Dalla sua testa ne sorsero le montagne, dal respiro vento e nuvole, dalla voce il tuono, dal sangue i fiumi, dalla carne la terra, da pulci e pidocchi, ovviamente, l’uomo [75].
Grazie al battesimo di Izanaki, ci è possibile rivisitare parte della cosmogonia del Kojiki proprio alla luce di quel creazionismo apparentemente rifiutato che, pur restando in questo caso inammissibile, può fornire uno sguardo per notare alcuni valori retrostanti. Già alle prime battute dell’opera, infatti, si era preannunciato che «il sole e la luna spuntarono dal lavacro degli occhi» [76], quelli di Izanaki stesso probabilmente, che già in precedenza aveva dato vita alla sacra Nakisaha piangendo la morte di Izanami. Si noti che anche dagli occhi del Puruṣa nacque il sole, l’analogo di Amaterasu, mentre la luna provenne dalla sua mente, di cui in quasi tutte le tradizioni è l’occhio a farne da specchio. In questo modo si può tentare un ipotesi sull’oscuro passo del Kojiki che descrive il primissimo movimento occorso ai primordi della storia. «L’orizzonte si era appena schiuso» [77] si diceva, disegnando forse lo stimolo di un occhio che si apre. Il racconto potrebbe allora giocar di metafora per mantenere l’ambiguità sulla presenza-assenza di un creatore, o meglio, per far dire alla metafora stessa ciò che un’ottica anti-creazionista come quella nipponica può solo adombrare. Sembra esserci perciò un “lavacro degli occhi” originale, la cui identità rimane però sfumata. Con il medesimo intento criptico, anche l’essere primevo descritto all’inizio dei Ṛg Veda rimaneva innominato. Era l’ekam = “Uno” o “neutro”, o anche solo «Ciò». Di lui si dice sia che possiede un «potere autonomo» [78] ma anche che ha avuto a sua volta una «nascita» [79]. Questa contraddizione impone quindi una serie di domande eziologiche che vengono formulate direttamente nel corso degli inni. «Chi invero sa, chi potrebbe proclamarlo da dove è nata, da dove si è verificata questa creazione?» [80] ci si chiede all’inizio. Lo stesso approccio si conserva anche quando in seguito si parla di altre divinità, come gli Aśvin, i cavalieri gemelli del cielo, di cui ci si chiede dove si trovino prima del mattino e dopo la sera, o come Vāta, dio del vento, di cui non si sa da dove proviene né dove svanisca. Lo stesso pungolo è esercitato nell’Edda da Ganlgeri, curioso di apprendere l’Άρχή. Se si nota, però, che nella tradizione nordica il suo nome è sia l’epiteto del re Gylfi, che come detto si incammina per soddisfare il suo dubbio, sia di Ódhinn, da cui il re si reca, allora si capisce che anche qui soggetto e oggetto scambiano ironicamente i ruoli. «Quale fu l’inizio – chiede allora Gangleri – e come ebbe principio ogni cosa?» [81]. Anche lui converte poi l’atteggiamento nei confronti dei fenomeni, domandando a sua volta «di dove viene il vento?» [82]. Ma anche per lui, tuttavia, il cammino a ritroso sul sentiero delle cause paventa il regressus ad infinitum. Quando chiede di cosa si nutrisse Ymir, il gigante originario di cui s’è detto, gli si risponde che beveva dalle mammelle della vacca Audhhumla, il che lo sospinge ovviamente a chiedersi di cosa si nutrisse lei a sua volta. È come la dinamica dell’elefante che regge il mondo e che viene sorretto da una tartaruga e poi chissà, di cui parla la tradizione indiana e che offre a Diderot uno spunto filosofico nella sua Lettera sui ciechi (1749). Essa viene nominata, per chiudere il cerchio, proprio dal prof. Nakagawa come esempio di ozioso quesito sul creazionismo da cui la sensibilità orientale guadagnerebbe una buona distanza.
Non mancano però delle eccezioni. Fu nel 1605 che un teologo giapponese, ovviamente cattolico, scrisse Il dialogo fra Yūtei e Myōshū, in cui si paragona l’universo ad una casa e si dice «l’origine non ha potuto prodursi da sola» [83] perché non si può credere che legname e bambù si siano riuniti da sé. Ciò che però Nakagawa non sottolinea citando il passo è che il dubbio dell’autore non è incentrato sull’identità dell’artefice, ma sulla sua sola presenza onde ricostruire la dinamica d’un evento altrimenti inspiegabile. Anche per questo è utile menzionare, come lui fa, le Informazioni sull’Occidente scritte nel 1710 dal filosofo Hakuseki Arai, il quale risponde: «se Deus ha potuto prodursi da sé perché il cielo e la terra non avrebbero potuto fare altrettanto?» [84]. In effetti il termine stesso natura, shizen (自然), letto come «hitori suru» significa «farsi da sé». Questo meccanismo interno, al di là della presenza allusa dal «lavacro degli occhi», vale per i primi esseri di cui parla il Kojiki, ma anche per la carne del cinghiale Sæhrímnir di cui parla l’Edda, che cotto e mangiato ogni giorno, a sera è di nuovo integro – il che ricorda il fegato di Prometeo – . Vale per la Notte descritta nella Teogonia che produce per generazione spontanea senza accoppiarsi e riguarda anche il ruolo del dio vedico Agni, che in quanto fuoco empie di potenza la natura, ponendosi come «embrione che sta nelle piante» [85]. Per cercare quindi di stemperare l’eccessiva, seppur veritiera, estraneità fra il Kojiki, e con lui la spiritualità asiatica nel suo complesso, con la cosiddetta tradizione occidentale – estraneità la cui odierna enfasi è spiegabile con il desiderio delle culture esotiche di veder riconosciuti i propri diritti intellettuali, anche se talvolta la strategia è controproducente, soprattutto quando pretende di scovare ovunque dei dualismi – conviene rifarsi ad un testo del noto sinologo François Jullien dal titolo Le trasformazioni silenziose, in cui sostiene senza remore il nuovo destino del soggetto:
Un “soggetto” che all’improvviso si scopre “processo” e si vede immerso, assorbito, in quest’ultimo [86].
Superando quindi anche la causa sui, opta per un continuum in cui il soggetto non si nega in quanto tale, ma si immerge nella sua funzione di elemento promotore di determinati processi. Curiosamente, l’ente unico e originario di cui parlano gli inni vedici, l’Uno indefinito, viene detto in sanscrito anche tat («Ciò»), che nelle lingue germaniche ricorda invece, pur senza parentela alcuna, la radice dei verbi d’azione. Ecco quindi che se Jullien parla riferendosi alla cultura orientale, questo valore si conferma anche in quella “nostrana”. Il Genesi stesso, per tornare al paragone iniziale, non spende una parola sull’identità divina, sulla descrizione di ciò che precedeva la creazione o sui motivi per cui essa ebbe inizio, e questo non tanto per il rischio di empietà cui solo dopo si dette adito, ma perché tutto l’interesse era rivolto alla dinamica, al processo, alla trasformazione ed evoluzione dell’Essere a partire dalla sua assenza, più che dal Nulla in quanto tale. Si centra allora la domanda quando ci si chiede «Come?» e non «Chi?». La risposta ad essa è deputata al mito. Se Jullien parla dell’evento come «affioramento» [87] di una trasformazione sotterranea e silenziosa, ebbene in questo caso esso è il mito stesso, e con lui la poesia, che lo esprime. Non dimentichiamo che dallo stesso «burro coagulato» che, prodotto durante il sacrificio del Puruṣa, nascono gli elementi naturali, sorse anche il Ṛg Veda stesso, i cui inni ne tramandano la narrazione. Dallo sputo degli dèi del Valhöll e del popolo dei Vani nacque Kvasir, l’uomo sapiente il cui sangue, mischiato assieme al miele, produce l’idromele che instilla il dono della poesia in chi lo beve. E pensare che anche le deformi figure dipinte da Monet erano state paragonate a degli sputi prima di capire la profondità del suo nuovo atto creativo.
Nel Kojiki, in uno dei vari componimenti poetici che, come nelle Mille e una notte, intervallano la prosa aiutando i personaggi a scampare alcuni pericoli grazie al fascino dei versi, se ne legge uno intonato da un’ancella che, rischiando la morte per aver fatto cadere una foglia nella coppa da cui il sovrano stava per bere il suo liquore, paragona la poesia stessa che ne è scaturita alla creazione originaria, sorta dalla salsedine cagliata dalla lancia di Izanaki, e dice:
Ricorda il grasso dell’inizio del tempo e il primo gorgoglio
Cosa straordinaria e mirabile [88].
NOTE
[1] Nakagawa Hisayasu, Introduzione alla cultura giapponese, trad. it. Francesco Saba Sardi, Bruno Mondadori, Milano, 2006.
[2] Ivi, p. 21.
[3] Ibidem.
[4] Ivi, p. 44.
[5] Kojiki. Un racconto di antichi eventi, a cura di Paolo Villani, Marsilio, Venezia, 2006, p. 33.
[6] Gen.1:2, La Bibbia, Edizioni Paoline, Roma, 1968.
[7] Ṛg Veda. Le strofe della sapienza, a cura di Saverio Saini, Marsilio, Venezia, 2000, p. 65.
[8] Esiodo, Teogonia, a cura di Graziano Arrighetti, Bur, Milano, 2013, p. 71.
[9] Kojiki, cit., p. 33.
[10] Gen. 1:1.
[11] Gen. 1:6.
[12] Snorri Sturluson, Edda, a cura di Giorgio Dolfini, Adelphi, Milano, 2013, p. 52.
[13] Ṛg Veda, cit., p. 68.
[14] Erodoto, Storie 2, 53, 1, cfr. Esiodo, Teogonia, cit., p. 53.
[15] Tito Livio, Storia di Roma dalla sua fondazione, trad. it. Mario Scàndola, Bur, Milano, 2013, voll. 13, I, p. 265.
[16] Kojiki, cit., p. 33.
[17] Ibidem.
[18] Gen. 1:2.
[19] Gen. 1:16.
[20] Gen. 1: 14.
[21] Gen. 1:4.
[22] Gen. 1:5.
[23] Kojiki, cit., p. 33.
[24] Ṛg Veda, cit., p. 65.
[25] Ivi, p. 229.
[26] Snorri Sturluson, Edda, cit., p. 59.
[27] Kojiki, cit., p. 33.
[28] Gen. 18:2.
[29] Kojiki, cit., p. 33.
[30] Ko-Gi-Ki, Vecchie cose scritte, Laterza, Bari, 1938, cfr. Hisayasu Nakagawa, Introduzione alla cultura giapponese, cit., p. 43.
[31] Ṛg Veda, cit., p. 92.
[32] Kojiki, cit., p. 36.
[33] Gen. 1:11.
[34] Snorri Sturluson, Edda, cit., p. 50.
[35] Ivi, p. 58.
[36] Kojiki, cit., p. 33.
[37] Ṛg Veda, cit., p. 65.
[38] Gen. 4:24.
[39] Ṛg Veda, cit., p. 70.
[40] Ivi, p. 113.
[41] Snorri Sturluson, Edda, cit., p. 50.
[42] Kojiki, cit., p. 36.
[43] Ibidem.
[44] Ṛg Veda, cit., p. 67.
[45] Snorri Sturluson, Edda, cit., p. 54.
[46] Ivi, p. 52.
[47] Gen. 2:7.
[48] Kojiki, cit., p. 36.
[49] Snorri Sturluson, Edda, cit., p. 37.
[50] Ibidem, cfr. F.R. Schröder, Ingunar-Freyr, Tübingen, 1941.
[51] Kojiki, cit., p. 36.
[52] Gen. 2:24.
[53] Ṛg Veda, cit., p. 67.
[54] Tito Livio, Storia di Roma dalla sua fondazione, cit., p. 335.
[55] Ṛg Veda, cit., p. 245.
[56] Snorri Sturluson, Edda, cit., p. 63.
[57] Esiodo, Teogonia, cit., p. 101.
[58] Ivi, p. 127.
[59] Kojiki, cit., pp. 38-39.
[60] Ṛg Veda, cit., p. 89.
[61] Ivi, p. 40.
[62] Kojiki, cit., p. 41.
[63] Ruth Benedict, Il crisantemo e la spada. Modelli di cultura giapponese, Laterza, Bari, 2009.
[64] Gen. 3:7.
[65] Gen. 2:25.
[66] Snorri Sturluson, Edda, cit., p. 80.
[67] Ṛg Veda, cit., p. 77.
[68] Ivi, p. 128.
[69] Kojiki, cit., p. 42.
[70] Gen. 6:5.
[71] Gen. 6:17.
[72] Kojiki, cit., p. 42.
[73] Ṛg Veda, cit., p. 66.
[74] Snorri Sturluson, Edda, cit., p. 57.
[75] Wilhelm Hellmut, Sinn des I Ging, Eugen Diederichs Verlag, 1986, p. 34.
[76] Kojiki, cit., p. 33.
[77] Ivi, p. 36.
[78] Ṛg Veda, cit., p. 65.
[79] Ivi, p. 68.
[80] Ivi, p. 65.
[81] Snorri Sturluson
, Edda, cit., p. 52.
[82] Ivi, p. 70.
[83] Nakagawa Hisayasu, Introduzione alla cultura giapponese, cit., p. 33.
[84] Ivi, p. 34.
[85] Ṛg Veda, cit., p. 99.
[86] François Jullien, Le trasformazioni silenziose, trad. it. Mario Porro, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2010, p. 13.
[87] Ivi, p. 132.
[88] Kojiki, cit., p. 33.
BIBLIOGRAFIA
Benedict, Ruth, Il crisantemo e la spada. Modelli di cultura giapponese, Laterza, Bari, 2009
Erodoto, Storie, tr. it. di L. Annibaletto, Mondadori, Milano, 1988
Esiodo, Teogonia, a cura di Graziano Arrighetti, Bur, Milano, 2013
Hellmut,Wilhelm, Sinn des I Ging, Eugen Diederichs Verlag, 1986
Jullien, François, Le trasformazioni silenziose, trad. it. Mario Porro, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2010
Kojiki. Un racconto di antichi eventi, a cura di Paolo Villani, Marsilio, Venezia, 2006
Ko-Gi-Ki, Vecchie cose scritte, a cura di Mario Marega, Laterza, Bari, 1938
La Sacra Bibbia, Edizioni Paoline, Roma, 1968
Nakagawa, Hisayasu, Introduzione alla cultura giapponese, trad. it. Francesco Saba Sardi, Bruno Mondadori, Milano, 2006
Ṛg Veda. Le strofe della sapienza, a cura di Saverio Saini, Marsilio, Venezia, 2000
Schröder, F. R., Ingunar-Freyr, Tübingen, 1941
Sturluson, Snorri, Edda, a cura di Giorgio Dolfini, Adelphi, Milano, 2013
Tito Livio, Storia di Roma dalla sua fondazione, trad. it. Mario Scàndola, Bur, Milano, 2013, voll. 13, I.