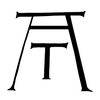di Antonio Attisani
Il tema che è qui proposto per rilevare alcune peculiarità dei teatri presi in considerazione rimanda, per quanto mi riguarda, al più vasto quadro del Novecento e allo scostamento tra realismi e grotteschi che lo percorre tutto. È una contrapposizione primaria, ma non esclusiva, da considerare assieme all’istanza di nuovi modelli volti a reintegrare gli aspetti festivi e comunitari della teatralità. La contrapposizione è tra una concezione del teatro come rappresentazione e illustrazione, per quanto “criticamente annotata”, dei testi drammaturgici, vale a dire delle poetiche e delle vicende preesistenti alla creazione scenica, concepite da scrittori e drammaturghi che ne sarebbero i titolari supremi, e dall’altra del teatro come luogo di trasformazione interiore e collettiva. Nel primo caso gli attori sono interpreti, nel secondo sono innanzitutto “poeti”. Alla fenomenologia del “teatro di poesia” in diversi contesti chi scrive ha dedicato alcuni studi, soffermandosi in particolare su ciò che essa comportava per la mentalità e i protocolli dell’attore, della compagnia teatrale, della regia e della ricezione, e dislocando in secondo piano la questione della drammaturgia intesa come biblioteca di testi. [1]
A partire dal 1991, l’incontro con il teatro del Tibet ha suggerito, anzi imposto, di considerare nel quadro delineato anche questa tradizione lontana in ogni senso, per i motivi che qui si tenterà di circostanziare. Chi scrive ha affrontato l’impegno con molti limiti, primo fra tutti la non conoscenza della lingua tibetana, ma soprattutto per l’incoraggiamento del Dalai Lama, il quale, ottimista come sempre, esortava a iniziare un lavoro destinato a restituire quella civiltà teatrale all’onore della storia, aggiungendo che sicuramente altri studiosi avrebbero colmato le inevitabili lacune. A quasi vent’anni di distanza non pare che ciò sia ancora avvenuto, purtroppo, e le pubblicazioni del sottoscritto sull’argomento sono rimaste isolate in uno strano silenzio, tanto della tibetologia (con le eccezioni di Erberto Lo Bue, prodigo di puntuali critiche e consigli, e Giacomella Orofino, capace di ascoltare e di formulare le domande ancora in attesa di risposta), quanto della teatrologia. Ciò ha comportato una concentrazione sui caratteri specifici e autonomi del teatro a ce lha mo, considerato sotto il profilo dell’evento performativo e come manifestazione di poesia orale, e un continuo tentativo di dialogo con diverse altre discipline.[2] Il risultato più significativo consiste forse nella creazione di una discreta biblioteca di documenti scritti, in diverse lingue, e di un fondo di audiovisivi che stanno per confluire in una istituzione pubblica e quindi saranno a disposizioni dei ricercatori che vorranno occuparsene. [3] Tutti i contributi pubblicati nel frattempo, anche quelli limitati a una riproposizione pittoresca del folklore tibetano o quelli specialistici su singoli temi storici o letterari, religiosi o sociali che trovano eco nell’a ce lha mo, sono lì ugualmente raccolti.
Una ragione non secondaria per partecipare a questo seminario è proprio la speranza di muovere l’interesse di nuovi e giovani studiosi. In questo senso è bene sottolineare che l’oggetto d’indagine ha molto da offrire alle legittime ambizioni di chi vorrà intraprendere nuove ricerche. Per avere successo in qualsiasi carriera è necessario segnalarsi come specialisti insostituibili di un soggetto e un metodo critico, e ciò sempre di più in un contesto internazionale. L’indagine sugli aspetti performativi del teatro tibetano è solo agli inizi, esiste davvero o poco o nulla su una drammaturgia che annovera sicuramente alcuni capolavori assoluti, e ancora tutte da sistematizzare sono le conoscenze relative all’aspetto musicale e canoro del lhamo, così come si continua a sentire la mancanza di una sua storia contestualizzata, di una indagine morfologica comparata (si pensi per esempio alle influenze indiane), di una iconologia storico-critica, senza contare naturalmente tutto ciò che potrebbe emergere dagli incroci delle diverse prospettive disciplinari. Per affrontare questi temi è indispensabile praticare almeno due lingue tra tibetano, inglese, sanscrito e cinese e il preventivo reperimento delle fonti richiederà un notevole impegno. È immaginabile dunque un impegno di molti studiosi per lungo tempo, ma si tratta di un’impresa meritoria e gratificante. Per concludere con questo aspetto, si aggiunga che la biblioteca dedicata finora allestita fornisce molte tracce e che oggi, a differenza di venti o dieci anni fa, diversi nuovi archivi e soprattutto il web rendono disponibile una mole di materiale prima inimmaginabile.
L’obiettivo principale è sicuramente quello di restituire all’onore del mondo una civiltà teatrale finora sconosciuta, non secondaria e diversa da tutte le altre, asiatiche e non, ma è auspicabile che qualcuno vorrà dedicarsi all’aspetto forse più intrigante della questione, cioè a considerare il lhamo in rapporto alle vicende e alle istanze teatrali del nostro tempo, come un teatro vivente, un luogo di pratiche e processi prima che di testi, sopravvissuto da una parte con caratteri di “estraneità” al moderno e dall’altra come una sorta di utopia realizzata, visto che alcune delle più significative rivoluzioni teatrali degli ultimi cento anni sono state mosse dal tentativo di riconquistare proprio quei caratteri. Altri teatri orientali sono portatori di felici anacronismi che hanno provocato un fertile confronto con i teatri contemporanei e sappiamo che molti studiosi e artisti di tutto il mondo procedono sistematicamente e con diverse metodologie su questo terreno, basti pensare all’ISTA (International School of Theatre Anthropology) diretta da Eugenio Barba, alla scuola di Ethnoscénologie diretta da Jean-Marie Pradier all’università di Paris VIII, oppure all’ARTA, fondata da Ariane Mnouchkine e operante alla Cartoucherie di Vincennes (Parigi). Le forme performative del Tibet non sono state ancora prese nella dovuta considerazione da parte di questi organismi.
La particolarità forse più vistosa dell’a ce lha mo è la sua somiglianza con il teatro ellenico, sul quale le testimonianze non abbondano e che tuttavia consideriamo – dando per scontate molte cose che non lo sono – come la “nostra” origine, quando si tratta invece di un fenomeno limitato a un arco spazio-temporale lontano (meno di cento anni nell’Atene di venticinque secoli fa) e soprattutto con il quale il teatro del nostro tempo sta in netta soluzione di continuità. Sia come sia, quel teatro ha quasi sempre costituito un modello ideale, cui adeguarsi, contrapporsi o da coniugare nel presente, e vederlo in parte “realizzato” nel teatro tibetano consente di verificare in corpore vili alcune questioni brucianti, ben al di là delle scarne testimonianze e della manciata di testi che ci restano. Ciò è possibile, però, non avvicinando il nostro oggetto attraverso i video e le tournée delle compagnie tibetane in Occidente, ma direttamente sul campo, tanto nel Tibet occupato quanto nelle comunità dell’esilio.
Per tracciare un primo ritratto e farci un’idea su come si configuri qui il binomio sublime-grottesco possiamo immaginare di guardare insieme un documentario girato nel 1993 a Dharamsala, capitale della diaspora tibetana in India, in occasione del primo festival teatrale Shotön, da allora replicato ogni anno. [4] In queste pagine si faranno giusto alcuni accenni ai vari aspetti di questo teatro (qualche approfondimento si trova nelle opere citate), così da affrontare il tema che ci riunisce.
La prima cosa da notare è come tutta la “città”, in ogni sua componente, si dia convegno a teatro, per un evento che si svolge dal mattino alla sera (e potrebbe durare anche più giorni). All’aperto – qui siamo nel cortile del Tibetan Institute of Performing Arts di McLeod Ganj –, sotto una grande tenda a volta, attorno a una “orchestra” semicircolare prendono posto circa duemila persone: su alcune panche siedono le autorità e gli ospiti, il resto del pubblico è sistemato su tappeti che ogni gruppo si è portato da casa, assieme alle provviste per il picnic. Al centro, addossato a un palo adornato che simboleggia l’axis mundi, c’è un altare che poi, nella convenzione scenica, diventerà il trono. Attorno a questo lo spazio interno, del palazzo reale o di altri ambienti in cui si svolge la storia, ai suoi margini i luoghi deputati esterni o lontani; alcune azioni, come le battaglie o le scene di piazza, investono tutta l’orchestra.
Lo a ce lha mo, o più familiarmente lhamo, è un caso unico di teatro dal nome femminile, essendo a ce lha mo un’espressione che indica una dea benevola, ideale di grazia e di bellezza. Le lhamo, o dakini nell’accezione di oggi, formano il coro che è sempre presente in scena e interagisce con i protagonisti. Le lhamo erano interpretate indifferentemente, nella tradizione, da attrici o attori, ma le attrici non erano normalmente ammesse a recitare allo Shotön (festa religiosa e di stato) e nei monasteri. Ciò nulla toglie al fondamento femminile di questo teatro, non solo perché molti dei suoi protagonisti sono donne ma perché esse incarnano lo spirito di quest’arte dispensatrice di “vera comprensione” alla comunità e agli spettatori.
Il repertorio tradizionale è limitato a una decina di testi, quasi tutti fissati nel XVIII secolo, sotto il regno del V Dalai Lama, un sovrano religioso e politico molto attento agli aspetti rituali, alle danze e al teatro secolare. I copioni composti e accolti successivamente possono differire nei temi, però si basano sui medesimi canoni espressivi (melodie, coreografie, maschere e costumi, ecc.). Il nucleo di ogni lhamo è costituito da canti le cui partiture di base sono poi precisamente definite e rifinite secondo i personaggi e la contingenza espressiva (l’ira, l’invocazione, la domanda, la decisione, ecc.). I copioni dei singoli lhamo sono comunque aperti, nel senso che ogni volta si definiscono contenuti e modi delle parti improvvisate e si adattano alla durata prevista della rappresentazione, che può variare dalle due-tre ore a più giornate. Di ogni titolo si conoscono o si ipotizzano a volte i primi estensori e alcuni adattatori successivi; ognuno dei copioni esiste pertanto in numerose versioni ed è difficilmente attribuibile a un singolo autore; i soggetti sono a volte di origine indiana o tratti da storie accolte nel canone tibetano detto Tangiùr. Gli innesti e le varianti apportati dalle compagnie possono essere di considerevole importanza. Tutto ciò prefigura una biblioteca ricca e disordinata, ancora lungi dall’essere raccolta e tanto meno studiata come merita. I copioni, comunque prodotto di una minoranza colta e sensibile all’evoluzione conseguente l’esperienza della rappresentazione, costituiscono una parte fondamentale del patrimonio letterario tibetano e alcuni di essi, come s’è detto e per quanto è dato comprendere allo stato, sono senz’altro da considerarsi capolavori. Si pensi per esempio a Nangsa, sorta di Casa di bambola d’ambiente tradizionale tibetano, con la sua eroina che si ribella a una vita di moglie e madre per inseguire un ideale ascetico, che per questo viene maltrattata e uccisa ma risorge e infine vince la sua battaglia con l’aiuto del lama suo maestro spirituale. Il valore di questo testo è riscontrabile anche dai lettori italiani e anglofoni nella versione tradotta da Tsultrim Allione. [5] È un vertice di poesia drammaturgica i cui accenti realistici in parte lo differenziano dagli altri lhamo del repertorio. La protagonista non è un’adolescente, come di solito accade, ma pur sempre una giovane donna alla ricerca di sé, o del Sé.
Comunque sia, il contenuto del lhamo in quanto creazione artistica e letteraria è sempre un racconto del divenire adulti. Per raggiungere questo obiettivo bisogna affrontare difficili prove, senza garanzia di successo, e la possibile riuscita mostra sempre due soluzioni principali: si può diventare regnanti, ovvero occuparsi delle cose del mondo e conquistare la felicità soprattutto dispensando felicità agli altri, oppure si può scegliere la via della rinuncia e del ritiro, raggiungendo la felicità suprema e immateriale della vacuità. Le vicende e le prove cui sono sottoposti i giovani protagonisti sono delineate secondo il paradigma della iniziazione sciamanica le cui costanti sono un maestro, o guida, le prove estreme (a volte istruite dagli stessi aiutanti magici) e la morte (simbolica e rituale) che si deve superare per rinascere alla vita autentica.
La concentrazione sulla drammaturgia non deve fare perdere di vista il fatto che l’evento teatrale tibetano non consiste esclusivamente nello spettacolo e trova il suo senso in un quadro più generale, festivo e rituale, dentro il quale è incastonato il sermo mythicus. Il citato documentario del 1993 mostra innanzitutto la festa solenne di un evento comunitario che rinasce nell’esilio. Tutti gli spettatori accorrono dal mattino presto. Le attrici e gli attori di una decina di compagnie teatrali della diaspora, composte da dilettanti (contadini, monaci, artigiani e giovanissimi di entrambi i sessi) – a parte il TIPA, l’istituzione per il teatro, il canto e le danze popolari fondata dal Dalai Lama già durante il primo anno di esilio in India, e luogo di formazione dei professionisti del lhamo – sono in attesa del Dalai Lama in un silenzio carico di commozione. La festa, per i tibetani, è da intendersi in senso pieno: interruzione delle normali attività, incontro tra tutte le componenti della comunità, monaci compresi ovviamente, che si riconoscono come parte di un tutto, ma anche gioco, abbondanti e squisiti picnic, corteggiamenti, discussioni, svago e riposo. Nel calendario tibetano la festa teatrale – con diverse compagnie e generi spettacolari – durava diversi giorni, una quindicina a Lhasa la capitale, meno nelle altre località.
Lo spazio scenico è dunque circondato dal folto pubblico che siede sui tappeti e accanto ai propri approvvigionamenti, mentre alcune tribune sono allestite per i membri del governo, gli ospiti stranieri e le alte gerarchie ecclesiastiche. La fase seguente inizia quando un corteo di attori, capeggiato in questa occasione da Norbu Tsering, l’anziano maestro del lhamo che ha guidato artisticamente il TIPA fin dai primi difficili anni di esistenza, pone sull’altare una piccola statua di Thangtong Gyalpo, il leggendario fondatore del teatro tibetano. All’interno della cornice festiva si apre quindi la cornice rituale, una sequenza codificata di danze e canti che hanno diversi scopi: prima di tutto consacrare lo spazio, ovvero trasformare un insignificante cortile o una radura nel luogo provvisorio di cui la comunità si servirà per riconoscersi e unirsi, ma anche per ricongiungersi benevolmente alle forze che regnano sotto terra, sulla terra e in alto. Questa cerimonia è officiata da tre gruppi di figure: i ngonpa (Cacciatori o Pescatori), le dakini e due gyalu, capivillaggio o capiclan, interpretati da attori che devono essere anch’essi tra i più anziani e rispettabili. Nella elaborata cerimonia officiata dagli attori che assumono una momentanea funzione “sacerdotale” si alternano per circa un’ora diversi canti corali solenni, per esempio in onore del Dalai Lama e del Panchen Lama o in lode delle catene montuose che rendono unico il Tetto del Mondo, ma anche sequenze acrobatiche e improvvisazioni, con i ngonpa in funzione di buffoni che provocano sia le belle lhamo che gli autorevoli gyalu. Il tutto è accompagnato dai ritmi dell’orchestra teatrale, composta normalmente da un suonatore di timpani e uno di tamburo a manico. Una volta conclusa la Esortazione dei ngonpa, questo il nome della sequenza-appello a tutte le componenti umane e naturali dell’evento affinché svolgano al meglio la propria funzione, entra l’attore capo della compagnia che si esibisce quel giorno e in qualità di Narratore introduce lo spettacolo, esponendo l’antefatto e presentando i protagonisti. Poiché ogni esecuzione è un adattamento, il Narratore interverrà più volte, con la sua tipica recitazione che somiglia al rap contemporaneo, svolgendo una funzione didascalica e di raccordo. Dopo di ciò può iniziare la vicenda teatrale vera e propria. Da spettatori abbiamo già preso atto di tutte le modalità espressive utilizzate da questo teatro: canto solista in dialogo con il coro, canto corale, recitazione “parlata”, recitazione ritmica, duetti, dialoghi, con tutti i gesti convenzionali e i movimenti coreografici del caso.
Assieme al Narratore entrano in corteo i protagonisti della prima “scena” (ognuna delle quali dura in media una ventina di minuti), quasi sempre un re e una regina con la rispettiva corte, oltre naturalmente al coro delle lhamo (cui si aggiungono di tanto in tanto, vocalmente, gli attori temporaneamente non impegnati come personaggi), che si schiera sul lato sinistro (per lo spettatore frontale) e sarà presente in scena sino alla fine. Le “arie” – s’è detto – costituiscono l’asse principale di ogni spettacolo e sono di difficile comprensione, vuoi perché il testo è arcaicizzante vuoi perché è interpolato da diversi suoni che fanno parte della melodia spezzando le parole; ma si tratta di canti molto popolari perché, oltre al loro contenuto sapienziale, sono un fondamentale oggetto di godimento e di dibattito estetico-critico e dunque costituiscono il principale elemento di valutazione dei singoli interpreti.
La situazione iniziale presenta sovente un regno non ancora conquistato al buddhismo o dove la religione è degenerata (per questo vi appaiono personaggi come indovini indù o stregoni di vario tipo). In questa corte o famiglia è sempre questione di bambini, talvolta desiderati dagli sposi e che faticano ad arrivare. La vicenda principale riguarderà il loro percorso verso l’età adulta e la successione ai genitori (ci sono significative varianti ed eccezioni, ma credo di avere dimostrato la persistenza dello schema accennato). Qui, nel dramma intitolato Dhonyoe e Dhondup, assistiamo dapprima alla partenza dei sovrani per ottenere da una lontana divinità la fertilità della regina. In ogni lhamo vi sono tesori di sapienza custoditi da draghi o deità terrificanti che regnano in luoghi impervi o sul fondo di laghi e mari, proprio come nell’Inno della perla che conclude gli Atti dell’apostolo Tommaso. I sovrani partono, sulla barca di stoffa sono dipinti il mare e i pesci. La seriosità è subito interrotta dalla vertenza comica instaurata dai traghettatori per ottenere il compenso che l’avaro ministro non concede, abusando del proprio potere. Gli inserti farseschi si svolgono attraverso dialoghi improvvisati, o meglio concordati per l’occasione.
La fase successiva riguarda le vicende del bambino o dei bambini, portati necessariamente al risveglio della propria personalità da persecuzioni, complotti e avversità varie. Quella del lhamo è una drammaturgia che trasforma in segni e peripezie il loro bisogno di sottrarsi alla morte del corpo e dello spirito, o alla sottomissione a qualsivoglia potere, per diventare se stessi. Per questo devono affrontare ogni sorta di avversità: montagne e tempeste, mostri, briganti e lestofanti di ogni tipo, animali feroci o di basso rango, che sono sempre latori di messaggi simbolici o direttamente sovrannaturali, e non mancano i frutti avvelenati o le deità terrifiche. Il loro percorso inizia sotto il segno della separazione e si conclude sotto il segno del ricongiungimento, anche se – come si vedrà – la loro fine individuale è diversa; ma incontrano anche alcuni aiutanti magici e sempre, al momento giusto, un maestro spirituale che ne riconosce le qualità e sa metterli sulla strada che finiranno di percorrere da soli, la strada del ritorno all’origine, o a Sé.
Il Dalai Lama segue la vicenda teatrale, scorrendo il testo e osservando gli attori con l’aiuto di un binocolo, da dietro una tenda, come da tradizione. Confusi tra il pubblico si intravedono due bambini tulku (rinascite volontarie di esseri che avevano conseguito l’illuminazione), che sono stati riconosciuti come “reincarnazioni” (così si dice sbrigativamente in Occidente) di due anziani tutori dell’attuale Dalai Lama, il quale è oggi il loro tutore. Dopo alcune ore, le peripezie dei due fratelli si interrompono per lasciare spazio all’abbondante e festoso picnic consumato sul luogo. E un paio d’ore dopo la ripresa, a pomeriggio inoltrato, Dhonyoe e Dhondup sono prossimi all’epilogo della vicenda. Entrambi hanno attraversato la morte rituale (riconoscibile come tale perché sono risorti) e si ritrovano infine a corte, accolti festosamente dai genitori pentiti e convertiti al buddhismo. Qui il loro differente destino si compie: il maggiore, destinato a subentrare nella guida del regno, deve prima sconfiggere in battaglia un esercito di mercenari guidati dal malvagio primo ministro ribelle (un personaggio comico, come tutti i “cattivi” del lhamo), mentre il minore, che ha scelto del via del ritiro ascetico siede per ora accanto al lama eremita che gli ha fatto da guida per poi diventare suo discepolo.
Una volta finito lo spettacolo si devono completare le sue due cornici esterne. Una sequenza di danze e canti eseguita da tutta la compagnia costituisce il rito conclusivo, codificato, che pone termine alla funzione trasmutativa del teatro, vicenda sulla quale ognuno è libero di riflettere individualmente, dopo questa sorta di iniziazione di secondo grado ricevuta. Quindi si può tornare alla cornice civile e laica. Ogni attore ringrazia il pubblico personalmente, rivolgendogli qualche parola (e anticamente intascando le offerte individuali) e gli spettatori o i rappresentanti delle istituzioni omaggiano gli artisti con diverse khata, le sciarpe beneaugurali bianche. Ora che lo spettacolo è davvero finito può ricominciare la festa, di cui sono protagonisti assoluti gli spettatori. Qualcuno subentra a suonare tamburo e timpani, altri danzano, i più piccoli assistono divertiti o si cimentano in qualche passo. La festa può protrarsi a piacere, nella tradizione durava anche per alcuni giorni molto giocosi e trasgressivi che coinvolgevano tutto l’accampamento creato attorno al luogo della rappresentazione.
***
Il teatro tibetano si propone come un paradosso positivo: un sistema espressivo arcaico, forse il teatro vivente più antico del mondo, mostra alcuni aspetti di sconcertante attualità (attualità, con riferimento ad alcune fondamentali istanze delle avanguardie novecentesche, e non modernità, ché anzi qui si prefigura una netta alterità rispetto al teatro realistico-borghese). Per tratteggiare questi aspetti una digressione utile è quella già accennata, relativa alle analogie e differenze tra il lhamo e il teatro ellenico. Nel quadro generale dell’antropologia tibetana, caratterizzata dallo sviluppo peculiare di un buddhismo che la pervade in tutti i suoi aspetti, un primo sguardo sommario permette di stilare un indice di temi da esaminare con attenzione: scopo precipuo di questo teatro è la celebrazione e rifondazione periodica della comunità; questa istanza tuttavia non esclude la presenza di elementi critici; lo specifico teatrale trova il proprio senso all’interno della cornice festiva e di quella rituale; quest’arte richiede di essere realizzata, più che da attori-interpreti in senso stretto, da artigiani e performer che si prendono cura di tutti gli aspetti dell’attività teatrale e soprattutto della sua continua “attualizzazione”, mentre l’eccellenza professionale non esclude l’esercizio di altre attività; la creazione di un tempo dalla consistenza speciale (holy days, giorni santi), di cui la durata degli eventi è solo un indicatore; la conformazione del luogo teatrale, il theatron come luogo in cui ci si reca a vedere, ma anche luogo di iniziazione e di rivelazione continua; arte scenica che intreccia canto, danza e recitazione, spettacolo i cui contenuti, in particolare il logos giudicante o asseverativo, sono rimessi in gioco dall’artificio dei significanti; l’uso della maschera, che è tale anche quando non appare, perché i personaggi sono innanzitutto tipi, o individui, e i loro tratti psicologici non rimandano a caratteristiche “personali”; una drammaturgia basata sul mythos, sulla fiaba di magia (non la favola a sfondo morale), apportatrice di trasformazione; e il fine, che Giuseppe Tucci indica con il termine «revulsione», anziché catarsi, [6] per indicare lo stato nuovo cui si accede attraverso la comprensione istruita da un piano simbolico, una comprensione totale, in un certo senso fisica e trasfigurante. [7]
Tra le differenze, la più vistosa è la centralità dell’elemento femminile, che emenda e sviluppa le concezioni originarie del buddhismo, ma essenziale è la concezione della morte, o meglio delle varie possibili specie di morte comprese in una forbice di significati che vanno dal fallimento karmico (noi diremmo esistenziale) e dal ripiombare nella sofferenza, fino alla rinascita, ovvero alla conquista di una illuminazione che “colui che è diventato se stesso” deciderà se investire nella propria definitiva estinzione o nel votarsi alla felicità degli altri; infine, ma non certo meno importante, la compresenza (non la sintesi) di forme eterogenee che definire “tragico” e “comico”, “dramma” e “commedia” sarebbe improprio, come si sta cercando di dimostrare, dunque di uno stile i cui elementi propriamente comico-farseschi, tanto quanto le apparizioni terrifiche e quant’altro contribuiscono alla funzione suprema, ancorché vicaria rispetto alle pratiche del buddhismo, del lhamo nell’antropologia tibetana: il raggiungimento del sublime, la lotta per la conquista del sacro, ossia di quella «verticalità» che dalla prima formulazione in ambito teologico di Rudolf Otto [8] fino a Jerzy Grotowski [9] è indicata come il senso del “veicolo” teatrale. Gli osservatori più sensibili delle cose tibetane, anche se non particolarmente esperti di teatro, come Jacques Bacot, Giuseppe Tucci o Fosco Maraini hanno confermato che questa e non altro è l’essenza del lhamo. Tutto ciò comporta, tra l’altro, che quando si è spettatori di questo teatro nei nostri comodi teatri, assistendo all’esecuzione di pochi brani tra i più folkloristici, si è lontanissimi dalla possibilità di comprenderlo; forse l’unico modo di vederlo altrove sarebbe quello adottato dal regista Abbas Kiarostami per le rappresentazioni del tazieh: mentre lo spettacolo veniva eseguito in versione estesa, il pubblico occidentale era immerso in un panorama di schermi che riprendevano i volti e le reazioni dei veri spettatori in Iran.
Nel teatro ellenico, per venire al nostro tema, l’elemento grottesco e quello sublime si presentano in specie e con funzioni diverse, come tra l’altro dimostra il saggio di Riccardo Palmisciano, mentre qui sono aspetti consustanziali della medesima poetica e specie artistica. Ciò detto, però, è necessario un chiarimento, perché la peculiarità di un ipotetico grottesco tibetano ha un senso pieno solo a condizione di liberare il termine da alcuni equivoci che lo accompagnano nella vulgata occidentale, dove ha finito per designare la mostruosità, la deformazione penosa e ridicola, configurandosi come polo opposto del sublime. Nella nostra cultura, per significare il grottesco ci si riferisce soprattutto a Victor Hugo e al romanticismo, commettendo anche in quel senso un errore poiché anche in quell’ambito esso assume diverse connotazioni, basti pensare a Heinrich von Kleist o Adam Mickiewicz, per non dire di Arthur Rimbaud, il cui adagio «Il faut faire l’âme monstruose» si riferisce da una parte alla funzione della poesia, al fare l’anima, e dall’altra alla mostruosità come destino sottratto alla normalità intorpidita.
Per concepire un altro grottesco contemporaneo il riferimento imprescindibile è il filosofo e critico letterario russo Michail Bachtin. È stato lui a opporre il grottesco del Gargantua rinascimentale di Rabelais a quello romantico di Hugo e a quello semplificato di alcune avanguardie del Novecento, [10] compiendo una grande impresa culturale e politica di attualizzazione e dimostrando che l’umanesimo borghese apparentemente trionfante porta con sé un modo della mimesis basato sulla impossibile censura di ciò che innanzitutto caratterizza l’umano: il corpo. Per comprendere il trait d’union Rabelais-Bachtin bisogna pensare all’Europa del Novecento, ovvero alle vicissitudini cui sono andati incontro un corpo e un tempo che non hanno saputo fare i conti con la propria realtà. Attraverso l’analisi del testo rabelaisiano, Bachtin non procede soltanto al rinnovamento filologico di un testo letterario, ma definisce un atteggiamento e un processo che ci riconsegnano un concetto di realtà non esteriore, più autentico ed essenziale di quello proposto dai realismi. L’autore oppone la ricerca della conoscenza e della saggezza secondo le coordinate di Rabelais alla rimozione del corpo propria degli umanisti; i loro ideali di eleganza e di buone maniere sono lo specchio deformante di una condizione umana assai più complessa, fatta anche di cibo, sesso, deiezioni. Tutto ciò considerando l’uomo un microcosmo. Da ciò il suo programma – oggi lo si definirebbe “biopolitico” – secondo il quale nell’arte occorre procedere a una «analogizzazione fantastica grottesca» [11] al fine di «corporeizzare il corpo, materializzarlo». [12] Per riuscire in questa impresa è necessario «distruggere la gerarchia stabilita dei valori, abbassare ciò che è alto e innalzare ciò che è basso, distruggere il quadro consueto del mondo in ogni suo punto», [13] vale a dire distruggere il falso e costruire (o divenire) il vero. È questa la concezione contemporanea del grottesco con cui occorre confrontarsi.
In tale quadro il “personaggio” «non è un corpo individuale […] bensì il corpo impersonale, il corpo del genere umano, corpo che nasce, vive, muore di molteplici morti e nasce di nuovo, corpo mostrato nella sua struttura in tutti i processi della sua esistenza». [14] L’attenzione è dunque spostata verso i processi e le manifestazioni, e i concetti bachtiniani non sono proiezioni idealistiche sulle cose osservate, ma strumenti suggeriti dall’esperienza e utilizzabili (certo solo transitoriamente) da coloro che si pongono sul medesimo cammino. Il corpo grottesco è incomparabilmente più vero di quello celebrato dai realismi. È opportuno insistere: la conquista di Bachtin non è la visione di qualcosa che fu, né una invenzione estemporanea, ma la messa a fuoco di un conflitto, centrale del XX secolo tra il corpo grottesco e gli ismi riduttivi, soprattutto i realismi, non a caso assunti a protocollo ufficiale da tutti i regimi e da coloro che vogliono controllare la comunicazione. Il grottesco non è un giudizio, ma uno specchio (nuovo) posto di fronte al mondo, e del sentimento con cui si compie l’opera. Questo specchio riflette il corpo grottesco così come si declina nei vari contesti culturali, nazionali e d’autore.
La storiografia di questo conflitto è ancora quasi tutta da fare; basti pensare agli episodi assai diversi che sono avvenuti nelle avanguardie artistiche di paesi come la Russia, l’Italia, la Francia, la Germania, la Polonia, ecc., senza dimenticare le cadute nelle semplificazioni ideologiche che pure si sono verificate, sempre nel nome della verità. Tutto il teatro del secolo è percorso e segnato da questa grande, per quanto talvolta non esplicita, “polemica” e dovrebbe essere riletto in questa luce, ovviamente non per ridurlo a una pseudo-dialettica ma per evidenziare nelle operatività, artistiche e non solo, i procedimenti e la qualità della mimesis, i diversi modi di confrontarsi con l’essenza del reale, e la comprensione catartica, comprensione conquistata attraverso un percorso fatto sia di emozioni che di concetti e che alla fine del lavoro diventa razionale e al tempo stesso fisica, totale.
Per focalizzare questa accezione del grottesco nella vicenda teatrale novecentesca bisogna guardare anzitutto a Vsevolod E. Mejerchol’d, e su questo non vi è chi non convenga, ma uno sguardo più attento rivela che persino il “naturalista” Konstantin S. Stanislavskij considera il grottesco come lo stile del secolo. [15] Il primo movente delle poetiche grottesche è costituito dal bisogno di andare oltre il “dramma borghese” e molto spesso la pronuncia culturale degli autori non va oltre tale orizzonte, ma basta pensare a un contesto come quello napoletano della prosa e della musica tra Otto e Novecento per rendersi conto della varietà e della ricchezza apportate da questa “nuova tradizione”. Il grottesco così definito prende le distanze, s’è detto, dal dramma socio e psicologico, ma in qualche modo lo “include” in un quadro antropologicamente più ricco di sfumature e preciso. Non deve ingannare il fatto che i movimenti in cerca di un altrove rispetto al controllo ideologico dei realismi abbiano adottato terminologie cangianti, a volte astruse, anche per segnalarsi sul mercato e non solo per astuzia anti-realistica.
Per Mejerchol’d il grottesco è il principio costitutivo del teatro in quanto tale. La sua definizione, riferita essenzialmente al procedimento compositivo, è comunque netta anche per ciò che concerne la contrapposizione con il realismo:
Grottesco: è un eccesso premeditato, una ricostruzione (uno sfigurare) la natura, un accostamento di oggetti che sarebbe ritenuto impossibile tanto in natura che nell’esperienza quotidiana, con una decisiva insistenza sul lato sensibile e materiale della forma in tal modo creata. In assenza di questa insistenza, che manifesta il processo di ricostruzione (e di composizione nell’ordine dell’immaginario), il grottesco è solo una chimera. Nel campo del grottesco si realizza la sostituzione alla composizione prevedibile di una composizione esattamente contraria, o l’aggiunta di alcuni procedimenti conosciuti, adatti alla rappresentazione di oggetti contrari a quello cui si applica il procedimento della parodia.
Il teatro, in quanto combinazione extra-materiale di fenomeni naturali temporali, spaziali e numerici che costantemente contraddicono la nostra esperienza quotidiana, è nella propria essenza stessa un esempio di grottesco. Nato dal grottesco del rito mascherato, il teatro crolla immancabilmente quando si compie il pur minimo tentativo di sottrargli il grottesco, suo principio costitutivo.
In quanto carattere fondamentale del teatro, il grottesco esige per esistere una inevitabile ricostruzione di tutti gli elementi esterni introdotti nella sfera teatrale, compreso l’elemento umano che gli è necessario e che esso trasforma in attore anche a partire da una personalità piccoloborghese. [16]
Da ciò possiamo dedurre che il grottesco è un modo della mimesis che consiste nella «ricostruzione» della natura in un’opera immaginale e in una «trasformazione» che riguarda tanto chi lo fa quanto i convenuti; mentre il rapporto con il rito indica la funzione di quest’arte scenica, funzione che secondo Mejerchol’d, si può addirittura assimilare a una interrogazione mistica:
Qual è per me il valore del misticismo? È l’ultimo rifugio di coloro che sono in cammino e si rifiutano di inchinarsi davanti al potere della Chiesa, senza però perdere la loro fede di uomini liberi e in un mondo trascendente. Il misticismo è una prova ulteriore che il teatro può risolvere la questione religiosa; per quanto scura possa essere la tonalità di un’opera teatrale, il misticismo contiene un appello incontenibile alla vita […] Il teatro deve dunque, secondo me, essere capace di strappare spettatori alla Chiesa e farli entrare nel proprio spazio, dove si produrrà l’illuminazione, la catarsi. In questo luogo l’anima in rivolta dell’uomo troverà il cammino che lo condurrà alla lotta. [17]
Il risultato finale di tale strategia mimetica, la catarsi, è una conoscenza conquistata da tutto il corpo. Ora, senza soffermarci sull’esegesi che meriterebbero queste citazioni e per tornare al nostro tema, cominciamo con il notare che «anima» è una parola che in tibetano non esiste, come d’altronde non esistono «catarsi», «spirituale» e nemmeno «misticismo»; ed è bene tenere conto che nel linguaggio materialistico integrale di Jerzy Grotowski il trascendimento diventa verticalità e a quello dell’anima subentrano i concetti di corpo-mente o corpo-vita. Insomma accettando di compiere un umile lavoro di traduzione, possiamo ipotizzare come si coniuga il grottesco nel caso del lhamo tibetano.
Qui l’idea del corpo (microcosmo) grottesco è estesa e proiettata sul cosmo. In questa prospettiva il lhamo appare come una realizzazione drammaturgica e una poetica, ma va inteso più propriamente come l’immagine dell’intero cosmo, una costruzione architettonica che include i corpi singoli e ne descrive le vicissitudini in quanto parti di un corpo collettivo in cammino per ri-conoscersi. La natura, qui, non è intesa come destino da accettare, ma come un potenziale che il lavoro di un’arte “spirituale” può attivare e sviluppare anziché subire. I motivi ontogenetici e la storia del lhamo sono tutti da approfondire in questo senso e i pochi studi già esistenti rappresentano solo un timido inizio. Quando ciò succederà, un’altra tradizione “pre-moderna” potrà essere messa in relazione con le ricerche più avanzate del XX secolo e contemporanee e una storia riprenderà vita. Il lhamo, inteso come insieme di drammaturgia, performance e protocolli di fruizione, risalterà allora in quanto “grottesco applicato all’anima”, come se quest’anima si materializzasse in tutti i suoi aspetti, bassi e alti: un’anima-ponte e un’anima-scala, orizzontale e verticale. Il effetti il lhamo non “rappresenta”, ma vive e suscita le avventure e le rivolte dell’anima-corpo che percorre il mondo: perciò è insieme un codice e un singolare universo poetico che contiene l’eco di un passato, di una civiltà che nel Novecento era in piena decadenza e oggi è a rischio di estinzione, ma che è anche capace di parlare agli spettatori di oggi, oltre che offrire uno specchio vivificante al nostro esangue teatro.
Il titolo di questa comunicazione, Teatro del popolo, teatro degli dèi, è stato deciso prima di riordinare le idee. Alla luce di quanto si è fin qui esposto direi che può essere confermato. Nell’antropologia tibetana il lhamo organizza in un sistema di segni il modo di viversi di un popolo e i suoi protocolli d’azione. Il popolo è un corpo-cosmo di cui gli dèi sono il DNA, un potenziale che abbraccia tutta la gamma di espressioni umane puntualmente indicizzate dal grottesco. Perciò popolo e dèi sono in qualche modo specchio uno dell’altro, e al tempo stesso sono fusi tra loro. Nel quadro dell’originale politeismo-ateistico tibetano, il lhamo opera come un luogo di sintesi e di elaborazione di questa concezione, come un dispositivo produttore di conoscenza e trasformazione, una occasione di libertà e di lotta contro ogni sorta di entropia.
Un ragionamento a parte andrà fatto sui peculiari caratteri estetici di questa civiltà teatrale appartata e minoritaria che ha conservato diversi tratti espunti dalla modernità trionfante nel mondo. Dovremo fatalmente utilizzare, in questa impresa, il nostro apparato concettuale, per esempio si dovrà fare i conti con la centralità dell’apparato simbolico; però si dovrà anche flettere quell’apparato verso l’orizzonte di senso tibetano, considerando che il simbolismo, anzi il sistema allegorico che lo contiene, qui, va ben oltre un livello didascalico, e che l’elemento performativo (il canto e l’azione coreografica) non ne costituiscono un ornamento o una mediazione comunicativa, ma sono al contrario una parte sostanziale di quel sacro che, secondo Otto, conduce lo spettatore divenuto individuo alla soglia di qualcosa di indicibile, di una esperienza non immediatamente condivisibile di trasformazione. L’euristica dedicata al lhamo sarebbe pertanto fine a se stessa se avesse soltanto lo scopo di scrivere un capitolo della storia culturale di un popolo e tradirebbe l’essenza di quest’arte, che non solo partecipa di un più vasto protocollo di conoscenza ma soprattutto ha la consistenza di una tecnica dell’immaginale che affronta problemi tuttora vivi sotto qualsiasi latitudine.
Ciò suggerisce di concludere riprendendo la questione del punto di vista. In Occidente si è affermata una gerarchia delle forme che nel caso del teatro, della letteratura e della poesia, da Aristotele a Erich Auerbach, [18] con aggiustamenti progressivi, assegna al lirico e al sublime il valore supremo e al grottesco – assieme al comico, al mostruoso e alla commedia – un valore incomparabilmente minore. Tant’è che lo stesso Auerbach nell’esaltare l’incontro tra grottesco e sublime in Dante lo pone sotto l’insegna di un «fenomeno stupefacente, paradossale, che si chiama il realismo dantesco», [19] seppure un realismo originale, evolutivo rispetto alla “rozza” compresenza dei due elementi nella drammaturgia medievale, a cui «bisognava perdonare la mescolanza degli stili per via della sua ingenuità». [20] Si fa questo esempio perché esso, considerato assieme all’impressione dei primi osservatori occidentali sulla natura “medievale” e appunto ingenua della drammaturgia tibetana, [21] potrebbe apparire come una conferma del carattere primitivo del lhamo, [22] di un suo sviluppo fermo alla fase che precede la grande svolta rinascimentale. Sarebbe una impressione, o una conclusione, sbagliata perché nel lhamo non vi è alcuna ingenuità ma l’incontro nel corpo unitario, di alto e basso. [23] Da questo incontro erompe il sacro («’l poema sacro, al quale ha posto mano e cielo e terra», Dante, Par., XXV, 2-3).
Il lhamo è ciò che è non a causa di un sottosviluppo, verosimilmente dovuto alla una mancata interazione con i teatri di civiltà più evolute, ma perché si è affinato (con precisi momenti di svolta, nel XIV secolo per la sua reinvenzione leggendaria da parte del santo folle Thangtong Gyalpo e nel XVIII per i protocolli fissati durante il regno del V Dalai Lama), fino alla sua decadenza nella seconda metà del Novecento e al suo parziale restauro attuale, restando sempre fedele alla sua funzione magica, ovvero di trasformazione e insegnamento “totale”, e al suo stile grottesco. In una ipotetica tassonomia delle forme, se mai avesse un senso decisivo, il lhamo tibetano dovrebbe essere considerato piuttosto un teatro barocco, come il teatro di William Shakespeare, che è perfettamente barocco e al tempo stesso unico (eppure la sua eccentricità non ha impedito che si tratti dell’autore più rappresentato di tutti i tempi). Sul senso di questa analogia ho speso diverse pagine in un’opera precedente. [24]Qui basterà ricordare quanto evidenzia uno dei più illustri critici shakespeariani, Jan Kott, affermando che «la caratteristica più rilevante di questo nuovo teatro è il suo aspetto grottesco».[25]
È bene precisare che Kott non offre una chiave di lettura definitiva e persuasiva, perlomeno secondo chi scrive, ma soltanto una potente suggestione che può sollecitare nuove messe in scena attualizzanti. Non a caso la prefazione di Mario Praz è molto appuntita contro una «critica valutativa», cui Kott è in pratica assimilato, che porta alla «falsificazione del passato», ovvero a vederci ciò che si vuole ci sia, ma ciò non impedisce di leggere e poi di apprezzare una lettura materialista che dimette però l’ottimismo dell’ortodossia ideologica (Shakespeare come drammaturgo delle lotte di potere a tutti i livelli) e legge la storia in senso nichilistico e aderente allo Zeitgeist novecentesco, ossia come assurdità sfuggita dalle mani dell’uomo. Insomma Kott non interpreterebbe Shakespeare con esattezza e tuttavia ne libererebbe un potenziale, come infatti ha confermato il teatro dagli anni Sessanta ai Novanta. Tra gli spunti propulsivi della critica kottiana vi è un concetto di grottesco precisamente definito. Anzitutto Kott precisa che «il grottesco si svolge in un mondo tragico»,[26] come una «derisione [che] non colpisce soltanto il carnefice, ma anche la vittima»[27] prefigurando così una «critica dell’assoluto in nome della fragile esperienza umana»[28] che non apporta la catarsi tragica ma lascia l’uomo contemporaneo solo di fronte al disinganno. Kott porta il suo ragionamento alle estreme conseguenze, certificando l’attualità di Shakespeare con l’eco che avrebbe in autori come Samuel Beckett e Eugène Ionesco, per i quali «l’assoluto è assurdo»[29] e anzi avrebbe «cessato di esistere», certificando l’«assurdità della situazione umana».[30] Ciò conduce, secondo Kott, sempre più irrevocabilmente lontano dal sacro e pertanto: «il destino, gli dèi e la natura sono stati sostituiti dalla storia».[31] Ebbene, la sua ermeneutica, mentre tradisce Shakespeare, come dimostra una critica più attendibile,[32] attraverso alcuni puntuali rilievi come quello che il suo grottesco «riprende gli schemi drammatici della tragedia e pone le stesse domande fondamentali. Sono le sue risposte che sono diverse»,[33] permette di cogliere una strategia della mimesis che si sottrae ai protocolli normalizzanti del realismo; e proprio come nel lhamo tibetano, sia pure con le debite differenze, si arriva così a creare un panopticon dei corpi nel mondo, corpi che subiscono il caotico potenziale umano e naturale oppure lottano per orientarlo.
Corpo grottesco, mondo grottesco, cosmo grottesco e secolo grottesco non sono certo finiti con le vicende storiche che li hanno resi percepibili, costituiti in concetti ed esaltati al massimo grado. Le storie di Nangsa e dei fratellastri Dhonyoe e Dhondup, come quelle del principe Drimekunden e della dakini Drowa Sangmo, ma soprattutto il procedimento festivo e rituale con cui sono offerte alla comunità e poi eseguite dagli attori, potrebbero dire qualcosa anche agli spettatori del tempo presente.
(Conferenza di Antonio Attisani, tenuta il 4 marzo 2009 presso il Centro di studi sul Buddhismo, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”)
NOTE
[1] Cfr. eventualmente A. Attisani, L’invenzione del teatro. Fenomenologie e attori della ricerca, Bulzoni, Roma 2003.
[2] Cfr., in italiano, A. Attisani, A ce lha mo. Studio sulle forme della teatralità tibetana, Olschki, Firenze 2001, e Idem, La prova del secolo. Il teatro del Tibet tra esilio e genocidio culturale, EIP, Torino 2008.
[3] Istituto per i beni marionettistici e il teatro popolare, diretto da Giovanni Moretti e Alfonso Cipolla, con sede presso Villa Boriglione, Parco Culturale Le Serre, via Tiziano Lanza 31, Grugliasco (Torino).
[4] Questo documentario, l’unico esistente sull’evento, è stato girato da Piero Verni, nell’occasione coadiuvato da Claudio Cardelli e dal sottoscritto. Il festival è stato da allora replicato ogni anno, con due interruzioni, nel 1998 e nel 2007, e alcune edizioni sono state oggetto di dettagliate riprese.
[5] Cfr. T. Allione, Nangsa Obum, in Donne di saggezza, Ubaldini, Roma 1985, pp. 83-146.
[6] Cfr. G. Tucci, Teoria e pratica del mandala, Ubaldini, Roma 1969.
[7] Per questa interpretazione del testo aristotelico cfr. Pierluigi Donini, Introduzione, in Aristotele, Poetica, Einaudi, Torino 2008, e A. Attisani, Così parlò Aristotele, in Idem, Smisurato cantabile. Note sul lavoro del teatro dopo Jerzy Grotowski, Edizioni di Pagina, Bari 2009.
[8] Cfr. R. Otto, Il sacro, (1917), traduzione di Ernesto Buonaiuti, SE, Milano 2009.
[9] Cfr. J. Grotowski, Dalla compagnia teatrale all’arte come veicolo, in Opere e sentieri, II, Jerzy Grotowski. Testi 1968-1998, a cura di A. Attisani e M. Biagini, Bulzoni, Roma 2007.
[10] Cfr. M. Bachtin, Estetica e romanzo, (1975), Einaudi, Torino 1979 (ma si consideri anche L’opera di Rabelais e la cultura popolare, Einaudi, Torino 2009).
[11] Ivi, p. 318.
[12] Ivi, p. 324.
[13] Ibidem.
[14] Ivi, p. 320.
[15] Stanislavskij si è espresso sul grottesco in diverse occasioni, ma particolarmente significativi sono i passaggi che dedica al tema, polemizzando (senza nominarli) con coloro che lo intendono a suo parere in modo riduttivo, in Il lavoro dell’attore sul personaggio, a cura di Fausto Malcovati, pref. di Giorgio Strehler, Laterza, Roma-Bari 2000, pp. 307-311. Qui il regista distingue tra un «falso grottesco», puro apparato di segni esteriori che “dicono” ciò che invece l’attore dovrebbe incarnare, e un «vero grottesco» che coincide con ciò che lui ha sempre fatto, anche quando lo etichettavano come naturalista, e cita come esempio supremo, esterno e oggettivo, la realizzazione dell’Otello da parte di Tommaso Salvini. Stanislavskij rifiuta di essere considerato un conservatore («Non è ora di farla finita con le parole “destra” e “sinistra”?») e polemizza contro la «corrente di pseudo-sinistra» e le sue «false innovazioni», concludendo che «l’autentico grottesco è molto di più che semplice caratterizzazione: è l’arte nel suo complesso. L’autentico grottesco è l’ideale della nostra creazione scenica».
[16] V. Meyerhold, Ecrits sur le Théâtre — Tome II, 1891-1917, trad, préf. et notes de B. Picon-Vallin, La Cité–L’Age d’Homme, Lausanne 1975, p. 84-85.
[17] V. E. Mejerchol’d, Zapisnajaknizka, Archivi letterari e artistici russi, Mosca, fondo 998, inventario 1, documento 193, ms., cit. da Gérard Abensour, Vsévolod Meyerhold ou l’invention de la mise en scène, Fayard, Paris 1998, p. 105.
[18] Cfr. E. Auerbach, Farinata e Cavalcante, in Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale, I, Einaudi, Torino 2000, pp. 189-221.
[19] Ivi, p. 207.
[20] Ivi, p. 201.
[21] Cfr. p.e. J. Bacot, Drimekundan, «Le Journal Asiatique», IX, 1914, pp. 221-305.
[22] E. Auerbach, Farinata e Cavalcante, cit. L’autore descrive i «tre regni» della Commedia come luogo di un’«esistenza immutabile» (p. 207), dunque di immanenza senza divenire. Mentre per Dante ogni individualità è fissata nell’«eterno giudizio» (p. 209), nel lhamo tibetano avviene il contrario: è descrizione di un puro divenire.
[23] La Commedia è tale, dice Dante nel De vulgari eloquentia, perché in essa «vero remisse et humiliter», lo ricorda Auerbach, op. cit., a p. 202.
[24] Cfr. A. Attisani, A ce lha mo, cit., cap. VI, Una drammaturgia fiabesca, pp. 377-429.
[25] J. Kott, Shakespeare nostro contemporaneo, (1961), pref. di Mario Praz, Feltrinelli, Milano 1964. La tematica del grottesco è sviluppata da Kott soprattutto a ridosso di Re Lear, ma chiaramente è proposta come un connotato generale e fondativo della originalità, anzi della vera e propria “rifondazione del teatro” da parte di Shakespeare.
[26] Ivi, p. 96.
[27] Ibidem.
[28] Ibidem.
[29] Ivi, p. 97.
[30] Ivi, p. 100.
[31] Ivi, p. 102.
[32] Cfr. lo stesso Praz, ma anche numerosi altri studiosi tra cui Harold Bloom (Shakespeare. L’invenzione dell’uomo, Rizzoli, Milano 2003) e Northrop Frye (Tempo che opprime, tempo che redime. Riflessioni sul teatro di Shakespeare, Il Mulino, Bologna 1986).
[33] Ivi, p. 104.