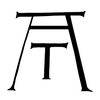https://doi.org/10.55154/UERP2859
Come citare
TARRICONE Riccardo, “Kagura, trance sciamanica e teriomorfismo: animali divini alle origini delle arti performative giapponesi”, AsiaTeatro – rivista di studi online, anno 2024, n.1, pp. 5-22.
https://doi.org/10.55154/UERP2859
Abstract. L’articolo si propone di integrare analisi condotte nell’ambito degli studi religiosi, con particolare attenzione al ruolo degli animali divinizzati nello Shintō dei primordi e nella religione popolare da esso derivata, allo studio delle arti performative giapponesi, affrontando soprattutto esempi provenienti dal Kagura. Vengono presi in esame alcuni aspetti della danza e del teatro giapponesi più facilmente riconducibili alle origini sciamaniche, soprattutto nel loro aspetto zoolatrico, attraverso riflessioni generali sui significati degli animali divini e della loro presenza all’interno della narrazione pantomimica e teatrale, nella quale si possono scorgere, nonostante i mutamenti d’epoca e contesto, le tracce di antiche pratiche rituali di metamorfosi ed estasi, che condividono anche con i drammi giunti ai nostri giorni più di quanto possa apparire a un esame superficiale.
Kagura, trance sciamanica e teriomorfismo: animali divini alle origini delle arti performative giapponesi
di Riccardo Tarricone
Nel corso della loro longeva e mutevole esistenza, le arti performative giapponesi hanno incorporato al loro interno una quantità di livelli stratificati di sofisticazione tale da farne scaturire analisi approfondite che spaziano tra ambiti disparati. Ne è un caso emblematico il Nō, con l’abbondanza e la minuzia delle teorie estetiche prodotte soprattutto dai suoi stessi esecutori o promotori: ma ciò non significa che la riflessione non possa spostarsi anche in campi distanti dagli studi teatrali, artistici ed estetici. Il campo degli studi religiosi non è escluso, anzi vi ricopre un ruolo cruciale. Indipendentemente da quanto un determinato testo teatrale abbia mantenuto le caratteristiche primigenie del suo genere d’appartenenza, difficilmente si può negare che il retroterra culturale in cui affondano tutte le radici delle arti performative, tra loro imparentate, conservi ‒ in misura più o meno forte, ma sempre presente almeno in parte ‒ un DNA legato alla vita spirituale dell’arcipelago.[1] Con questo non ci si riferisce al carattere spiccatamente buddhista di alcuni testi Nō e Kyōgen, né alla numerosità di influenze sia continentali che autoctone confluite nel Kagura, per quanto sia importante riconoscerle.[2] Ciò che si intende affrontare è, piuttosto, qualcosa di più nascosto ‒ come nascosti sono sempre, in una loro parte, i kami[3] ‒ e che accomuna linguaggi in apparenza estremamente diversi, manifestandosi di volta in volta con le caratteristiche del caso. Lo si rintraccia nell’atmosfera di forte trasporto emotivo, talvolta quasi ultraterreno, che la performance di Nō intesse tra il primo attore (shite) immerso nell’atto metamorfico e il pubblico incantato;[4] nelle voci lanciate nei momenti di pathos (kakegoe) spesso in unisono ai colpi catalettici del tamburo nel Nō o nel Kabuki; nella volontà stessa di inscenare un atto di trasformazione o di discesa di una divinità servendosi di espedienti variegati (maschere, oggetti di scena, gestualità codificate, o anche la comparsa di una marionetta draconica nel mezzo di uno spettacolo di Ningyō Jōruri).[5] Estasi, metamorfosi, presenza divina in un altare sacro o in una maschera di animale o altro oggetto riferito a un’essenza naturale e ferina, pratiche quasi ascetiche in preparazione di una performance, tamburi sincronizzati a grida e stereotipia di gesti, e soprattutto, a permeare ciascuno di questi aspetti, la messa in scena dell’attraversamento di una soglia, l’atto umano che si pone a metà tra due mondi separati, ma attraversabili da specifici individui dotati di adeguate abilità[6] (che si tratti di attori o di officianti religiosi): tutto questo è parte dell’essenza dei fenomeni sciamanistici del Giappone,[7] presenti già in tutte le forme spirituali autoctone[8] che in seguito sarebbero state raggruppate nella categoria dello Shintō, e che avrebbero fatto trovare terreno fertile anche a tutti quegli aspetti analoghi appartenenti ai sistemi di pensiero continentali che esercitarono la loro influenza sul teatro e sull’intera vita socioculturale (principalmente Buddhismo, Tao, Onmyōdō, e tutte le forme di commistione armonica tra l’autoctono e il continentale, come nello Shugendō, corrente buddhista di asceti di montagna).
Può forse apparire strano paragonare il gesto di un attore, altamente codificato e analizzato da innumerevoli esegeti attraverso tutta la storia del teatro, a un elemento rituale di un’esperienza d’estasi presente sin dalle origini preistoriche della spiritualità giapponese e ormai (erroneamente) non più presentata nel discorso mainstream come aspetto cruciale nello Shintō; esistono tuttavia numerose ragioni per credere che il paragone non sia azzardato ‒ e anche senza addentrarsi negli esempi, sarebbe sufficiente pensare alle radici comuni dell’esigenza umana di esprimersi attraverso l’arte performativa: “the step from religious ritual to art is a small one”.[9] Molti dubbi poi si dissipano quando si osserva la forma che più esplicitamente ha preservato l’originaria natura sciamanica: il Kagura.

Kagura: natura mutevole, nucleo stabile
Il Kagura consiste in performance di danza a carattere rituale inscenate spesso nel corso dei matsuri (i festival che costellano la vita culturale dell’intero arcipelago dai santuari più piccoli fino al Santuario di Ise) dei quali potrebbe costituire una forma prototipale.[10] Le caratteristiche e le funzioni devozionali o apotropaiche della danza sono molto variabili, e anche i due termini giapponesi che la designano ‒ mai e odori ‒ possono avere significati scambievoli; a seconda dei casi osservati, si può ritenere che il vocabolo mai si riferisca alle danze fatte di movimenti circolari ed eleganti e che odori indichi uno stile opposto fatto di salti e movimenti agitati, o si può ritenere l’esatto contrario, ma entrambe le modalità, invariabilmente, sono riconducibili ai fenomeni di trance sciamanica (il primo caso corrisponde probabilmente alla differenza lessicale originaria).[11] È spesso possibile osservare nel Kagura una coreografia in due tempi: il primo avviene durante l’induzione del fenomeno di possessione coadiuvato da sciamane e sacerdoti addetti all’accompagnamento ritmico e musicale, e il secondo si manifesta a possessione avvenuta. Nel primo movimento, contemporaneo ai rituali di purificazione e invocazione delle divinità (le armi sorrette dagli officianti in questo momento[12] rientrano infatti tra i maggiori oggetti catalizzatori di discesa dei kami, in particolare quelli alpestri e boschivi[13]), la miko (sciamana) oscilla delicatamente finché non cade in trance, momento a partire dal quale la danza prosegue in maniera inconscia producendosi in salti e strattoni incontrollati. Si può parlare in questo caso di kamigakari (stato di trance sciamanica innescato dalla presenza di kami dotati di poteri di possessione spiritica) indotto, ma esiste anche la modalità completamente spontanea caratterizzata dalla sola odori (ed eventualmente da altre odori eseguite da uno dei sacerdoti accompagnatori, per purificare il luogo dagli spiriti maligni).[14] La struttura rituale sin qui descritta riflette certamente una modalità propria dei kamigakari quando avvenivano nei tempi in cui era assente l’elemento di espressione artistica, vale a dire quella di una progressiva perdita di controllo, ma è opportuno ricordare che, dal momento in cui questi fenomeni religiosi si sono evoluti in un’arte performativa, il fatto della “perdita di controllo” è diventato piuttosto una semplice rappresentazione della trance, che non necessariamente riflette uno stato alterato della miko che ne imita il movimento.[15] Occorre poi notare che si riscontrano forme di trance prive del processo di perdita di controllo, un altro fatto ereditato dal Kagura in particolari danze più “lievi” rispetto a quelle che intendono significare in maniera esplicita l’alterazione della coscienza;[16] quando però la scena della possessione è prevista, questa diventa il fulcro dell’intera performance e l’evento acquisisce significato in rapporto al momento fondamentale del kamigakari che viene anticipato e preparato da tutti gli altri momenti dell’evento attraverso lo sforzo collettivo.[17] Una reale alterazione di coscienza è comunque ritenuta perlopiù assente nei fenomeni contemporanei di Kagura, solo imitativi dei significati originari, pur sempre però calati in contesti di ritualità religiosa che riconoscono gli elementi sciamanici, per quanto mitigati.[18]
Anche a causa di quanto avvenuto a partire dall’epoca Meiji (1868-1912) fino al secondo dopoguerra, dunque nel contesto dell’istituzionalizzazione e supremazia del cosiddetto “Shintō di Stato”, le caratteristiche della spiritualità giapponese che sarebbero potute apparire “primitive” agli occhi delle potenze mondiali furono ridimensionate, se non del tutto cancellate, e le pratiche originanti in maniera troppo esplicita dallo sciamanesimo dei primordi furono chiaramente tra le prime vittime di questo mutamento forzato[19] (ciò non significa che elementi ancor oggi messi in primo piano nella descrizione vaga dello “Shintō”, quali le festività assai sentite dei matsuri e tutto ciò che ruota attorno ai santuari, non avessero avuto ugualmente origine nell’essenza primitiva che si tentò di cancellare). E se ciò vale per lo sciamanesimo in generale, è ancora più eclatante per quanto riguarda la forte componente di metamorfosi animale compresa in esso, un aspetto così primitivo da non poter trovare spazio nel contesto dei suddetti mutamenti storici. In tal senso ciò che è noto riguardo alle origini del Kagura costituisce un’eredità preziosa, un fossile intatto di quel mondo.
Questo mondo può essere conosciuto solo attraverso tentativi di speculazione, non essendo sufficienti le prove archeologiche che permetterebbero di far luce sui dettagli specifici della divinizzazione animale sviluppatasi nel corso dei periodi della preistoria giapponese. Analisi d’altro tipo ‒ sul mito e sulla tradizione orale, per esempio ‒ permettono però di immaginare determinate figure animali come particolarmente influenti dal punto di vista spirituale, e spesso in relazione totemica con i clan (uji).[20] Simili conoscenze possono essere integrate anche allo studio del Kagura, se si vuole ipotizzare quali categorie di animali potessero essere al centro delle danze d’estasi sciamanica che portarono alla nascita di questo genere performativo, contribuendo anche alla genesi delle altre forme teatrali. Conoscere di più sull’animale immaginato dagli antichi abitanti del Giappone colti in uno dei momenti di massima ispirazione e commistione con i kami permette di affacciarsi sul possibile significato di alcune performance e, in maniera più ampia, del genere teatrale nella sua interezza, giacché le divinità animali erano sempre rivestite di significati assai sentiti nel contesto della cosmologia percepita collettivamente al tempo.[21]
Danze di animali e zoolatria
Sappiamo che uno dei più antichi esempi di Kagura ancor oggi tramandati è quello della “danza del leone” (shishimai), che nel contesto dello Shugendō diventa un sottogenere,[22] tipico degli yamabushi (praticanti Shugendō) itineranti dell’area del monte Hayachine.[23] È indubbio che, nel caso dello Shugendō, i significati buddhisti aumentino esponenzialmente. La stessa figura del leone poi è un immediato richiamo al ruggito del Buddha,[24] all’India, e alle pratiche indiane che si è ipotizzato abbiano influenzato enormemente la diffusione estremorientale di siffatte “danze leonine”, in concomitanza con l’espansione del Buddhismo.[25] Il caso del Giappone non permette tuttavia di dichiarare esaurita la questione dell’influenza contenuta in un fenomeno di costume solamente sulla base del fatto che questo sia associato a una determinata scuola di pensiero interna al Buddhismo, tanto più nel caso dello Shugendō che costituisce uno dei massimi esempi di come nella spiritualità giapponese il sincretismo abbia regnato incontrastato prima che una percezione di stampo più “accademico” (non popolare) contribuisse a separare esperienze religiose diverse, fenomeno poi esacerbato dallo Shintō di Stato.[26] Nello Shugendō si conservò molto di antiche divinizzazioni di montagne, litolatrie e religioni naturaliste, un fatto cruciale in rapporto allo sciamanesimo giacché è molto comune trovare la montagna come axis mundi nei sistemi di pensiero associabili al termine ‒ ancor più nello sciamanesimo giapponese in cui, a differenza dello sciamanesimo “originale” della Siberia, sembra essere assente il concetto pivotale dell’albero cosmico, i cui ruoli e significati vengono tuttavia attribuiti in Giappone proprio nell’immagine della montagna.[27] Inoltre tutto ciò che ha a che fare con lo Shugendō presenta spesso un’unione armonica di mondi diversi, come esemplificano le emblematiche pratiche di sfruttamento dei poteri delle volpi del Monte Izuna, che vedono l’unione di divinità volpine indiane (Ḍākinī), di Inari, e di divinità volpine dell’arcipelago ancora più antiche.[28] Si può immaginare che quanto accaduto in rapporto alla “danza leonina” fosse molto simile: un fatto culturale continentale e buddhista si adagiò comodamente su un panorama preesistente di figure e simbologie affini, motivo per il quale l’associazione tra la danza e lo Shugendō, di per sé tendente a fenomeni di questo genere, è rimasta forte. Il fatto che la divinità celebrata presso il Monte Hayachine sia considerata “straniera”[29] passa in secondo piano se si pensa che nel far visita agli altri kami dei villaggi locali compie lo stesso movimento periodico associato a essi, consistente nella discesa dalla dimora di montagna suddivisa in tappe vicine ai nuclei abitati: le credenze associate ai comportamenti delle entità divine di qualsiasi tipo sono scivolate le une nelle altre amalgamandosi senza opporre resistenza. Considerato ciò, riesce difficile negare che ci siano aree di significato comune tra le danze Kagura specificamente preposte alla celebrazione dei kami di montagna durante la loro discesa e la shishimai apparentemente soltanto buddhista, soprattutto quando si osserva che la divinità leonina del monte degli yamabushi compie un tragitto ugualmente suddiviso in visite, ugualmente richiedendo ai partecipanti non laici di sottoporsi a preparazioni rituali fatte di tabù e fasi cerimoniali rigidamente strutturate.[30]

Che tipo di creatura era dunque il “leone”, interpretato nelle danze giapponesi eppure assente nell’arcipelago? Osservando raffigurazioni pittoriche giapponesi, molto lontane dal reale, di animali la cui esistenza poteva essere conosciuta solo attraverso la cultura continentale, si potrebbe credere che finissero per occupare, nella percezione collettiva, lo stesso scaffale dei dragoni e delle creature immaginarie, esotiche ed evocative di realtà lontane dall’esperienza concreta. È probabile che nell’immagine del “leone” fosse presente anche tale tendenza, ma l’identità della bestia in questione non poteva limitarsi a questo. Così come nel termine “wani” confluivano sia i coccodrilli sconosciuti del continente che i predatori delle acque giapponesi riveriti sin dalla preistoria in quanto divinità di primo piano,[31] la parola “shishi” indicava non soltanto il leone delle fonti indiane e cinesi, ma un insieme ampio e polimorfo di realtà concreta e di immaginario, il cui significato primario era legato all’area semantica delle bestie di terra, quadrupedi, spesso oggetto di caccia da parte delle popolazioni montane e forestali.[32] Ma come è testimoniato dai gruppi di cacciatori-raccoglitori dell’arcipelago (con esempi protratti fino a tempi relativamente recenti in aree come il Tōhoku), l’uccisione più o meno ritualizzata di un animale e la sua venerazione spesso coincidevano (e al tempo stesso esistevano casi contrari in cui vigevano proibizioni rituali sulle specie interessate).[33] La “danza del leone” preservata dal Kagura era di fatto un rito sciamanico di commistione umano-animale, e precisamente era una “danza delle bestie selvatiche”, una danza in cui si rendeva omaggio all’animale venerato, spesso in relazione a un significato propiziatorio per la riuscita della caccia, particolarmente nei casi in cui “shishi” poteva riferirsi ad animali come cervi e cinghiali (ovvero i casi in cui le tradizioni di danze celebrative o metamorfiche dedicate a taluni mammiferi selvatici, analoghe alla shishimai, palesano quanto quest’ultima sia provvista di un’ossatura autoctona, risalente alle epoche che ancora non avevano conosciuto il Buddhismo).[34]
La preparazione dell’attore che per settimane deve sottoporsi a un isolamento caratterizzato da pratiche intense di concentrazione e da precise regolamentazioni alimentari[35] ‒ sempre presenti in misura più o meno incisiva nei totemismi[36] ‒ coincide con quella di un officiante religioso, custode di particolari doti spirituali, che si prepara a fungere da perno tra due mondi, e far librare la propria anima in modo da attraversarli a proprio piacimento.[37] Una maschera viene poi collocata sull’altare, un tipico oggetto/spazio considerato idoneo alla discesa di un kami: sull’altare, è la maschera stessa, con le sue fattezze animali, a costituire il corpo della divinità, poiché il tamashiro, ricettacolo del kami, implica la presenza di quest’ultimo, e non una sua mera simbolizzazione.[38] Anche le maschere del Nō possono essere considerate “imparentate” a questi animali divini: non importa che non tutte presentino, come la maschera dello shishi diffusa anche nei testi del Nō, dei tratti animaleschi riconoscibili, poiché un certo grado di semplificazione è prevedibile in tutte le forme di espressione che attraverso degli oggetti rituali o scenici codificano forti simbolismi.[39] Ma è in quegli spettacoli di Kagura più vicini alle origini che il significato della maschera animale e del suo collocamento sull’altare si manifesta evidente, a partire dalla stessa etimologia, in entrambe le sue principali interpretazioni: Kagura è il seggio degli dei (神の倉), oppure il divertimento, il piacere degli dei, come rappresentato nei kanji 神楽 tipicamente impiegati.[40] Nel corso del rituale il kami ferino compie una discesa all’interno di un oggetto idoneo, come nella maggioranza dei rituali Shintō che prevedono la presenza del kami,[41] e ivi si fa venerare attraverso delle offerte.[42] Queste vengono recate presso l’altare decorato dalla maschera prima dell’atto finale del rituale durato diversi giorni, quando cioè il “divertimento” ricevuto consiste proprio nelle danze che lo omaggiano, ed è prevista l’entrata in scena dello shishi che fa sfoggio della sua natura animalesca con movimenti di fauci e muscolatura.[43] Secondo gli studi di Blacker che hanno approfondito le pratiche sciamaniche del Giappone, uno degli impulsi principali che possano indurre un animale a farsi venerare consiste nel desiderio di ricevere offerte:[44] un appetito e bramosia da bestia selvatica che è presente nella stessa misura della natura divina. Qualsiasi kami è infatti una commistione armonica e non contraddittoria di più nature: un’anima pacificata e un’anima furiosa,[45] un’essenza ineffabile perennemente nascosta da un lato, e una forma assai concreta dall’altro (messaggero animale, oggetto sacro, albero, intera montagna, etc.),[46] soltanto per nominare alcune di queste apparenti dicotomie. Tale natura molteplice del kami può essere intercettata dallo sciamano che conosce i passaggi tra i due mondi, e dalla collettività[47] attraverso l’atto di inscenare ciclicamente il rituale: così un’arte performativa scaturisce dalla volontà di ripetere ciò che era appannaggio di singoli individui, in momenti assai significativi per la comunità in cui si contattavano mondi diversi, la cui armonia andava preservata affinché si preservasse con essa l’intero equilibrio cosmico secondo i principi di reciprocità e interconnessione radicati indistricabilmente nella spiritualità giapponese.[48] Questo ruolo dello spettacolo, sia cioè di rituale sciamanico che di performance collettiva sostitutiva dello stesso, è osservabile per il primo aspetto in uno degli scopi della danza, ovvero di pacificazione dell’anima del kami, e per il secondo aspetto in relazione alla diminuzione degli autentici fenomeni di kamigakari dovuta alla già accennata progressiva estirpazione di elementi “primitivi” dai riti e le arti giapponesi ‒ da cui l’esigenza di trasformare il delirio visionario dell’antichità in una manifestazione artistica tradizionale che vede la partecipazione numerosa della comunità.[49] Ma in tutte le scuole di Kagura, nonostante la varietà, è possibile scorgere gli elementi sciamanici che l’avanzata del tempo e le circostanze storiche non sono riuscite a cancellare: anche in assenza di altare viene eretto un recinto e uno spazio rituale viene creato, anche in assenza di trance il momento in cui un danzatore indossa una maschera animale avrà il ruolo di imitare l’avvenuta possessione a opera della divinità discesa, e così via.[50] In tutto questo la musica di accompagnamento prevede sempre percussioni e flauti che custodiscono il potere di evocare le divinità[51], nonché la funzione di “maschera acustica”,[52] vale a dire un segnale uditivo teofanico che precede la comparsa della maschera o raffigurazione animale (forse non solo nel rituale, ma anche storicamente)[53] e che, si potrebbe ipotizzare, costituisce un analogo sensoriale della parte “nascosta” insita nel concetto di kami: in un rito religioso e in tutti i generi teatrali, la musica, solo percussiva o adornata dai fiati, manifesta la presenza in quel luogo di un kami ancora non visibile, prima che appunto riveli l’altra sua parte, quella dotata di una forma (il flauto è certamente uno strumento importante, ma il tamburo è universale nelle esperienze di trance,[54] forse per l’influenza che la ripetizione ritmica esercita sulla mente: in ogni caso nel momento dell’evocazione della divinità non può mancare qualcosa che inneschi un suono ritmico ripetitivo, come anche una campana, o l’agitarsi frusciante e percussivo di un’asta rituale[55]). La maschera poi è un oggetto paragonabile alle pelli, le parti animali, i teschi[56] che i primi sciamani adoperavano a mo’ di indumenti o accessori decorativi per impersonare l’animale con il quale occorreva ricercare un legame, per ragioni totemiche o contestuali al rito: non si può dimenticare che non si tratta soltanto di omaggiare le divinità, ma anche di diventare un kami, ed è suggestivo pensare a come questo sia imprescindibile anche nei generi teatrali lontani dal contesto rituale dei matsuri. Nel Nō l’attore diventa un dio, e il teatro è sempre in qualche misura devozione: “the first role played by man was that of a god”.[57] È noto e di facile comprensione che, in una cultura sin dal principio devota all’equilibrio insito nei ritmi naturali, gli animali ispiratori di timore reverenziale o economicamente importanti fossero tra i più immediati oggetti di divinizzazione,[58] per cui non sarebbe azzardato immaginare un contesto storico ancestrale che consenta di estendere l’affermazione sopracitata: “il primo ruolo fu quello di un animale divino”. Studiando le leggende e le pratiche giapponesi si incontrano le tracce delle lontane pratiche di teriomorfismo, in cui lo sciamano per esempio poteva trasformarsi in un uccello affinché ottenesse, grazie alla libertà di movimento rappresentata dal volo, la capacità di spostarsi fluidamente tra i piani esistenziali ed entrare in contatto con le anime dei defunti. Le “torimai”, o danze degli uccelli, sono vestigia di questo: danze che imitano l’atto del volo, ma che un tempo non erano mera imitazione[59] (si riteneva inoltre che il volo così rappresentato fosse uno dei tratti distintivi del comportamento dei kami[60]). Anche il ricchissimo folklore relativo agli animali trickster e metamorfici come la volpe, il cane procione e il serpente ‒ il più antico e importante degli animali divini ‒ è indubbiamente imparentato a quell’ancestrale importanza del teriomorfismo, sebbene abbia accolto al proprio interno significati disparati.[61]
Che lo shishi ancora celebrato nel Kagura e a teatro sia imparentato ad animali sacri dell’antichità come il cervo e il cinghiale, o che lo si faccia risalire alla bestia leonina immaginaria mutuata dalle cronache buddhiste, ha importanza soltanto contestuale: il suo nucleo invariabile è una natura divina in cui confluiscono il mondo dei kami e quello degli animali, che ai primordi dello Shintō in epoca preistorica costituivano una delle manifestazioni più dirette della presenza divina, soprattutto nei casi di categorie di animali ‒ piuttosto che di singole specie ‒ connotate per una forte relazione con l’ambiente naturale in cui comparivano, di cui erano incarnazione, in modo tale che l’avvistamento di un cervo o un cinghiale bianco[62] si traducesse, nella percezione umana di allora, in un incontro con il dio della montagna. Probabilmente anche lo shishi immortalato nella danza e nel teatro giapponese ha molto in comune con le bestie selvatiche che corrispondono ai kami di montagna: ragionando sempre per categorie di animali ampie e internamente variegate, la “bestia di terra” incarnata dal termine shishi poteva corrispondere sia a divinità agricole risalenti al periodo Yayoi (circa 300 a.C.- 300),[63] sia a divinità di montagna risalenti al ben più antico periodo Jōmon (circa 10000 a.C.- 300) e sopravvissute anche nel corso dei periodi successivi.[64] Anche prendendo in considerazione le divinità campestri Yayoi, il cui emblema è la volpe di Inari, il legame con la montagna è innegabile per innumerevoli motivi; citandone soltanto due tra i più importanti, il campo semantico della fertilità era associato tanto ai campi quanto alle montagne intese come “grembo” e oltretomba al tempo stesso,[65] e, in secondo luogo, la pratica di divinizzare esseri campestri si assestò a partire dalla credenza che le divinità di montagna annualmente compissero un tragitto discendente dalle catene montuose più lontane dal villaggio ‒ dimora degli spiriti per eccellenza ‒ attraverso varie tappe negli scenari del microcosmo giornalmente vissuto, ultima delle quali nel campo coltivato nei pressi dell’abitato.[66] Le danze, che fossero propiziatorie di una buona caccia o di un buon raccolto invocando il potere generativo della fertilità, o che avessero tutt’altro scopo, si rivolgevano a una divinità che in ogni caso doveva calare dal suo mondo selvatico di spiriti e animali, dalla sua dimora di montagna o di foresta, per collocarsi infine su un altare, all’interno di un recinto, insomma in uno spazio sacro allestito per l’occasione dagli esseri umani, che avrebbero continuato, attraverso l’arte performativa, a inscenare ciclicamente quella sacra esperienza, anche nell’epoca in cui si sarebbero perse le tracce di quella profonda percezione compenetrata ai ritmi di un mondo naturale di essenze misteriose e spettri, in gran parte dimenticato. La danza dello shishi è soltanto un esempio di questo, e si potrebbero applicare gli stessi ragionamenti alle altre figure rappresentate nel corso di queste unioni di danza, messa in scena e rito religioso. Per esempio, la rappresentazione del serpente,[67] a causa della vastità sconfinata della simbologia che lo concerne, richiederebbe un’analisi separata, ma basti ricordare come innumerevoli divinità di sorgenti montane e divinità campestri della fertilità prendano forma ofidica nelle leggende per comprendere che le stesse macroaree tematiche confluivano nelle figure animali percepite come divine e ritenute degne di essere rappresentate, spesso creature ispiratrici di timore reverenziale.[68] Non sorprende che in un particolare tipo di Kagura la trance venga rappresentata nel momento in cui la figura sacerdotale si ritrova sempre più addentro la stretta delle spire di un enorme serpente di panno, fatto strisciare in circolo dagli altri sacerdoti che lo sorreggono.[69] Indipendentemente dalle influenze Onmyōdō e buddhiste o dall’epoca di appartenenza, visti i personaggi coinvolti ‒ serpente e figura sacerdotale ‒ si può supporre che la scena sarebbe apparsa familiare anche ai popoli giapponesi di epoche molto più antiche, devoti com’erano all’aura spirituale emanata da determinate creature associate a simboli assai importanti (va da sé che col tempo si aggiungessero al pantheon celebrato dalle danze numerosissime figure, tra oni, divinità misteriose, spiriti ancestrali, figure continentali).[70]
Lo sciamano/attore e l’acquisizione di poteri
Si può prendere brevemente in esame un ultimo elemento, proveniente da un altro esempio di Kagura tra i più noti della variante Iwami originaria della prefettura di Shimane. Vi si osserva l’attore principale che brandisce un bastone e lo punta verso le cinque direzioni, di per sé una chiara influenza del pensiero cinese, e anche il gesto ricorda quello di un onmyōji, eseguito però mediante un oggetto che, calato in un contesto nipponico, non può non richiamare immediatamente anche le aste rituali[71] tipiche sia della religione popolare che dello “Shintō ufficiale”. Lo spettacolo in questione, “Gojin” (五神, “le cinque divinità”), ha numerosi titoli, e tutti fanno riferimento al numero cinque che nel sistema di pensiero cinese è associato alle direzioni dello spazio e ai cinque elementi che costituiscono la materia[72]. Nello spettacolo inoltre vi è un’associazione tra quattro di queste direzioni e le quattro stagioni, poiché viene narrata una contesa tra un kami e i suoi quattro fratelli maggiori che presiedono alla gestione, tra loro equamente ripartita, dei giorni dell’anno, fisicamente collocati nei punti indicati dal bastone; alla fine dello scontro il fratello minore ottiene i giorni “doyō”, corrispondenti alla mezza estate.[73] Se imbattendosi in questa narrazione pantomimica la si volesse contestualizzare, ciò sarebbe possibile a partire da tradizioni religiose diverse: Onmyōdō, Shintō, Buddhismo (quanto a quest’ultimo, si pensi per esempio ai Cinque Buddha o ai Cinque Grandi Re della Saggezza 五大明王della tradizione esoterica, noti anche come guardiani direzionali), ma, indipendentemente dal punto di riferimento scelto, rimane il fatto che nello spettacolo di Kagura sia presente un forte elemento di acquisizione di poteri. I quattro fratelli che siedono su quattro direzioni e quattro stagioni, infatti, siedono anche, per il sistema di associazioni culturali che fa da retroterra alla narrazione, sulle energie elementali. Non è strano che una danza di origine sciamanica metta in scena simili tematiche: lo sciamano è di per sé una figura che in virtù della propria speciale ricettività nei confronti di determinati fenomeni può ottenere dei poteri.[74] Nel caso giapponese il fattore della “acquisizione” (non predisposizione) è ancor più incisivo per quanto riguarda il tipo di estasi di origine buddhista, in cui sottoponendosi a pratiche ascetiche o di concentrazione si ottengono delle capacità accessibili solo attraverso siffatti percorsi di intensa autodisciplina spirituale.[75] È bene ricordare a questo punto che, prima che le politiche dello Shintō di Stato imponessero a livello nazionale una separazione netta e violenta tra Buddhismo e Shintō, la percezione popolare non operava la stessa distinzione: per un individuo in difficoltà desideroso di rivolgere una preghiera a una divinità non esisteva sostanziale differenza ontologica tra, per esempio, un bodhisattva e un kami locale, dunque la scelta era condizionata soltanto da fattori contestuali;[76] allo stesso modo uno sciamano erede della tradizione più antica, uno yamabushi o un onmyōji potevano svolgere un’identica funzione di contatto con spiriti o entità di grande potere, fatto in ragione del quale è possibile parlare dell’esperienza sciamanica giapponese considerando come sue parti fondamentali tanto l’estasi delle miko quanto le esperienze di estasi extracorporea cui lo yamabushi accede attraverso un preciso allenamento.[77] Ciò che distingue l’officiante (sciamano o yamabushi) di un rito di possessione o di generale comunicazione con degli spiriti è la capacità unica di mettersi in collegamento con gli altri mondi, attraversando il “ponte”.[78] È facile comprendere come la sua interconnessione ‒ tra mondo umano e mondo spirituale, oppure tra vivi e morti, o in numerosi altri sensi ‒ si potesse rappresentare attraverso la tematica della padronanza degli elementi, come avviene nel testo in questione.
Conclusioni
La modalità ancestrale di percepire il rapporto con la natura, per le popolazioni giapponesi dalla preistoria all’età premoderna, prevedeva la possibilità che mondi separati, pur sempre in eterna interconnessione, sfociassero l’uno nell’altro: lo si vede anche nelle cronache storiche, dove ciascun clan rivendica la discendenza da una divinità, poiché un essere umano illustre ‒ o in possesso di poteri di visione e spostamento extracorporeo, come uno sciamano o, in un certo senso, un attore ‒ può diventare un dio, e lo si vede nelle innumerevoli leggende di metamorfosi o di matrimoni interspecifici che danno origine a stirpi il cui sangue è condiviso da creature divine.[79] Queste tematiche, materiale dei pilastri sui quali si sorreggeva l’intera visione del cosmo, ritornano costantemente in tutti i fenomeni culturali assieme agli altri fondamenti del pensiero collettivo (quali la reciprocità e l’essenza inquinante dell’impurità, con annessa necessità di debellarla ritualmente). Esse naturalmente confluirono anche nell’insieme di pratiche all’origine delle arti performative e teatrali, messe in scena più volte con un preciso scopo di riaffermare tutte le necessità dell’essere umano in rapporto al suo posto intermedio nella cosmologia. Tenendolo a mente, anche in una modernità derubata dello spirito si potranno comprendere le ragioni della passata percezione di presenza divina assistendo a una danza e osservandone le maschere, e si potrà forse trovare un senso diverso a quel trasporto quasi trascendentale provato durante il climax di un dramma di teatro altamente sofisticato, un senso non limitato alla filosofia estetica della recitazione. Un senso attraverso il quale anche nell’attore, nella sua maschera e nella sua gestualità, si scorgeranno sacri animali della foresta, o una tra le innumerevoli ripetizioni dell’originaria ispirazione che colse la dea Ama no Uzume nell’occasione della sua prima danza, madre di tutte le arti performative;[80] in ogni caso, deve essere sempre possibile intravedere la presenza ‒ o i suoi fugaci indizi ‒ delle divinità che, discendendo da un mondo di spiriti e animali ispiratori di timorata devozione, prendono dimora temporanea negli umani e nel loro mondo.

Bibliografia
AVERBUCH Irit, “Shamanic Dance in Japan: The Choreography of Possession in Kagura Performance”, Asian Folklore Studies, vol. 57, no. 2, 1998, pp. 293-329. JSTOR, https://doi.org/10.2307/1178756 (visitato 2/12/2023)
BLACKER Carmen, The Catalpa Bow: A Study of Shamanistic Practices in Japan, Allen & Unwin, Londra, 1975
BREEN John, TEEUWEN Mark, Shinto in History: Ways of the Kami, Curzon Press, Richmond (Surrey), 2000
CASAL U.A., “The Goblin Fox and Badger and Other Witch Animals of Japan”, Folklore Studies, vol. 18, 1959, pp. 1–93. JSTOR, https://doi.org/10.2307/1177429 (visitato 4/12/2023)
HERBERT Jean, Shinto at the Fountainhead of Japan, Allen & Unwin, Londra, 1967
HORI Ichirō, Folk Religion in Japan, The University of Chicago Press, Chicago, 1968
HORI Ichirō, Nihon no Shamanizumu (日本のシャマニズム), Kōdansha, Tōkyō, 1971
IWAMOTO Yutaka, SAKAMOTO Yukio (traduzione, a cura di), Hokkekyō; ge (法華経‐下), Iwanami Shoten, Tōkyō, 1991
IMMOOS Thomas, “The Birth of The Japanese Theater”, Monumenta Nipponica, vol. 24, no. 4, 1969, pp. 403-414. JSTOR, https://doi.org/10.2307/2383881 (visitato 2/12/2023)
KNIGHT Catherine, “The Moon Bear as a Symbol of Yama: Its Significance in the Folklore of Upland Hunting in Japan”, Asian Ethnology, vol. 67, no. 1, 2008, pp. 79-101, JSTOR, http://www.jstor.org/stable/25135287 (visitato 4/12/2023)
KNIGHT John, “On the Extinction of the Japanese Wolf”, Asian Folklore Studies, vol. 56, no. 1, 1997, pp. 129-59. JSTOR, https://doi.org/10.2307/1178791 (visitato 4/12/2023)
KNIGHT John, Waiting for Wolves in Japan: an anthropological study of people-wildlife relations, Oxford University Press, Oxford, 2003
LANCASHIRE Terence, “‘Kagura’ ‒ A ‘Shinto’ Dance? Or Perhaps Not”, Asian Music, vol. 33, no. 1, 2001, pp. 25-59. JSTOR, https://doi.org/10.2307/834231 (visitato 2 Dec. 2023)
LEVI-STRAUSS Claude, Totemism, Merlin Press, Londra, 1962, translated by Rodney Needham (edizione originale: Le totémisme aujourd’hui, PUF, Paris, 1962; trad. it. Il totemismo oggi, Feltrinelli, Milano, 1964)
MIYAKE Hitoshi et al., “Japanese Mountain Religion: Shrines, Temples and the Development of Shugendō”, Cahiers d’Extrême-Asie, vol. 18, 2009, pp. 73-88. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/44167433 (visitato 4/12/2023)
NAKAMURA Ikuo, MIURA Sukeyuki, Shinkō no Naka no Dōbutsutachi (信仰の中の物たち), Yoshikawa Kōbunkan, Tōkyō, 2009
RAVERI Massimo, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia, 2006
TANIGAWA Ken’ichi, Kami Ningen Dōbutsu: denshō wo ikiru sekai (神・人間・動物: 伝承を生きる世界), Kōdansha, Tōkyō, 1986
VILLANI Paolo (a cura di), Kojiki: un racconto di antichi eventi, Marsilio, Venezia, 2006 [711-712, Ō No Yasumaro]
WALKER Brett, JAPANimals: History and Culture in Japan’s Animal Life, Center for Japanese Studies, The University of Michigan, Ann Arbor, 2005
YANAGITA Kunio, HAGIN MAYER Fanny (a cura di), Nihon Hōsō Kyōkai (a cura di), The Yanagita Kunio Guide to the Japanese Folk Tale, Indiana University Press, Bloomington, 1986
“Shinto Symbols”, Contemporary religions in Japan, vol. 7, no. 1, 1966, pp. 3-39. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/30232983 (visitato 4/12/2023)
NOTE
[1] Immoos 1969, p. 404.
[2] Lancashire 2001, pp. 25-59.
[3] Breen e Teeuwen 2000, p. 43; Herbert 1967, p. 27.
[4] Immoos 1969, p. 411.
[5] Immoos 1969, pp. 411-412.
[6] Blacker 1975, pp. 21-22.
[7] Blacker 1975, pp. 19-84, pp. 164-251.
[9] Immoos 1969, p. 404.
[10] Averbuch 1998, p. 294.
[11] Averbuch 1998, p. 297.
[12] Averbuch 1998, p. 297.
[13] Miyake 2009, pp. 74-75.
[14] Averbuch 1998, p. 297.
[15] Averbuch 1998, p. 298.
[16] Averbuch 1998, pp. 298-299.
[17] Averbuch 1998, p. 304
[18] Averbuch 1998, pp. 298-299.
[19] Breen e Teeuwen 2000, p. 41; Tanigawa 1986, pp. 4-5; Knight 2003, p. 217; Walker 2005, pp. 13-14.
[20] Shinto Symbols 1966, p. 12, p. 16; Tanigawa 1986, p. 17, pp. 203-204; Casal 1959, p. 89; Breen e Teeuwen 2000, p. 34; Nakamura e Miura 2009, p. 23, pp. 78-80, p. 91.
[21] Breen e Teeuwen 2000, p. 34; Nakamura e Miura 2009, pp. 1-10; Tanigawa 1986, pp. 3-5.
[22] Immoos 1969, pp. 408-409.
[23] Averbuch 1998, pp. 312-313.
[24] Iwamoto e Sakamoto 1991, p. 55. Questo esempio tratto dal sedicesimo capitolo del Sutra del Loto è solo uno tra tanti.
[25] Immoos 1969, p. 408.
[26] Blacker 1975, p. 33; Averbuch 1998, p. 294, p. 300, p. 306, p. 308.
[27] Blacker 1975, p. 27; Hori 1968, pp. 175-179.
[28] Blacker 1975, p. 55; Casal 1959, p. 22; Nakamura e Miura 2009, pp. 85-87.
[29] Averbuch 1998, p. 313.
[30] Averbuch 1998, p. 313, p. 318; Immoos 1969, p. 410.
[31] Nakamura e Miura 2009, pp. 20-33, pp. 39-40.
[32] Immoos 1969, p. 408; Nakamura e Miura 2009, p. 17, p. 80; Knight C. 2008, pp. 83-89.
[33] Knight C. 2008, pp. 83-89, p. 94.
[34] Immoos 1969, p. 408.
[35] Immoos 1969, p. 410.
[36] Knight C. 2008, p. 84, p. 94; Nakamura e Miura 2009, pp. 33-37; Levi-Strauss 1962, p. 23.
[37] Blacker 1975, p. 25, p. 35; Hori 1971, pp. 64-65.
[38] Immoos 1969, p. 407.
[39] Immoos 1969, p. 407.
[40] Averbuch 1998, pp. 294-296; Immoos 1969, p. 408.
[41] Miyake 2009, pp. 74-75; Blacker 1975, pp. 38-39.
[42] Immoos 1969, p. 408.
[43] Immoos 1969, p. 408.
[44] Blacker 1975, p. 52.
[45] Blacker 1975, pp. 43-46.
[46] Shinto symbols 1966 pp. 3-39.
[47] Averbuch 1998, p. 302.
[48] Nakamura e Miura 2009, p. 6; Tanigawa 1986, p. 3, p. 13.
[49] Averbuch 1998, pp. 294-296.
[50] Averbuch 1998, p. 296.
[51] Averbuch 1998, p. 296.
[52] Immoos 1969, pp. 406-407.
[53] Immoos 1969, p. 407.
[54] Blacker 1975, p. 25.
[55] Averbuch 1998, p. 297.
[56]Immoos 1969, p. 407; Knight J. 1997, p. 141.
[57]Immoos 1969, p. 411.
[58] Tanigawa 1986, p. 28; Breen e Teeuwen 2000, p. 34; Nakamura e Miura 2009, p. 23, pp. 78-80, p. 91.
[59] Nakamura e Miura 2009, pp. 18-19; Blacker 1975, p. 33.
[60] Averbuch 1998, p. 311.
[61] Tanigawa 1986, pp. 3-4; Casal 1959, p. 24; Raveri 2006, p. 326; Blacker 1975, pp. 51-52.
[62] Villani p. 106, p. 108.
[63] Nakamura e Miura 2009, p. 80.
[64] Nakamura e Miura 2009, pp. 80-81; Tanigawa 1986, p. 17.
[65] Miyake 2009, pp. 74-75; Hori 1968, pp. 164-166, p. 173, p. 178.
[66] Breen e Teeuwen 2000, p. 44;Tanigawa 1986, p. 205; Knight C. 2008, pp. 82-83; Hori 1968, p. 151.
[67] Averbuch 1998, p. 300, p. 303; Immoos 1969, pp. 411-412.
[68] Nakamura e Miura 2009, pp. 80-82; Tanigawa 1986, pp. 203-204.
[69] Averbuch 1998, p. 303.
[70] Averbuch 1998, pp. 306-307.
[71] Blacker 1975, pp. 38-39.
[72] Lancashire 2001, p. 25.
[73] Lancashire 2001, p. 25.
[74] Blacker 1975, pp. 21-22.
[75] Blacker 1975, pp. 21-23, pp. 235-251.
[76] Blacker 1975, p. 33.
[77] Blacker 1975, pp. 21-23, pp. 164-185.
[78] Blacker 1975, pp. 19-33.
[79] Tanigawa 1986, pp. 14-15, p. 35; Herbert 1967, pp. 23-31; Blacker 1975, pp. 34-35; Nakamura e Miura 2009, pp. 22-23, pp. 33-37, pp. 79-80; Villani 2006, pp. 74-75; Yanagita e Hagin Mayer 1986, pp. 124-143.
[80] Villani 2006, p. 48; Immoos 1969, pp. 413-414.