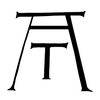Per gentile concessione del TTB, pubblichiamo questo estratto dal libro di Renzo Vescovi, “Scritti dal Teatro Tascabile” a cura di Mirella Schino, Bulzoni Editore 2007.
Il Sapore della Danza
Introduzione di Mirella Schino
L’India, per Renzo Vescovi e il Tascabile, fu, in primo luogo, la ricerca di una tecnica precisa e articolata e di un sapere teatrale superiore alla frequente approssimazione occidentale. È stata una scoperta tecnica e culturale insieme, l’incorporazione di un sapere che con gli anni andava sempre più approfondendosi. Capitava con relativa frequenza che Vescovi ne parlasse, o ne scrivesse. In genere, però, sempre per una qualche necessità: che poteva essere la presentazione di uno o più spettacoli, l’orchestrazione di una trasmissione televisiva, o l’intervento ad un convegno. Si tratta in linea di massima di un sapere coltivato con cura e con passione, ma esplicitato soprattutto in situazioni di necessità.
Qui, sotto il titolo Il sapore della danza (che è un titolo dello stesso Vescovi) abbiamo riunito diversi scritti: c’è Il sapore della danza, un insieme di materiali di supporto, di spiegazioni per spettatori ignari (preparato in occasione del festival dallo stesso titolo organizzato dall’IXO-Istituto di Cultura Scenica Orientale e dal Teatro Tascabile di Bergamo nell’estate del 1981, e poi pubblicato, insieme a L’attore lirico, in Necessità e libertà. Il lavoro dell’attore e il lavoro del regista, a cura di Alfredo Chiappori, “Quaderni del Comballo”, Lecco, ed. del Comballo, 1993), e lo abbiamo integrato con la trascrizione parziale di tre trasmissioni televisive, dedicate all’Orissi (1979, e 1982), al Bharata Natyam (1979 e 1981) e al Kathakali (1988), e di un intervento orale (A|ha\rya abhinaya, poi pubblicato in Mascheramenti. Tecniche e saperi nello spettacolo d’Occidente e d’Oriente, a cura di Paola Bignami, Roma, Bulzoni, 1999).
Sono stati mescolati insieme, dunque, interventi diversi (ma accomunati tutti dalla loro natura di presentazioni di base), interventi nati talvolta come testi scritti, e talvolta, invece, come discorsi, nei quali è ancora possibile, (soprattutto nelle parti dedicate al Bharata Natyam e al Kathakali) ritrovare giri di frasi tipicamente orali, o quella forma più approssimativa che è tanto necessaria ad un discorso non scritto.
Si tratta insomma di interventi pensati, comunicati o scritti in forme e occasioni molto diverse, ma con una finalità unica, che rende plausibile e a nostro parere opportuna una loro unificazione: sono interventi per lo più dei primi anni Ottanta, quando il lavoro sull’India era ancora agli inizi, e soprattutto sono interventi tutti di presentazione, pensati per un pubblico, o per lettori non competenti.
Uno dei più illustri storici della danza occidentale, Arnold Haskell, ha sinteticamente definito la danza indiana “il più completo e il più espressivo di tutti i sistemi di danza”. Sarebbe, questo autorevole giudizio e la realtà cui esso fa così perentorio riferimento, ragione sufficiente a giustificare qualsiasi attività volta a promuoverne la conoscenza: e tuttavia può essere anche più interessante accennare alle diverse motivazioni che spingono oggi a queste indagini alcune fra le forze più ricche della ricerca teatrale contemporanea.
Di fatto, nella presente, assai complessa crisi del teatro occidentale, l’evoluzione della cultura scenica nelle sue forme più vive e interessanti mostra una crescente convergenza fra ciò che ancora usa, parlando, dividere nelle due categorie del teatro e della danza.
Da un lato si assiste, nella danza occidentale, a un progressivo avvicinamento a quanto più propriamente sembra potersi chiamare “recitazione”, e dall’altro la concezione dell’attore appare sempre più legata, al di là della pura comunicazione verbale cui in genere viene limitato il suo ruolo, ai fondamenti corporei della sua arte specifica.
Come è noto questa recentissima tendenza ha precedenti illustri e addirittura antichissimi nella grande cultura del teatro orientale in cui i due aspetti sono tradizionalmente fusi così come è codificato da duemila anni nel Nāṭyaśāstra, la Bibbia del teatro indiano.
A questa tradizione il teatro occidentale, che vi ha spesso attinto nei momenti di crisi, si è accostato sempre con un misto di ammirazione e di impotenza.
Così mentre gli orientali, con estrema plasticità artistica, hanno trasformato differenti “tradizioni locali”, per esempio europee, in categorie assolute (producendo ottimi cantanti d’Opera, eccellenti direttori di filarmoniche e così via), il mondo occidentale ancora non ha osato infrangere i tabù culturali che lo separano dallo studio concreto della musica e del teatro-danza orientali.
Eppure questo accostamento non sembra casuale: da una parte esso è l’esito naturale, una possibile concretazione o specificazione tecnica del processo innescato a suo tempo da quel teatro che scelse di fare del corpo lo strumento privilegiato della sua espressione (con doveroso riferimento, almeno, alla rivoluzionaria esperienza di Jerzy Grotowski); dall’altra, l’acuirsi del disagio della civiltà, e il sempre più avvertibile senso di alienazione che essa produce hanno fatto considerare l’esperienza orientale e il suo prezioso retaggio un possibile correttivo del crescente squilibrio, un punto di riferimento essenziale nel fosco pericolo di smarrimento, se non proprio di sparizione, che attualmente ci minaccia. È dunque una tendenza assai diffusa e profonda che è andata ramificandosi bene addentro al tessuto più vivo della nostra cultura nelle zone contigue della crisi delle ideologie, dell’utopia ecologica, della riscoperta del corpo, del rifiuto, insomma, del modello consumistico che ha dominato, in modo confuso e vitale, la cultura giovanile a partire, in modo particolarmente vistoso, dagli anni Settanta.
Non intendiamo ora affrontare veramente la complessità di un problema cui ci siamo limitati ad alludere: ciò che importa è che questo interesse non si inaridisca nel ricorrente dilettantismo esotico alla moda, ma fiorisca in qualche attenzione produttiva o, almeno, in qualche studio o lavoro concreto.
A questo studio, se non, magari, lavoro, questo Sapore vuol essere un invito, e le note che seguono sono redatte per facilitarne l’avvio.
Occorre precisare che l’angolazione da cui questa esperienza è vista viene qui esplicitamente circoscritta al momento della metodologia tecnico-artistica del teatro. Volutamente viene dunque tralasciato ogni riferimento alle implicazioni e ai riferimenti più specificamente filosofico-religiosi e anche più lautamente culturali cui la materia è, per universale e vulgato riconoscimento, intimamente legata. Confidiamo che la nostra impostazione abbia una sua legittimità anche in questa così ridotta prospettiva: quello che qui si vuol fornire è solo qualche informazione di base che permetta di accedere con meno disagio a una realtà di cui è lecito affermare che è insieme più vicina o più lontana di quanto non si creda.
Nella grande varietà e specificità delle differenti tradizioni locali è possibile trovare qualche essenziale carattere comune che ci permetta di enunciare alcune regole cardine del teatro-danza orientale.
La maggior parte di esse sono esplicitamente esposte nei trattati classici sull’argomento, fra i più noti dei quali vanno citati almeno il Nāṭyaśāstra e l’Abhinaya Darpaṇa.
Il modo più diretto per accostarsi all’universo del teatro-danza classico è forse quello di considerarne una possibile partizione secondo i fondamentali concetti di danza pura (nṛtta) e di recitazione (abhinaya), con particolare riferimento a quella sorta di linguaggio di alta stilizzazione mimata che tecnicamente viene chiamato nṛtya o danza espressiva.
La recitazione (“abhinaya”)
Nella puntigliosa formalizzazione della cultura scenica tradizionale indiana, il sintetico termine di abhinaya (recitazione) riassume l’esito finale di un processo cui concorrono svariati elementi a loro volta nitidamente individuati e dettagliatamente descritti. In particolare, assolutamente essenziale per la comprensione del concetto appare il riferimento alla stretta interazione delle quattro categorie fondamentali della āṅgika abhinaya (che concerne l’uso del corpo), vācika abhinaya (l’uso della voce), āhārya abhinaya (uso del costume e del trucco) e infine sāttvika abhinaya (l’elemento psicologico o il dato interiore della recitazione). Ciascuna di esse è poi scomponibile in diverse classi e sottoclassi con partizioni minori e sub-articolazioni ricchissime che ai livelli minimi divengono praticamente infinite.
Tutte le quattro categorie concorrono obbligatoriamente a costituire la particolare caratteristica dell’abhinaya, ma in diversa misura e con diversa incidenza nei differenti generi teatrali. Così, per esempio, nel nāṭya, o teatro letterario, maggiore enfasi è ovviamente posta sul vācika o elemento vocale, mentre nel teatro di danza, tradizionalmente definito nrtya, viene privilegiata l’ āṅgika, la categoria che concerne specificamente l’uso del corpo. In questo caso si è avuta una sorta di consapevole scissione dell’elemento vocale da quello espressivo corporeo che ha portato alla formazione di due universi linguistici autonomi e paralleli attraversati da numerose articolazioni connettive.
Da una parte il linguaggio si è fatto parola musicata suscettibile di sfocare il suo nucleo semantico in puro suono ritmato, dall’altra la danza si aggrappa tenacemente al valore semantico attraverso il ricorso all’espressione pantomimica: con un grado di stilizzazione che a tratti dissolve il dato imitativo in segni così convenzionalizzati da identificarsi in pratica con l’arbitrarietà assoluta di un linguaggio ignoto (cosicché per lo spettatore ordinario, anche indiano, essa finisce dunque, in certo modo, per identificarsi con la danza pura).
Così nella pratica scenica attuale il testo, musicato e cantato, che un tempo neanche molto lontano era affidato all’attore-danzatore, è abitualmente eseguito dall’orchestra, mentre il danzatore appare più ampiamente impegnato nel suo ruolo specifico: e sia pure in stretta connessione con la parte vocale e strumentale con cui intrattiene un rapporto assai complesso.
La danza espressiva (“nṛtya”)
La tecnica di relazione fra linguaggio verbale e la danza si manifesta in due momenti: uno è quello diretto e assai rigido del pada artha abhinaya, o traduzione letterale di ogni parola del testo nel particolare linguaggio coreografico impiegato; l’altro è quello che potremmo definire approssimativamente una tecnica contrappuntista che gioca esplicitamente col testo, alludendovi in modo dichiarato con messaggi complementari o variamente sinonimici o magari antitetici e utilizzando tutti i possibili congegni della retorica coreografica.
La danza che fa riferimento a un testo preesistente o che comunque intende esprimere specifici messaggi attraverso l’uso del corpo viene definita, come abbiamo detto, nṛtya o danza espressiva. Individuato come strumento essenziale di comunicazione, il corpo è stato segmentato in diverse parti e di ognuna di esse si è formalizzato l’uso potenziale all’interno dei singoli sistemi o stili di danza.
Così, per esempio, nei trattati classici sono scrupolosamente indicati i possibili movimenti del capo o del volto, nel suo complesso e nelle sue diverse parti, con i viniyoga o significati relativi.
Tra le varie parti del corpo di cui si specifica l’uso nella precettistica scenica classica, particolare rilievo hanno assunto, come è largamente noto anche in Occidente, le mani. Ampiamente citata è a questo proposito la sintetica e capitale indicazione dell’Abhinaya Darpaṇa secondo cui “il canto deve essere ben tenuto con la gola, il sentimento mostrato con lo sguardo, il ritmo marcato dai piedi. Dovunque la mano va la segue lo sguardo, dove va lo sguardo lo segue il pensiero; dove il pensiero va il sentimento lo segue, e dove va il sentimento lì c’è il Sapore” (rasa: il culmine dell’esperienza artistica secondo la terminologia dell’Estetica indiana). Alle mani, la particolare caratteristica del teatro indiano conferisce dunque un’importanza senza riscontro in altre culture (e che era antropologica e sacra prima di essere scenica). Le mani agiscono in una sorta di autonomia narrativa e coreografica che stabilisce, anche spazialmente, un piano intermedio fra l’attore e lo spettatore. Esse esercitano esplicitamente una doppia funzione: da una espongono i contenuti narrativi secondo la citata tecnica nṛtya, dall’altra esse forniscono lo stimolo sensoriale destinato a provocare la risposta espressiva dell’attore assolvendo dunque a una funzione determinante nel processo della recitazione. Nell’abhinaya le mani (che in questa specifica funzione teatrale sono tecnicamente chiamate hasta) esercitano il loro ufficio attraverso un linguaggio convenzionalizzato alla cui origine è verosimile ipotizzare un probabile processo di estrema rarefazione di elementi mimetici di base. Non è qui il caso di addentrarci nelle particolarità dei segni che ne compongono l’alfabeto, ma occorre menzionare che ciascuno di essi è atto a convogliare un numero di significati che possono variare, a seconda delle differenti scuole, da alcune unità a diverse decine e perfino centinaia.
In realtà non conviene far troppo caso ai numerosi esempi sbalorditivi che possono essere prodotti, né insistere sul carattere ermetico di quel linguaggio.
Di fatto la base pantomimica, levigata da una sistematica stilizzazione che ne ha filtrato le impurità realistiche, è sufficiente ad assicurare la comprensione essenziale del materiale narrativo allo spettatore dinamico: cui basta fornire elementari informazioni sul contesto particolare. Quello che importa e che ne costituisce il grande patrimonio tecnico e l’enorme autorità metodologica, come vedremo, è la nitida individuazione, l’estrema rifinitura di ciascuno dei differenti segni di cui si serve questo sofisticato sistema teatrale.
Il “sāñcarī bhāva” o “improvvisazione”: mito e realtà
Può apparire una singolare contraddizione il fatto che, nell’universo della più rigida prescrizione e un posto di fondamentale importanza debba spettare all’“improvvisazione”: per quanto occorra specificare subito che la vulgata traduzione del concetto di sāñcarī con questo vocabolo merita bene le virgolette con cui viene stampato.
Di fatto occorrerà circoscrivere il termine al suo reale valore, cominciando a precisare, intanto, per dovere d’informazione, che qui esso viene usato col senso che assume nel gergo tecnico della concreta pratica teatrale odierna e non nel significato teorico che gli affida l’ordinata strutturazione piramidale della teoria scenica classica. Nella teoria esso indica infatti lo stato psichico transitorio, una vitale connotazione, un prezioso accessorio degli elementi psichici fondamentali che individuano un personaggio o una situazione.
Con una piccola forzatura semantica il termine viene ora invece impiegato a indicare la riesposizione sinonimica di un enunciato o addirittura la sua intera rielaborazione in nuclei narrativi completi che da esso si dipartono verso una progressiva e totale autonomia. Per dare un esempio che potrà forse meglio chiarire il procedimento, esaminiamo brevemente la struttura compositiva di una splendida creazione per recital del Guru Maya Dhar Raut ispirata alla sesta lirica del Gītagovinda.
Si tratta di qualche decina di secondi della prima parte.
La composizione inizia col ritornello in cui Rādhā, la protagonista, si rivolge alla compagna invitandola a condurle l’amato dio Kṛṣṇa per dilettarsi con lui nei piaceri d’amore. Seguendo la tecnica nṛtya del pada artha abhinaya il testo di Jayadeva, messo in musica e cantato, viene tradotto alla lettera, parola per parola, secondo il particolare stile di danza, che nel nostro caso è Orissi. Così la coreografia prevede che al ritmo della musica scelta la danzatrice esponga col linguaggio del corpo nelle sue varie parti (āṅgika abhinaya) il corrispettivo delle parole 1) ramaya (dilettarsi nell’amore), 2) mayā (me), 3) saha (insieme con), 4) madana (Cupido), 5) manoratha (che fa smarrire): naturalmente seguendo la costruzione del testo originale sanscrito. La danzatrice incomincia dunque suggerendo 1) la tenerezza dell’abbraccio, e prosegue indicando 2) se stessa, 3) giungendo davanti a sé le mani atteggiate in una forma particolare, 4) scagliando il dardo mortale di Eros e mostrandone infine 5) l’immagine divina nell’atto di imbracciare il famoso arco di fiori. Abitualmente il canto prosegue esponendo il testo in forma continuata, ma qui scatta invece il momento del sāñcarī bhāva. Testo e musica ripetono continuamente la stessa sequenza: Rādhā si perde nel desiderio di Kṛṣṇa e continua a danzare la sua preghiera offrendone fino a sei diverse varianti. La danzatrice espone dapprima sinonimi del testo originale e poi se ne scosta via via con evocazioni sempre più autonome nelle quali, interpretando ora Kṛṣṇa ora Rādhā, mostra il crescendo della seduzione del dio fino al momento in cui, in una vampata di rossore, si avvede del seno ignudo che Kṛṣṇa ha appena liberato, con un inganno, dalla fascia che lo celava.
A questo punto il sāñcarī finisce e la danza continua sviluppandosi in accordo coi versi della poesia e riallargandosi a tempo debito in altri e più importanti sāñcarī di analoga struttura compositiva. Come si può dunque vedere, il termine di “improvvisazione” con cui viene tradotto il nome di questo importante momento tecnico risulta piuttosto approssimativo. In realtà qui “l’improvvisazione” è un brano coreografico perfettamente strutturato dal compositore che l’interprete non fa che eseguire con la stessa meticolosa cura di quanto illustra o “traduce” le parole del testo nel pada artha abhinaya.
Da quanto esposto non si ricaverebbe dunque altro che una ennesima riprova della secca dichiarazione attribuita a Martha Graham secondo la quale “l’improvvisazione non esiste”. E tuttavia, per quanto riguarda il teatro orientale, l’affermazione dell’artista americana va almeno temperata e per ragioni che ne ribadiscono l’altissimo valore metodologico. In verità, proprio la rigorosa formalizzazione del linguaggio scenico permette squarci di reale improvvisazione inimmaginabile in altre culture (o dovrei dire piuttosto pratiche) teatrali.
Stretta come si trova a essere fra gli altri argini delle leggi ritmiche che ne regolano l’esecuzione e la rigida strutturazione linguistica del suo alfabeto, la forza dell’ispirazione artistica può più facilmente conservare la sua energia incanalandola nel preciso nitore dell’immagine poetica invece che disperderla sfocandosi nella velleità dei conati interrotti.
La danza pura (“nṛtta”)
Abitualmente uno spettacolo di danza classica indiana si compone di una collana di vari pezzi estratti alternativamente dal repertorio della danza espressiva o da quello della danza pura.
L’avvio è in genere una forma di preghiera danzata che, con nomi diversi nei differenti stili, introduce al rito poetico della rappresentazione. La parte centrale, il suo cuore, è uno spiegarsi del ventaglio delle emozioni e dei sentimenti nei differenti brani di abhinaya.
La conclusione è invece un particolare pezzo di danza pura (nṛtta). La sua collocazione privilegiata e la fattura particolarmente squisita di questi pezzi invitano a un’analisi più ravvicinata di questa categoria fondamentale del teatro classico indiano.
Per cominciare dalla sua nascita divina, nella notte dei tempi, occorre sapere che il veneratissimo dio Śiva, dopo aver assistito al primo spettacolo messo in scena dal saggio Bharata (l’autore del citato Nāṭyaśāstra, l’illustre trattato che ci racconta questa vicenda) su un’idea o un testo dello stesso Brahmā, pensò che insomma lo spettacolo ci avrebbe guadagnato con l’aggiunta o l’incorporazione della danza pura di cui era il riconosciuto inventore. Sia Brahmā che Bharata accettarono l’osservazione di Śiva e da allora il teatro orientale ha preso la forma che lo caratterizza. Naturalmente l’ingenuità del racconto non riesce a semplificare l’enorme complessità della concezione di un teatro siffatto: e un’eco vi si avverte nella traccia di un dibattito che ogni tanto pertinacemente riaffiora in tempi e regioni così distanti e che ha appunto in tre versi del IV capitolo del Nāṭyaśāstra la sua prima formulazione conosciuta.
Gli intellettuali si volgono a Bharata e volentieri riconoscono l’importanza della recitazione, “ma” aggiungono “non riusciamo a capire perché tu vi abbia incluso la danza pura, dal momento che non esprime nessun significato particolare”. Risponde Bharata: “Devo ammettere che la danza pura non ha significati particolari. Devo anche aggiungere che essa nasce senza una specifica ragione e senza ragione è amata da tutti”.
Viene dunque ipotizzata una sorta di necessità biologica della danza, come se questi movimenti organizzati rispondessero a un bisogno umano antropologicamente fondato; come se la cessione spontanea di una sovrabbondanza di energia vitale consegnataci dal codice genetico trovasse nella danza il suo esito naturale. Da questo deriva la nota identificazione della vita colla danza che sotto diverse forme viene affermata, lungo tutta la sua storia, in ogni cultura del pianeta. Questo è naturalmente il senso dell’immagine famosa di Nāṭyaśāstra nelle sue vesti di nāṭarāja, di re, appunto, della danza. È infatti parso agli indiani che questo singolare alternarsi di luce e di tenebre, di vita e di morte, di dolori e di gioie che è la vita umana, altro non fosse, immaginosamente, che la danza di un essere supremo, di un danzatore cosmico il cui corpo fosse l’universo, la cui voce fosse la musica delle sfere celesti, i cui gioielli fossero la luna e l’intero firmamento. Così la base stessa di questo teatro, il supporto di ogni ulteriore specificazione drammaturgica è il dinamismo biologico in se stesso, che la danza esprime e, reciprocamente, alimenta.
Il teatro-danza orientale nasce quindi nel cuore stesso del crogiuolo della fucina vitale, e i materiali che va dunque piegando e ribattendo per organizzarli in forma artistica hanno la torrida incandescenza del magma originario da cui sono prelevati.
Questa rifondazione “shivaita” del teatro letterario di Brahmā offre l’occasione di un possibile parallelo con l’attuale fase della ricerca scenica in Occidente.
La trisecolare storia artistica e il costume del teatro tradizionale europeo con la logica sociale etica e culturale che essi sottendono, e che così chiaramente essi riflettono, in tempi così mutati e ormai tanto diversi hanno per molti esaurito la loro spinta feconda. Di fronte a questa crisi così clamorosamente irrimediabile, la soluzione non poteva che essere radicale: come periodicamente accade, lo smarrimento delle certezze concettuali ha indotto ad aggrapparsi alla realtà più innegabilmente concreta dei corpi; al frigido galateo culturale del teatro si è preferita la goffaggine della pulsione viscerale; la prostituzione dell’attore ai piedi del pubblico è stata rovesciata nel martiri dell’attore santo; il costume sociale del teatro come intrattenimento è stato deviato su occasioni più condecenti. Questo avvicinamento inconsapevole alle radici stesse della grande tradizione scenica orientale deve ora far tesoro della sua esperienza bimillenaria.
“Il teatro orientale nasce nei templi, il teatro occidentale nei postriboli”, diceva Jacques Copeau. Certo, a partire da una sintesi storica così asciutta sembrerebbe che la distanza fra le due esperienze risulti assolutamente incolmabile.
Ma la nascita, pur essendo evento capitale, non pregiudica tutto intero lo sviluppo di una vita.
Forse ora ci sono meno templi in India, e forse meno ce ne saranno, come progressivamente sta accadendo per le chiese occidentali. C’è chi se ne duole, come è giusto, e chi pensa che dopo tutto il più vero tempio dell’uomo, quello che più importa custodire e preservare, sta nel fondo del suo cuore.
Che questa osservazione venga ribadita dal vaporoso spiritualismo umanista occidentale non fa, naturalmente, meraviglia, ma che avrebbe detto Copeau a sentirselo dire con fede e amarezza da un’autorità della cultura orientale come Mulk Raj Anand?
“È vero che la nostra arte è ancella della nostra religione, ma ora la fede appare sempre meno sentita e realmente vissuta; e d’altro canto l’arte non può essere lasciata a coloro che ne fanno un pretesto per una bella serata con gli amici: il suo futuro forse sarà nei nuovi templi che potremo costruire sotto forma di teatri e di centri culturali…”.
Allora forse non sarà questa o quella corrente religiosa a prevalere, ma l’intensa consapevolezza di coloro che possono leggere dietro i simboli di ogni fede il senso delle proprie battaglie spirituali. E forse il solo modo per salvare la bellezza (è lei che salverà il mondo, dichiarava Dostoevskij!) è quello di sottrarla agli acri fumi dei santuari e alla volgarità dei rituali del dopo-teatro per consegnarla al tabernacolo dell’interiorità personale.
Due avvertite volontà di riforma radicale e di alta tensione spirituale vanno convergendo da poli opposti verso la religione contemporanea della poesia.
Ed è su questo piano, il piano dell’arte, che fruttuosamente la fresca rivoluzione del teatro del corpo può incontrare l’antichissima tradizione orientale.
La sua battaglia più forte, sul piano della dignità del mestiere, che è quello tecnico della recitazione, il teatro tradizionale occidentale deve ingaggiarla collo psicologismo della sua troppo tenace tradizione realistica. Tecnicamente questo significa un riassorbimento delle efflorescenze psicologiche nella asciutta discrezione dei muscoli. L’attore soccombe sotto il peso del suo compito quando cede alla tentazione di “parere” che nell’arcaica accezione del vocabolo fa coincidere la debolezza del mostrare colla goffa conseguenza del sembrare. In realtà tutta la recente tradizione anti-teatrale del suo lavoro congiura contro di lui. Il suo compito è quello di trattare l’aria e di abbracciare fantasmi. Uno sconosciuto abitatore di altri mondi, uno scrittore, ha generato, con nascita partenogenetica, creature senza corpo che ha poi imbrigliato con le reti fonetiche e sintattiche dei ritmi verbali. Con queste creature si chiede al povero attore una sorta di impossibile connubio raggelato da una dichiarata inessenzialità del suo corpo totalmente negletto, cui il contatto con il fantasma poetico viene completamente evitato quasi si trattasse di una mera fleboclisi mentale. Dovendo manovrare la materia troppo fluida di questi sentimenti allo stato puro senza argini e senza chiuse, qual meraviglia che egli venga sopraffatto e annaspi scompostamente nella piena della confusione dilettantistica.
Il problema è dunque di imbrigliare la corrente di queste acque: se non che, il compito non può essere affidato alla insufficiente tecnica psicologica i cui esiti hanno la breve persistenza di segni tracciati sull’acqua. E se ancora il teatro occidentale non ha accumulato tanta carica vitale da rovesciare in danza i suoi dialoghi raziocinanti (come non ricordare il grande Mejerchol’d al cospetto di Sada Yacco, la mitica attrice giapponese: “E così conquistò il pubblico. Non con le battute né con la mimica né con altri accorgimenti, ma solo quando fuse la sua recitazione con l’orchestra”), certo può accogliere le suggestioni fondamentali di una tecnica che ferma nella precisione del corpo gli impulsi disordinati della psiche.
Ed ecco che allora acquista un senso chiudere questi riferimenti al teatro occidentale proprio nel paragrafo dedicato alla danza pura.
Perché, naturalmente, come noi oggi sappiamo che il segreto della pittura o della scultura non si svela nel realismo della copia ma si annida nelle pieghe dei panneggi o nella morbidezza delle luci, consiste, insomma, nella distribuzione dei rapporti di energia cromatica e spaziale, così sarà forse lecito sostenere che il fascino dell’attore consiste nella trama di impulsi che viene a configurarsi nello svolgimento della sua azione scenica. E quando questi elementi cominciano il loro gioco dinamico le cariche si attivano sempre più, abbandonando progressivamente i presupposti realistici da cui hanno preso le mosse fino a coincidere, al culmine del loro processo, con una sorta di danza pura il cui ultimo senso è quello di bastare a se stessa.
Nel crescendo di questo vortice, le immagini sonore e visive si frantumano fondendosi in una emulsione sottile che penetra nell’organismo progressivamente alterato dello spettatore attraverso i mille pori della percezione. Qui si scatenano una serie di rispondenze segrete e di collegamenti misteriosi, attivando una vasta eco di ripercussioni e di risonanze interiori, determinando il prodigioso innesco di mille gangli percettivi, mobilitando l’intera nervatura psichica con le sue intricate connessioni di cultura e riflessi organici, finché, a un tratto, tutto l’essere, corpo e anima, non prende a sommuoversi ribollendo con forza inarrestabile e rovesciandosi infine tutto intero nell’esplosione di una progressiva fioritura di vibrazioni che si ramificano nelle più remote periferie nervose, increspando le terminazioni più sottili, serpeggiando in oscuri canalicoli sotterranei, riverberandosi nel guscio attonito di ogni emisfero cellulare. Questi subitanei fiotti che sgorgano lentamente da mille contemporanee fessure e ignote scaturigini ricolmano, fluendo ininterrotti, uno spettatore progressivamente trasmutato, inondandolo di un calore diffuso di origine inafferrabile in cui si mescolano, fondendosi, tracce di ricordi, di esperienze e di desideri: reagendo alle precise sollecitazioni e all’ipnosi segreta dei movimenti ritmici della danza, l’organismo risponde con un quieto sconvolgimento che si irradia nella psiche pervadendola come un gusto o un profumo: è il sapore della danza.
L’Orissi
Ci sono ore del giorno che sono magiche o particolarmente suggestive. Una di queste è certamente il crepuscolo. Gli indiani lo chiamano Sandhym e lo raffigurano come una tenera cerbiatta, figlia di Brahmā, che fugge per il cielo inseguita dal padre incestuoso. È l’ora dei prodigi ed è l’ora in cui si svolgono le principali cerimonie religiose. Quando la campana le dà il segno che il momento è arrivato, una sacerdotessa si incammina per un vialetto nascosto del Tempio, si inoltra fino al suo cuore e lì, davanti all’immagine del dio, esegue la sua danza. È un modo di pregare delle antiche sacerdotesse indiane, le devadāsī, le serve degli dèi. Durante la danza, la danzatrice versa dalle sue mani i fiori che ha raccolto in atto di offerta e di sottomissione. Quando la preghiera è finita, ella prende l’immagine del dio e lo ripone a dormire per la notte, come fosse una creatura umana. Questa che un tempo era considerata una danza sacra, oggi è diventata una danza classica e dall’India si è sparsa per tutto il mondo come un patrimonio comune dell’arte universale. In particolare la danza che noi abbiamo appena visto (un brano di un maṇgalacharan con Sanjukta Panigrahi) è originaria della regione di Orissa, uno Stato dell’India orientale cui non è esagerato dire che si devono molte caratteristiche della danza classica Orissi: la sua mollezza, il suo abbandono, la sua certa sensuosa eleganza richiamano certamente la fecondità, la dolcezza e la mollezza di queste terre, di queste acque, di questi verdi, di questo paesaggio dolcissimo. Nella regione di Orissa esiste una particolare forma di religione, l’induismo, che è rivolta al dio Jagannātha, che ha il suo celebrato tempio nella città di Puri, che in pratica vive poi di questo tempio. Qui ne vediamo una parte essenziale che è il śikhara, la grande torre. E il dio Jagannātha è, dicevo, una divinità molto complessa che in sé riassume e fonde diversi momenti della storia religiosa indiana, che ne fa in pratica una sorta di aspetto del dio Kṛṣṇa, una delle incarnazioni di Viṣṇu. Proprio il particolare rigore e il particolare esclusivismo in questa religione ci hanno fermato sulla soglia del tempio, come questo cartello documenta, e da lì abbiamo spiato se era possibile intravedere l’immagine di Jagannātha. Che per altro devo dire non è un’immagine proibita perché anzi è molto diffusa, è possibile trovarla in molti altarini improvvisati, su cui compare questo singolare dio dalla figura molto rozza, di cui la leggenda dice che si tratta di una scultura eseguita su un vecchio tronco. L’artefice era uno scultore divino il quale interruppe a metà la sua opera perché molestato dalla curiosità indiscreta della moglie del re.
Le devadāsī, le sacerdotesse, legate al culto di Jagannātha, si chiamano Mahari. Ancora oggi in Orissa esistono alcune vecchissime Mahari che oramai però non esercitano più la loro funzione e questo per la profonda modificazione cui il culto è andato soggetto negli ultimi anni, come accenneremo fra poco.
Come è successo per altre danze classiche indiane, anche Orissi è passata dal tempio alla scena con una modificazione profonda del suo statuto. La codificazione precisa della danza è avvenuta per Orissi non più tardi di venti, venticinque anni fa. Prima, di questa danza si ignorava il nome. Naturalmente la danza esisteva, ma era un atto di culto svolto all’interno dei templi. Fuori, non si poteva vedere. Venti, venticinque anni fa, come dicevo, si è avuto uno storico meeting, cui hanno partecipato studiosi e i più valenti Guru dello stato di Orissa, che sono quattro, e dal loro incontro è avvenuta la codificazione precisa di questo stile. In mancanza di altri nomi, si è chiamato Orissi, dal nome dello Stato, si è rapidamente diffuso in India con una fortuna travolgente che l’ha fatto conoscere in tutto il mondo. Una caratteristica essenziale di questo stile, come si è visto, è il riferimento alle pose scultoree che ne intessono così fittamente il linguaggio. In particolare il monumento, il vocabolario pietrificato della danza Orissi si trova nel tempio di Konarak, fatto costruire da un grande re della dinastia dei Gaṇgā e che contiene nelle sue sculture tutte le pose di danza che ora servono come riferimento tecnico all’Orissi.
In brevissimo tempo, Orissi ha goduto di un’espansione assai forte che ne ha fatto rapidamente una delle danze classiche indiane più apprezzate e studiate in patria e nel mondo.
Come tutte le altre danze classiche indiane anche Orissi, pur conservando l’impronta religiosa delle sue origini, è ora diventata un fatto essenzialmente artistico. E benché possa talvolta ancora, in particolari occasioni, essere danzata nei templi, in realtà il suo luogo più conveniente è ora quello più laico del palcoscenico dei teatri.
Il repertorio Orissi
La vitalità della tradizione di Orissi ha portato in breve tempo a un’evoluzione rapidissima di quello che solo da qualche anno può essere effettivamente definito “repertorio”.
Nell’Orissi, la danza veniva presentata come un lungo brano di una quarantina di minuti preceduto, da un’invocazione e chiuso da un pezzo di danza pura in tempo prestissimo. Questo blocco unitario, attraverso successive dissimilazioni, è arrivato infine ad articolarsi nella forma di recital che viene presentata attualmente.
Uno spettacolo di danza Orissi è ora composto di una collana di brani di diversa ampiezza e natura. Dopo una sorta di preludio consistente in una preghiera propiziatoria danzata (maṅgalacharan), la rappresentazione prosegue alternando momenti di danza pura o nṛtta (nello stile Orissi abitualmente chiamati pallavi) a momenti di danza recitata (abhinaya) e conclude generalmente con il Mokṣa, un pezzo di danza pura, vero e proprio gioiello coreografico elaborato dalla tradizione.
La pallavi è una composizione di immagini di grande fascino visivo. La danzatrice sviluppa, una sequenza dopo l’altra, movimenti, pose e passaggi coreografici completamente fusi con la melodia ritmata che l’accompagna.
Appartenente alla categoria nṛtta della danza pura, la pallavi non ha altro significato, per usare la terminologia tipica del teatro indiano, che l’espressione della bellezza delle linee e della forma.
Molte delle pose statuarie che ne costituiscono un’importante caratteristica sono prese dai rilievi di danza che si trovano in gran numero nei templi di Konarak e Bhubaneshwar in Orissa.
Il nome di pallavi, che letteralmente significa “elaborazione”, è in genere specificato dal rāga in cui è composto e che ne detta anche, conformemente alla natura della musica classica indiana, il particolare carattere.
Al rāga si riconnette il breve frammento di “danza espressiva” da cui la pallavi può essere talvolta introdotta. Esso evoca i tratti essenziali del rāga poeticamente personificato (così, per esempio, il rāga Vāsanta, o della Primavera, è mostrato attraverso le immagini degli alberi che fioriscono, degli uccelli che cantano, dei germogli che spuntano ai nuovi tepori, mentre sul risveglio del creato domina sovrano Ka\ma, l’Amore, che saetta tutt’intorno col suo arco di fiori).
Gli abhinaya (pezzi recitati) sono ispirati ad alcune fra le più belle liriche del Gītagovinda.
Kutiyattam (teatro sanscrito classico)
Kutiyattam significa letteralmente “recitare insieme”. Si può partire dal nome per rilevarne la specificità rispetto ad altre due forme, di cui conviene fare menzione per tratteggiarne le caratteristiche: si tratta del celebre Kathakali, la più nota forma, in Occidente, di teatro classico indiano, e del meno conosciuto Chakyar Kūttu. Sono, queste, alcune fra le più illustri testimonianze del rigoglio teatrale di una fecondissima regione dell’India Sud-Occidentale, il Kerala.
Schematizzando in modo un po’ rozzo, si può ipotizzare una sorta di linea evolutiva che partendo dal Chakyar Kūttu arriva al Kathakali passando, appunto, attraverso il Kutiyattam.
Il Chakyar Kūttu, “danza (o dramma) del Chakyar”, è una forma di rappresentazione eseguita da un membro della casta dei Chakyar (i discendenti dei mitici sūta, o cantastorie, ricordati nel Mahābhārata), riservata, nella tradizione, agli induisti delle caste più elevate e presentata nel kūttampalam, lo speciale teatro di cui alcuni templi sono appositamente dotati. Lo spettacolo, che si tiene di regola il pomeriggio, consiste nella lettura di un pezzo classico sanscrito che viene ampiamente e liberamente commentato nella lingua locale, il malayalam, con allusioni piene di umorismo spesso pungente alle vicende locali, politiche e di costume. Nel corso dello spettacolo, che è un “a solo”, il Chakyar interpreta i diversi personaggi attraverso l’azione mimica e in certi momenti arriva addirittura a veri e propri momenti di danza elementare.
Assai celebre è la straordinaria padronanza dei mezzi espressivi del corpo con particolare riguardo al volto (al Chakyar si attribuisce la capacità di ridere con un occhio e insieme di piangere con l’altro). La sua recitazione è commentata e sottolineata, in particolari intervalli, dal suono da un gigantesco tamburo di rame, il mizhāvu, e da cembali metallici percossi da una donna, in genere la moglie del suonatore di tamburo. Quando gli attori (un tempo i Chakyar: ora, da pochissimi anni, l’appartenenza alla casta non è più una condizione necessaria) sono più d’uno, magari con la partecipazione di attrici, allora il Chakyar Kūttu, l’“a solo”, diventa un “recitare (o danzare) insieme”, che in malayalam suona, appunto, Kutiyattam: esso è unanimemente ritenuto la più antica forma oggi esistente di teatro classico basato sulle regole esposte nel Nāṭyaśāstra.
Secondo la tradizione, l’origine dell’attuale struttura del Kutiyattam si fa risalire al re Kulaśekhara-varman, della dinastia dei Perumal, vissuto intorno al decimo secolo della nostra era. Aiutato dal suo ministro, l’espertissimo Tolam, egli trasformò la sofisticata recitazione dei capolavori estetico-religiosi della tradizione sanscrita in spettacoli di più ampia popolarità con alcune modificazioni sostanziali. La più decisiva fu certo l’introduzione del Vidūṣaka, una sorta di clown che commenta in malayalam, con calcolati interventi parodie e digressioni lo sviluppo dell’azione principale. Secondo la tradizione, il Kutiyattam viene rappresentato non come divertimento o svago, ma come pratica religiosa, in particolari festività. Proprio la rottura di queste regole che gli hanno permesso di presentarsi dovunque, anche al di fuori dei templi, hanno ottenuto al Kathakali (che al Kutiyattam deve la maggior parte delle sue caratteristiche) la più larga fama e diffusione di cui gode (accanto a questa va menzionata un’altra differenza fondamentale: la presenza delle attrici, caratteristica singolare nella scena orientale, propria del solo Kutiyattam).
Misurare questo teatro col metro della concezione occidentale dello spettacolo provoca subito qualche perplessità.
La struttura ordinaria richiama quella, citata, del “Kūttu”, per cui un verso viene prima declamato, poi varie volte ripetuto attraverso l’uso di uno specifico linguaggio gestuale: già questa piccola informazione ci permette di indovinare le conseguenze sul piano della durata: uno spettacolo di Kutiyattam si sviluppa infatti, nel più celere dei casi, nell’arco di almeno qualche giorno e può arrivare, nel caso di alcuni testi particolari, a qualche centinaio di rappresentazioni continuate. Lo spettacolo viene abitualmente tenuto dopo le dieci di sera e dura dalle tre alle sei ore consecutive.
Dopo una prima notte di auspici e preghiere e una seconda di antefatto, è la volta della facoltativa presenza del Vidūṣaka, che può durare per due notti: e finalmente, la quinta notte, lo spettacolo vero e proprio può cominciare.
Due assistenti reggono un sipario colorato, i tamburi attaccano a rullare: piano piano, abbassando la cortina con le mani, l’attore comincia a mostrarsi e quindi, rimosso definitivamente il sipario, acconciato coi tratti dell’eroe che dovrà interpretare, fa la sua definitiva comparsa e prende a declamare il suo primo verso. La dizione della poesia sanscrita del Kutiyattam obbedisce a regole assai precise. La pronuncia è molto lenta, le parole vengono enunciate sillaba per sillaba e l’intonazione è guidata da specifici riferimenti musicali. A questo scopo sono impiegati speciali rāga, o melodie recitative, che vengono scelti in rapporto alle diverse caratteristiche dei singoli momenti.
Ci sono rāga per l’amore fra alcuni personaggi e rāga per l’amore fra altri, rāga per le descrizioni della pioggia e rāga per l’uccisione dei malvagi.
Altri artifici, noti alla tecnica della dizione universale, sono poi alcune particolarità come la pronuncia volontariamente blesa o balbuziente o variamente caratterizzata per sesso età e professione.
Lo stesso puro suono delle parole, indipendentemente dal loro significato, viene poi sottolineato e variamente utilizzato. Così, in un famoso esempio, l’apostrofo di Arjuna al protagonista di Subhadrādhananjaya, mentre egli si aggira sperduto nella foresta, è di prima avvertito come lo sciabordio delle acque del lago poi come il gracidare delle rane: questo innesca un momento di abbandono alle memorie remote del protagonista che da bambino si divertiva a torturarle crudelmente: finalmente il suono ripetuto viene interpretato in modo corretto. Anche il testo, infine, viene spesso alterato con il ricorso a una sorta di linguaggio maccheronico in vista, naturalmente, di studiati effetti comici.
Il dato linguistico così trattato attraverso la voce viene poi ampiamente analizzato approfondito e rielaborato tramite un uso particolarissimo del linguaggio del corpo. Alla prima enunciazione il senso è affidato alle parole in se stesse: per questo, secondo precise indicazioni del Nāṭyaśāstra, la musica tace. Poi il tema verbale è variamente svolto in diverse maniere. Ogni parola viene riesposta una prima volta attraverso il linguaggio delle mani (i celebri mudrā o, come più correttamente va detto, hasta). Questa esecuzione è assai precisa e analitica: espone non solo i nuclei semantici principali ma ogni altro elemento linguistico: il tempo, il modo, il plurale, il genere, il livello stilistico e così via. Dopo la ripetizione del verso segue una più ampia elaborazione che prende spunto da vari elementi del testo. Un esempio potrà forse meglio rendere l’idea di questo processo compositivo. Nel primo atto del dramma già citato, al protagonista accade di salvare l’eroina senza conoscerne l’identità: subendone poi il fascino chiede a se stesso chi mai sarà colei
la cui bellezza ferisce il suo cuore e i cui occhi, luminosi come fiori di loto freschi, addolciti dal kajal che li sottolinea, sono ancora più belli per lo spavento che li fa tremare. Orbene, ad elaborare questi due versi, l’attore che interpreta il ruolo di Arjuna consacra almeno tre ore.
Arjuna ricostruisce nei particolari una scena da boudoir, con le ancelle che vestono e truccano la padroncina finché l’opera d’arte della sua bellezza non è completata col tocco mancante del kajal che le restituisce il compiuto splendore di quegli occhi. Dopo aver chiuso l’intero giro della elaborazione parte per parte, l’attore prosegue col secondo verso (o con la seconda metà di quello appena illustrato) con lo stesso procedimento Un altro elemento da cui prende spunto l’elaborazione è l’analisi etimologica della parola, che può dar luogo, anche qui, a innumerevoli sviluppi. Si prenda ad esempio un famoso passo dell’opera di Bhāsa, Abhiṣeka-nāṭaka, che prende spunto da un episodio del Rāmāyana. Sugrīva, il fratello esiliato del re delle scimmie, Bālī, deve salutare il grande eroe Rāma e gli si rivolge col nome di Deva (“divino”). L’apostrofe si trasforma in una sorta di narrazione in cui vengono evocate le gesta di Rāma a partire dai suggerimenti della radice “div”, che nella fattispecie sono quattro: felicità, splendore, desiderio, scherzo.
Così egli mostra il momento in cui l’eroe abbatté i sette grandi alberi con un solo tiro del suo arco e quanto egli fu “felice” per questo; poi ripete “deva” e suggerisce che per chi ha compiuto un’impresa così straordinaria non sarà che uno “scherzo” uccidere Bālī e così via.
Secondo un carattere proprio di molta parte del teatro orientale, il trucco del Kutiyattam è assai elaborato (anche se più semplice di quello, universalmente celebrato, del Kathakali, che ne è un complesso sviluppo). Il trucco si differenzia per tipi di personaggio di cui individua gli elementi fondamentali: così, per esempio, gli eroi sono tipi “paccha”, o verdi: hanno cioè il volto ampiamente tinto di verde (il colore del nobile, del buono e del giusto) e rilevato dal chuṭṭi, una sorta di lama bianca, lievemente falcata ottenuta con un particolare impasto di calce e riso, disposta in senso perpendicolare alle guance e fissata in coppia, con un mastice speciale, lungo la linea della mandibola. Caratteri malvagi, come Ra\vana, sono invece del tipo “katti”, o coltello, che aggiunge al verde della regalità un segno rosso, in forma appunto di coltello, e due piccole sfere bianche aderenti alla fronte e alla punta del naso.
Il repertorio tradizionale consta di tredici drammi con un complesso di settantadue atti: la menzione degli atti non meraviglierà una volta ricordata l’ampiezza di messinscena di questa forma teatrale: non è un caso che siano i nomi dei singoli atti a dare, in realtà, il titolo agli spettacoli presentati di volta in volta. A questa base, nel corso dei secoli e dei decenni, si sono peraltro aggiunti altri grandi monumenti della poesia sanscrita, fra cui la celeberrima Śakuntalā di Kālidāsa, il dramma classico più noto alla cultura occidentale.
Molti di questi testi, unitamente ai Kramadīpika, i manuali tecnici di recitazione, sono gelosamente custoditi dalle famiglie dei Chakyar. Queste singolari caste di attori sono ora protette dal governo indiano, ma le diciotto famiglie originarie, ridottesi a sei negli anni Sessanta, sono ora gravemente minacciate di sparizione.
Recentemente, nel 1965, il Kutiyattam fu rimesso in valore grazie alla prestigiosa scuola governativa del Kalamandalam, che invitò ad aprire questa speciale sezione uno dei grandi discendenti della tradizione, il maestro K. Rama Chakyar.
Bharata Natyam
Oltre duemila anni fa, nel Tamil Nadu, una regione dell’India del Sud, c’erano delle danzatrici sacre che vivevano nel tempio e che la sera facevano sempre una sorta di rito che consisteva nel versare alcuni petali di fiori e un pugno di riso di fronte all’immagine del Dio, suonare una campanella e bruciare dell’incenso davanti a essa, prima di prenderla e riporla a dormire per la notte come se fosse una creatura umana. Parte integrante di questo rito notturno e solitario era una danza che la sacerdotessa faceva davanti all’immagine del Dio senza nessun altro spettatore che naturalmente il Dio stesso. Questa danza, attraverso molti cambiamenti, è quella che oggi noi possiamo rintracciare nel filone che si chiama Bharata Natyam. “Bharata” ha varie spiegazioni, ma una delle più convincenti è che questo è un acrostico, una fusione di tre sillabe diverse che sono “bha”, bhāva, il sentimento; “ra”, rāga, la melodia; “ta”, tāla, il ritmo: cioè il sentimento espresso attraverso la melodia e il ritmo. “Natyam” significa danza e teatro, sicché è il teatro della danza fatta attraverso il ritmo e la melodia. Questo è grosso modo il significato della denominazione di questa danza. Possiamo vederlo immediatamente partendo da una lezione in cui vengono scomposti alcuni dei suoi elementi essenziali.
Naturalmente ogni lezione di danza indiana inizia con un saluto sacro che è fatto toccando la terra, la madre terra a cui si chiede scusa di essere calpestata e si finisce con i tre saluti: in alto, agli dèi; sulla fronte, al Guru e sul petto ai compagni o meglio alla parte divina che è nei compagni.
L’insegnante si ripropone di rintracciare gli elementi essenziali dell’Alarippu, che significa “aprirsi del fiore”, una immagine singolarmente calzante, perché il corpo si desta parte per parte, proprio come un fiore che schiude i suoi petali sul far del mattino. Fra gli elementi essenziali ci sono le posizioni. Le posizioni possono essere denominate dal tipo di rapporto che hanno i piedi o dal modo di tenere la testa, gli occhi e così via. In questo caso si prende come riferimento il corpo nel suo insieme, questi si chiamano pāda bhēda, sono le posizioni del corpo. La trattatistica classica ne enumera, fra varie discussioni, diciotto.
Caratteristica della danza Bharata Natyam è un’estrema precisione di linee, un’architettura assolutamente nitida e quasi spigolosa. Quello che viene mostrato adesso è uno dei karaṇa. Ora, i karaṇa sono delle posizioni mitiche che sono scolpite in due templi del Tamil Nadu, la regione dell’India da cui questa danza proviene. Si parla dei karaṇa come le basi originali di tutti i movimenti della danza orientale. Un karaṇa implica un particolare assetto del corpo, una particolare posizione dei piedi, delle gambe, una particolare forma delle mani, questo per esempio è un karaṇa che allude a Kṛṣṇa, di cui si mostra che tiene il serpente con la mano sinistra e con la destra, intanto che con uno dei piedi ci danza sopra. Questo è Śiva, il grande danzatore cosmico, è uno degli dèi più popolari della religione induista e una delle sue caratteristiche è di essere nāṭarāja, cioè il re, il rajah della danza. Ecco, questa particolare posizione è quella di Śiva Nāṭarāja, Śiva mostrato nell’atto in cui danza e con la sua danza crea il mondo e ne assicura il ritmo. Kṛṣṇa, dio dell’amore, è un’altra divinità popolare che appartiene a un filone parallelo della cultura indiana che è quello vaishnava, e la sua innamorata, si chiama Rādhā ed è il simbolo stesso della femminilità e dell’amore.
Ogni parte del corpo ha un suo particolare allenamento. Tutti gli esercizi vengono fatti in modo meccanico, in modo da dare una specie di scioltezza a tutte le singole parti del corpo che vengono interessate. Pensate che ci sono decine e decine di movimenti soltanto per quanto riguarda la testa e il volto. Una delle caratteristiche del Bharata Natyam è l’inclinazione del corpo in avanti, il che gli permette di avere sempre una tensione continua, di non riposarsi mai, quindi di non essere mai abbandonato. Ciò provoca una reazione, una tensione immediata che si avverte quando guardiamo la danza.
Ci sono poi movimenti del capo. Secondo i trattati ce ne sono nove, ma in realtà ciascuno di essi ha poi una serie di sottosezioni per cui alla fine diventano parecchie decine. La danza implica ritmo e implica movimento. Il movimento è assicurato dalle particolari unità di base che vengono chiamate adavus, e che si fanno risalire ai mitici karana. Il lungo training di chi impara il Bharata Natyam si consuma i primi tempi danzando per decine e decine di ore soltanto queste unità ritmiche di base che sono gli adavus, ma è estremamente importante; non è possibile immaginare un danzatore che non abbia una padronanza completa di questi elementi essenziali. In generale gli adavus sono mostrati a tre differenti velocità, ciascuna il doppio della precedente. Il che implica un’estrema padronanza di tutti i movimenti che entrano nella composizione coreografica unitaria. Anche durante l’esecuzione dell’adavus il corpo deve mantenere l’assetto particolare del Bharata Natyam, che implica una specie di tensione che va dalle vertebre lombari fino al capo, in modo che il busto ha una sua tensione che non viene mai meno anche quando tutto il resto del corpo si fa estremamente morbido. Queste unità si fondono in superiori unità coreografiche che sono oramai già delle micro-danze. E così entriamo nel cuore di un’altra danza che appartiene sempre alla sezione di cui stiamo occupandoci adesso che riguarda il momento della danza pura, quello che i trattatisti chiamano nṛtta: un pezzo che si chiama jātisvaram: insieme di jāti (cioè di momenti ritmici) e di svara (cioè di note). Il ritmo ha due momenti essenziali. Il primo si chiama teermanams e viene sostenuto da un fuoco di sillabe ritmiche che richiede una particolare abilità da parte del nattuvanar, il conducente, il direttore della piccola orchestra di Bharata Natyam. Dopo un momento ritmico così pronunciato e così violento c’è come un momento di riposo e poi il ritmo prende una sorta di ordine in crescendo, per cui le pause vengono a essere in numero sempre minore, e invece si accresce la complessità e la ricchezza della coreografia di base con ritmi che sono sempre più complessi e sempre più intricati. Questo particolare tipo di Bharata Natyam (Bharata Natyam è un nome complessivo che riguarda in realtà altri elementi di danza) sarebbe più corretto chiamarlo sadir, dicono i tecnici, viene in generale eseguito in forma solistica, o in coppia, e in questo caso la coreografia elementare provvede a una specie di bilanciamento fatto in ossequio alla simmetria così tipica della tradizione culturale induista. L’ultima danza si chiama tillana, un nome generico, il nome generale di una danza che ha delle caratteristiche specifiche e che in generale viene messa in coda come chiusa di uno spettacolo di Bharata Natyam. C’è una ragione profonda per questo: è come se il danzatore, che ha fino ad allora investito tutte le sue forze in quell’evocazione della vita che è in generale uno spettacolo di danza indiana, bruciasse ora tutte le energie che ha conservato nell’ultimo respiro di questa danza.
La tillana è un momento di alto virtuosismo tecnico, è il momento, nell’ambito della danza pura, più complesso dal punto di vista tecnico, ritmico e coreografico, ed è però un atto di estrema dedizione in cui il danzatore brucia le sue energie fino all’ultimo respiro. Non meraviglierà quindi di vedere che in chiusa alla tillana, dopo una breve sospensione di qualche secondo, c’è di nuovo un maṇgalam, cioè un canto devozionale che in generale è eseguito non più come una danza ma attraverso la lenta forma del saluto rituale finale, con cui la danzatrice di nuovo si dedica agli dèi a cui ha aperto la sua danza.
Trucco e poesia nel teatro Kathakali
Vorrei sostenere e suffragare quanto andremo dicendo intorno alle caratteristiche del trucco nel teatro classico indiano (qui parlerò dello stile Kathakali) con un paio di documenti.
Il primo è l’elaborazione del trucco professionale ordinario con cui un attore del TTB-Accademia delle forme sceniche sta preparandosi per la circostanza. Il secondo è un filmato che abbiamo girato con la Rai quindici o sedici anni fa. Questi documenti sono indispensabili: come diceva Bertrand Russel, le parole non danno l’idea del formaggio se uno non ne ha un’esperienza extra-linguistica. Il film che vediamo presenta una danza del Sud dell’India, il Kathakali (è nata nel Kerala, sulla costa del Malabar, India Sud-Occidentale, e ha raggiunto lo forma che oggi vediamo, più o meno quattro secoli fa), che qui viene analizzata in alcuni suoi passaggi. Uno di questi passaggi sarà particolarmente dedicato al trucco: esso arriverà dopo dieci-quindici minuti dall’inizio, ma tutto quello che vedrete potrà essere utile.
Intanto io devo rifarmi, con la necessaria cautela, alla relazione che mi ha preceduto e non oso entrare nella dialettica di giganti tra natura e cultura instaurata da Baudelaire. Ma appena è stato fatto il riferimento al dandismo baudelairiano, subito mi è venuta in mente una sua famosa poesia, Une charogne, in cui Baudelaire parla di una fanciulla bellissima. Il protagonista si rivolge alla sua innamorata in modo esplicitamente sospiroso: “[…] étoile de mes yeux, soleil de ma nature, / vous, mon ange et ma passion […]”. Un giorno tu sarai come l’infame carogna che abbiamo visto allora, “au détour d’un sentier”: “[..] Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride / d’où sortaient de noirs bataillons / de larves […]”. La puzza che emana dal tuo cadavere è così forte che io temo di venir meno.
È certo molto affascinante e questo però riflette la violentissima ostilità di Baudelaire verso l’elemento femminile naturale che lo porta poi ad accentuare, viceversa, ovviamente, tutto il mascheramento artificiale che predica come l’unico riscatto possibile: la menzogna è la sola salvezza rispetto ad una realtà della vita che altrimenti sarebbe insopportabile, nella sua crudezza reale.
Naturalmente questo riferimento all’artificialità è obbligatorio, invece, nella cultura artistica. In essa tutto è assolutamente arti-ficiale: spezzo la parola in due perché arti-ficiale deriva da una radice di ascendenza indoeuropea, più o meno greca, “AR”, che implicava grosso modo l’organizzazione di un’idea di ordine attraverso la tecnica, e che ritroviamo come radicale in parole come “arma”, “aratro”, “arto” eccetera. Poiché il teatro è un manufatto, tutto quello che gli pertiene risulta, con diverse caratteristiche, “arti-ficiale”: questo nell’arte orientale, naturalmente, in primis, ma anche nel linguaggio scenico di qualche valore che si presenti anche oggi sulle scene di tutto il mondo.
Un’analogia particolarmente calzante, per spiegarmi meglio, potrebbe essere quella del discorso poetico. Quando lo stile è in versi e usa parole di un codice conosciuto, per esempio la lingua italiana, queste parole possono avere un significato, ovviamente, ma non si presentano nella loro nudità di portatrici di significato. Si presentano nella loro complessità, nella loro ricchezza di senso – più-suono, – più-ritmo, una diversa serie di componenti (per questa ragione la chiamo orchestrale). Naturalmente sarebbe diverso dire “mi è sempre piaciuta questa collina solitaria” e dire “sempre caro mi fu quest’ermo colle”. È evidente che dal punto di vista del significato non c’è nessuna differenza, però una cosa è “sempre caro mi fu quest’ermo colle” e un conto è affermare “mi è sempre piaciuta questa collina solitaria”. Nel primo verso incomincia a esserci un fatto di auroralità (o di zenit) poetico, nel secondo esempio c’è semplicemente la comunicazione realistica, oggettiva, di un contenuto veicolato ad ascoltatori.
In che cosa consiste l’orchestralità? Quando vedete un attore orientale che danza o che recita, se avete la possibilità di guardarlo con attenzione (“spectare”), siete colpiti dalla difficoltà di mettere a fuoco lo sguardo su una parte specifica del suo corpo. Avete visto passare sullo schermo del documento Rai un personaggio femminile e un personaggio maschile e già in queste veloci apparizioni voi avete avuto la percezione del fatto che da quegli attori si dipartono nello stesso momento tutta una serie di stimoli. La metafora che usiamo è quella di “corpo orchestra”, nel senso che in un’orchestra possono suonare tutti gli strumenti, ovviamente, ma all’interno della complessità del suono orchestrale possono entrarne, in un momento dato, solamente alcuni: possono esserci un oboe, un flauto e un timpano, possono suonare solamente sezioni di archi o di ottoni o singoli strumenti, magari con note differenti, per esempio: e il fatto che suoni qualcuno non significa, ben inteso, che suoni anche qualcun altro. Esattamente l’opposto delle percezioni che voi avete normalmente in un’esperienza della media di un teatro classico occidentale.
Questo che ora state vedendo è un massaggio: le immagini sono il riversamento di un filmino in otto millimetri girato in India nei primi anni Ottanta, all’interno di un kaḷari, cioè di una palestrina molto scura (in India c’è molto sole, come sapete, quindi tutti tendono a difendersi dal sole, ecco perché dove lavorano è piuttosto buio). La macchia scura che vedete è un maestro che si sta appoggiando a una sbarra trasversale di legno: da questa posizione può massaggiare con la pianta dei piedi un giovane allievo (lo intravedete al suolo, disteso su una stuoia) dopo averne cosparso il corpo con olio medicamentoso (questo permette ai piedi di scivolare naturalmente sul corpo).
C’è una sorta di peso progressivo che il maestro può esercitare sulle membra dell’allievo, sostenendosi appunto alla sbarra citata. Occorre molta esperienza sorvegliata perché questo tipo di pratica è molto pericolosa. Il massaggio serve a far sì che anche il corpo dell’allievo, anatomicamente parlando, assuma sempre di più le caratteristiche che gli permetteranno di entrare all’interno dell’architettura scenica del teatro Kathakali. Osservate: il bambino a un certo momento viene messo supino con ciambelle di tela piena sotto le anche, sotto i fianchi, in maniera che le ginocchia, divaricate e flesse, restino sospese a qualche decimetro dal suolo. È giusto allora che premendo su cosce e polpacci, facendo avvicinare le ginocchia sempre di più al terreno, quindi piegando in qualche modo tutta la struttura della gamba verso l’esterno, il massaggio fa assumere all’allievo, con l’andar del tempo, le ginocchia aperte che gli permettono di avere la sua famosa caratteristica stilistica (di occupazione dello spazio. Lo spazio dell’attore, come è noto, risulta individuato da alcuni punti, fra i quali vanno sicuramente menzionati gomiti e ginocchia: è il controllo di questi elementi che aiuta l’attore a costruire la sua “presenza scenica”. Se egli, per così dire, non usa sufficientemente gomiti e ginocchia, non riempie abbastanza lo spazio: vedete nel filmato che l’attore tende a ruotare le ginocchia verso l’esterno, in maniera che l’apertura dell’inguine e quella delle ginocchia sia la più grande possibile. Questo permette poi all’attore [si lavora sui millimetri naturalmente] di avere la presenza scenica che è necessaria negli spettacoli Kathakali).
Lo stesso tipo di ampiezza artificiale (perché si tratta di mostrarsi, alla lettera, di essere in stato di rappresentazione, per l’appunto), lo stesso tipo di dilatazione viene applicata al trucco. Ora vedremo una scena con gli attori della troupe del Kalamandalam, cioè della più grande scuola governativa del Kerala, lo stato dell’India in cui il Kathakali è nato, che si stanno truccando: siamo in un teatro italiano in cui avevamo invitato la troupe che ora si accinge a entrare in scena. Qui possiamo invece fermare il film e vedere alcune fotografie.
Parlavo del corpo orchestra per dire che lo stesso tipo di logica presiede a qualsiasi componente scenica del teatro Kathakali, inclusa naturalmente quella di cui ci dobbiamo occupare adesso, che è il trucco.
Il trucco è una delle quattro parti di quello che gli indiani chiamano abhinaya. Abhinaya è una parola composta: vi troviamo una radice sanscrita, “ni”, che significa “portare” e “abhi”, “verso”. L’abhinaya è un elemento scenico “che porta verso”. Si tratta di qualche cosa fatta per essere convogliata verso il pubblico, perché è a questo che bisogna farla conoscere: cioè è esplicita la sua natura di consapevolezza artistica, di artificialità. E che cosa bisogna far conoscere? Le caratteristiche dei protagonisti delle scene del teatro Kathakali.
Il teatro Kathakali, come è noto, è un teatro molto aristocratico, non si occupa che marginalmente di cose umane, si interessa essenzialmente di vicende di dèi o al massimo di semidei o eroi (alcuni personaggi delle pièce di Kathakali con caratteristiche più o meno quotidiane [un operaio, perfino un cacciatore, da un certo punto di vista] sono visti come personaggi grotteschi e il trucco, il maquillage che li contraddistingue segnala il punto di vista dello spettatore aristocratico).
Tornando adesso al nostro filmato: il personaggio che ora vediamo è Hanūmān, cioè il dio-scimmia, la scimmia bianca, che è caratterizzato da un copricapo che per qualcuno è di ascendenza portoghese (una specie di furto omaggio culturale fatto dagli indiani nei confronti degli invasori portoghesi nel Cinquecento), ma questo non si sa se sia vero.
In realtà esso è però organizzato con una sua semplicità, per mettere in evidenza, invece, il volto. Il volto evoca le fattezze di una scimmia, ma lo fa attraverso elementi stilistici di base che ritroviamo anche negli altri ruoli.
È estremamente importante fare riferimento al fatto che il trucco del Kathakali in ogni caso non è una bella statuina: è un trucco creato in pieno accordo con gli altri abhinaya di cui vi parlavo, cioè delle altre tecniche di comunicazione scenica o di ostensione, di messa in situazione di rappresentazione.
Nella tradizione classica del teatro-danza indiano ci sono quattro differenti categorie maggiori di abhinaya: una riguarda il corpo (āṅgika), l’altra riguarda l’uso della voce (vācika), una terza riguarda per l’appunto il trucco (āhārya), di cui ci stiamo occupando, e l’ultima riguarda la parte cosiddetta interiore (sāttvika: che detiene, in qualche modo, una sua specificità).
Si tratta di un lavoro negli interstizi, estremamente ricco e affascinante, su cui non possiamo fermarci adesso. Esso è però strettamente collegato con il resto. Il fatto che non siano belle statuine significa che tutto è organizzato, in questo volto. Lo vedete: vi troviamo connessioni coi tre cerchi della corona lignea e la sua cuspide, la grande gonna a fior di loto rovesciato, le lunghe sciarpe chiuse dal tessuto organizzato in petali (col calice raccolto sullo specchio che ne costituisce la base). Gli occhi sono estremamente sottolineati; in alto, al centro della fronte, vedete una vasta macchia gialla col profilo della lettera “V” di Viṣṇu, segno di appartenenza religiosa, che include ulteriori simboli grafici rituali. Gli occhi hanno caratteristiche in un certo senso femminili: secondo la cosmetica indiana, l’occhio è tanto più bello quanto più la sua forma è ovale (il riferimento esplicito è la forma del pesce). Il volto, come vedete, è verde, cioè, come si dice nella lingua del Kerala, è un paccha (si pronuncia “pàccia”). I paccha sono tutti eroi e il loro volto è verde. Il pigmento è composto da una pietra gialla triturata e polverizzata e poi mescolata con un’altra pietra che invece è blu. Le due pietre vengono pestate in un apposito mortaio, il miscuglio viene gonfiato con pasta di zinco e pasta di riso (che non dà colore). Qualche volta si mescola con una sorta di colla solidificata, una specie di pietra anche questa, le cui scaglie conferiscono al verde la lucentezza necessaria: alla fine il tutto viene impastato con olio di cocco e spalmato sulle parti convenienti del viso.
Quando vengono in Italia, gli attori indiani, che non si portano dietro l’olio di cocco, usano l’olio di mais (lo testimonio in omaggio alla materialità del teatro che tanto piace a Nicola Savarese). Ai lati delle guance viene messo questa sorta di protesi che si chiama chuṭṭi: sono fascette, perpendicolari alle guance, alte una decina di centimetri, che vengono fatte così: si stende in primo luogo una striscia di colla, poi si mette un corrispondente strato di calce, vi si colloca una garza sottile di cotone e su questa a poco a poco si mettono (o almeno nella tradizione era così) delle quote progressive di una sorta di colla mescolata con calce finché queste fasce crescono su se stesse. Si lasciano asciugare e sull’orlo della prima, che è alta due-tre centimetri, si comincia a innestare la seconda: questo spiega perché il trucco del Kathakali duri un tempo che va da un minimo di due ore per quelli più semplici a quattro o perfino cinque ore per i più complessi. Qui siamo all’interno di un trucco medio, dura più o meno due ore e mezzo (quello dal vivo che vedrete alla fine di questa sessione è un poco più ricco, è un katti e complica questo elemento di fondo con un altro tipo di intervento).
Le labbra sono rosse corallo (esistono diversi tipi di rosso): queste labbra sono rosse corallo perché il grande sentimento di riferimento di questo paccha, di questo eroe positivo, è l’amore (śṛṅgāra rasa: il rasa è una categoria estetica legata a un sentimento. Gli indiani indicano in nove [i celebri navarasa appunto] gli spicchi in cui è possibile suddividere la sfera della psiche umana: ulteriori sottodivisioni e combinazioni o mescolanze rendono infinite le sfumature componibili).Vedete che ai lati delle labbra, sull’angolo, c’è una specie di bollo circolare rosso che fa sì che il volto, in ogni caso, abbia una specie di sorriso perpetuo. A questi personaggi paccha è vietato aprire la bocca: non possono mai dischiudere, con le labbra, l’oscuro, il buio terrorizzante e drammatico della parte che sta oltre l’omerica chiostra dei denti. Ovviamente questi personaggi sono muti, non possono parlare (aprirebbero la bocca!).
A questo punto del filmato l’attore sta amoreggiando (a proposito, questo è Gopi, uno dei più grandi attori contemporanei di Kathakali), poi lo vediamo mentre beve: questo ci permette di porre l’attenzione su un’altra parte del volto dell’attore Kathakali che sono gli occhi. L’attore sta bevendo (in questo momento interpreta un leone). Sta bevendo il sangue di un elefante che ha appena ucciso: “beve” con gli occhi, quindi sono gli occhi che attraverso tutta una serie di movimenti, come vedete, inghiottono il sangue e lo deglutiscono. Noi vediamo attraverso gli occhi la deglutizione del sangue che l’attore sta bevendo, del sangue dell’elefante (simbolo dell’essere umano) che ha appena ferito e che mette a morte.
È estremamente rilevante lo scopo del trucco dell’attore Kathakali. Questo trucco tende a fare sparire completamente l’individualità dell’attore dietro la proiezione metafisica di un suo personaggio. Non esiste l’attore, esiste il personaggio. Questa è l’esperienza affascinante del Kathakali: è successo, nella pratica del galateo teatrale di noi vecchi cresciuti con l’Odin Teatret, di andare a ringraziare gli attori dopo lo spettacolo. Spessissimo c’è un salto, alla lettera, di livello di percezione visiva che tutte le volte mi stupisce: vado di corsa nella green room, nella sala del trucco dove l’attore esce alla fine dello spettacolo. La sensazione è di tenere sempre lo sguardo da un metro e settanta in su per guardarlo come in spettacolo, ma poi mi ritrovo spesso un attore mingherlino, seduto per terra, struccato, che ti guarda curioso e smarrito, con un sorriso timido. Sembra la Cenerentola ma è lui, era proprio lui, il grande Bhīma, il terribile Rāvana. Era lui che, quando compariva in scena, ci intimoriva come bambini piccoli, sperando che non succedesse niente, che non ci incenerisse attraverso lo sguardo. A fine spettacolo il personaggio sparisce e ti ritrovi l’attore: è un esserino minuscolo, indifeso, che ti guarda stupito perché tu arrivi pieno di entusiasmo ad abbracciare un’ombra che lui ha abitato, ma che non era lui stesso. Di questo “equivoco” egli è in qualche modo cosciente e questa obliterazione totale, questo consapevole cancellamento dell’individualità dell’attore è probabilmente la lezione etica più grande che ci consegna il teatro orientale.
Vorrei fare riferimento ancora una volta agli occhi, per concludere. Prima rivedevo il vecchio film e sorridevo. Mi dicevo: “Cancellano tutto, però gli occhi non si cancellano”. La risposta è semplice: “Sì, gli occhi sono quelli dell’individuo, che in essi si rifugia per opporsi alla propria sparizione” (perfino nel Kāmasūtra, nella sezione dei baci, si segnala che si possono dare differenti tipi di morsi, ma non si può mordere l’interno della bocca [è vietato] e non è permesso mordere gli occhi, non sono manipolabili). Ma nel Kathakali, perfino gli occhi vengono modificati: la cornea dell’attore viene colorata di rosso o di rosa attraverso due diversi semi di una pianta locale, che vengono messi sotto le palpebre. (Se l’attore si appresta a interpretare Duryodhana, e cioè il grande eroe nella sua furia passionale distruttiva, la sua cornea sarà rosso acceso, furibonda; se invece fa, come in questo caso, l’attore in amore, allora la sua cornea sarà dolcemente colorata di rosa, perché il seme che viene messo all’interno della palpebra, invece, colora la cornea solo di rosa).
Questa sparizione dell’individuo dietro il suo doppio ideale è la grande lezione del Kathakali.
Renzo Vescovi
Leggi anche: Perché L’India